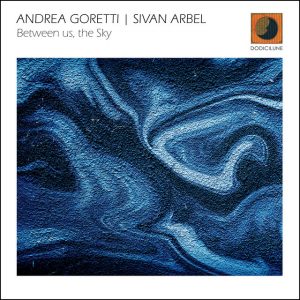Austin Peralta: il genio precoce del jazz, fra tradizione e sperimentazione, morto a soli 22 anni

Il jazz, in fondo, non è mai un semplice genere musicale: è un linguaggio, una filosofia, un modo di esplorare l’ignoto. Il pianista losangelino, attraverso la sua visione dello scibile sonoro, ci ha mostrato inedite possibilità da sondare e ardite dimensioni sonore che ancora oggi continuano a vibrare.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Nel panorama del jazz contemporaneo, pochi artisti hanno saputo lasciare un segno così forte in così poco tempo come Austin Peralta. Enfant prodige con l’attitudine a muoversi tra le armonie del jazz più tradizionale e le contaminazioni elettroniche più moderne, Peralta ha avuto una carriera breve ma intensa, riuscendo a ridefinire il linguaggio pianistico con una sensibilità unica, profondamente influenzato da alcuni maestri del jazz: Chick Corea, da cui traeva ispirazione per il suo approccio sperimentale; Herbie Hancock, per il magistrale uso dell’armonia e della costruzione melodica; Bill Evans, il cui lirismo e la cui introspezione scandiscono i momenti più intensi delle composizioni del giovane pianista californiano. Musicista poliedrico e dal talento precoce, Austin ha vissuto intensamente i suoi 22 anni, regalando al mondo composizioni profonde e interpretazioni che tradivano una maturità musicale ben superiore alla sua età.
Nato a Los Angeles nel 1990, figlio di Stacy Peralta – leggenda dello skateboarding e regista – Austin evidenziò, fin da piccolo, un’abilità fuori dal comune. A cinque anni già sedeva al pianoforte con la naturalezza di un consumato esecutore, tanto da pubblicare i primi due album non ancora ventenne. Peralta non si limitava al jazz tradizionale, ma amava immergersi nelle nuove frontiere della musica, collaborando con vari artisti e formazioni legate alle avanguardie: con Flying Lotus, si è avvicinato al sound elettronico e sperimentale; con Thundercat ha esplorato i ritmi più audaci e sconosciuti; con Erykah Badu ha travasato il jazz nell’universo hip-hop e neo-soul; con Teebs, ha elaborato incroci tra jazz e beat elettronici; con The Cinematic Orchestra ha sperimentato atmosfere più raffinate ed orchestrali. Austin non era un pianista che si accontentava di muoversi nei confini del jazz: cercava sempre di oltrepassarli. Nel novembre 2012, la luce intorno a lui si è spenta improvvisamente. La sua morte prematura – a causa di una polmonite virale aggravata da una combinazione letale di alcol e droghe – ha lasciato un vuoto incolmabile. Tuttavia, la sua eredità è rimasta intatta: i suoi dischi continuano ad ispirare giovani musicisti e appassionati a vario livello; soprattutto la sua breve ma intensa parabola artistica è celebrata come quella di un genio che, sebbene vissuto troppo poco, ma capace imprimere un’impronta indelebile nella storia del jazz contemporaneo.
Registrato nel 2005 presso gli Avatar Studios di New York, uno dei luoghi sacri della musica jazz di quegli anni, «Maiden Voyage» fu un prova inconfutabile della straordinaria maturità esecutiva di Peralta, che all’epoca aveva appena 15 anni. Nonostante la giovane età, il pianista dimostrò una padronanza tecnica impressionante, un raffinato senso dell’armonia e una sensibilità espressiva che lo ponevano in dialogo diretto con due nomi di prestigio: Ron Carter al contrabbasso icona del jazz moderno, e Billy Kilson alla batteria, noto per la versatilità e la capacità di adattarsi a diversi contesti sonori. Questa formazione, tutt’altro che convenzionale per un debutto così precoce, garantì un interplay di altissimo livello, elevando il progetto ben oltre le aspettative di un disco d’esordio. Ciò che rende «Maiden Voyage» un lavoro degno di nota non è soltanto la qualità tecnica dell’esecuzione, ma anche la scelta di un repertorio che spazia tra riconoscibili standard jazz e composizioni originali. Il giovanissimo pianista dimostrò una capacità interpretativa non comune, muovendosi agilmente tra composizioni simbolo della tradizione popolare e momenti di autentica libertà espressiva.
L’uscita di «Mantra» nel 2006 suscitò un certo fermento all’interno della critica. Non si trattava semplicemente di un nuovo album da aggiungere al vasto panorama discografico del genere, ma di un’opera che metteva in discussione il concetto stesso di maturità artistica. Austin Peralta, appena sedicenne al momento della registrazione, si presentava al pubblico con una maestria pianistica e una visione musicale che sfidavano ogni pronostico. I più autorevoli critici colsero immediatamente l’anomalia: un ragazzo ancora immerso nella sua adolescenza si confrontava senza timore con musicisti navigati come Buster Williams, una vera e propria istituzione del contrabbasso, e Marcus Strickland, sassofonista già affermato per via di una ricerca timbrica sofisticata. «Mantra» non era un esperimento giovanile, un tentativo ingenuo di inserirsi nel grande albero genealogico del jazz moderno, ma una dichiarazione d’intenti ben strutturata, che mostrava un talento precoce predisposto ad articolare linguaggi complessi con estrema naturalezza. Non era difficile individuare e sottolineare le influenze stilistiche che permeavano il pianismo di Peralta. Herbie Hancock, in primis, fu il riferimento più citato: la fluida dinamicità degli accordi, l’uso di progressioni armoniche sofisticate e l’approccio percussivo alla tastiera ricordavano il periodo d’oro del Hancock anni ’70. Al tempo stesso, alcuni recensori ritennero che il fraseggio e la costruzione melodica di Peralta tradissero un’inclinazione evansiana, figlia di quel lirismo sottile e intimista di Bill Evans, soprattutto nei passaggi più meditativi dell’album. Ciò che più colpì fu l’intensità espressiva dell’album. «Mantra» non si limitava ad essere un esercizio di virtuosismo, ma cercava di trasmettere una narrazione sonora coerente e ben articolata. Yasohachi «88» Itoh, produttore e figura chiave nella scena jazz giapponese, fu determinante nel garantire una qualità sonora che valorizzasse al meglio ogni sfumatura dell’interplay fra i musicisti. La registrazione, effettuata presso gli Avatar Studios di New York, preservava la spontaneità e il carattere improvvisativo di un jazz contrassegnato da architetture armoniche che sembravano dialogare fra loro in un continuo scambio di dinamiche ed ambientazioni.
«Endless Planets», pubblicato nel 2011 su doppio vinile, per l’etichetta Brainfeeder, rappresenta il culmine del suo percorso musicale: un album che mescola tradizione e avanguardia in un equilibrio perfetto. L’idea dell’album nasce dalla volontà di Peralta di creare qualcosa che fosse profondamente radicato nel jazz ma aperto a nuove contaminazioni. Il giovane pianista aveva assorbito il vernacolo tradizionale e lo aveva trasformato in un’espressione personale, in grado di dialogare con la musica elettronica e le soluzioni più cinematiche. Quando Flying Lotus, fondatore dell’etichetta Brainfeeder e figura chiave della scena elettronica californiana, notò il talento di Peralta, capì subito che il suo stile si sarebbe integrato perfettamente con la filosofia del collettivo. La registrazione dell’album si svolse in due sessioni separate: la prima presso i Drum Channel Studios di Oxnard in California, un ambiente perfetto per catturare la spontaneità dell’improvvisazione jazzistica, e la seconda presso il W Studios di Brooklyn a New York, dove furono aggiunte le ultime tracce e gli elementi più sperimentali. Austin era ossessionato dalla qualità sonora: ogni nota, ogni atmosfera doveva riflettere la sua visione artistica. Ascoltare «Endless Planets» significa immergersi in un flusso di suoni che sfidano le categorizzazioni. C’è il lirismo del jazz acustico, la profondità dell’elettronica, le strutture armoniche complesse ed un uso della ritmica che rompe gli schemi convenzionali. Peralta non voleva semplicemente «suonare il jazz», intendeva reinventarlo, spingendolo verso nuove direzioni. Lo dimostra la varietà stilistica delle tracce: da composizioni che richiamano la scuola modale di Miles Davis a brani che flirtano con la psichedelia elettronica. In questo processo, il pianista si circondò di musicisti affini. Ben Wendel, al sax tenore e soprano, portò un’interazione dinamica che si intrecciava con il pianoforte, mentre Hamilton Price al basso e Zach Harmon alla batteria promulgarono una base ritmica elasticizzata, perfetta per le perlustrazioni del pianista-leader. In alcuni frangenti, l’album appare come una reiterata conversazione strumentale, un dialogo in cui ogni musicista porta qualcosa di unico.
«Introduction: The Lotus Flower» è una sorta di preludio etereo, dominato dal sax soprano di Ben Wendel e da ambientazioni sospese. La progressione armonica è costruita su accordi modali, che emanano un senso di apertura e di ariosità. In «Capricornus» il groove si fa più incisivo, con un tema serpentino che richiama le influenze di Hiromi Uehara. Il pianoforte di Peralta è agile e dinamico, mentre la sezione ritmica, guidata da Hamilton Price (basso) e Zach Harmon (batteria), mantiene un drive costante. «The Underwater Mountain Odyssey» evoca immagini cinematografiche, con un interplay tra sax alto (Zane Musa) e sax tenore (Ben Wendel) che si s’interfaccia con le linee del pianoforte. La struttura è quasi discorsiva, con sezioni che si alternano tra momenti di tensione e distensione. In «Ode To Love» il pianista dispensa un lirismo più marcato, con un tema delicato eseguito al sax soprano da Ben Wendel. L’uso del Fender Rhodes aggiunge una singolare morbidezza, mentre la batteria opera su pattern sincopati che danno profondità al brano. «Interlude» è una camera di decompressione, una breve pausa sonora, quasi un respiro fra le tracce più strutturate. Qui emergono le influenze elettroniche, con manipolazioni sonore sottili curate da Strangeloop, che aggiunge texture astratte. «Algiers» introduce elementi percussivi inediti, con l’uso della tabla suonata da Zach Harmon. La fusione tra jazz e ritmi nordafricani crea un’atmosfera ipnotica, con il pianoforte che si muove tra scale modali e improvvisazioni libere. «Epilogue: Renaissance Bubbles» suggella l’album con un ritorno alle situazioni più rarefatte, dove il Fender Rhodes di Austin battibecca con le manipolazioni elettroniche della Cinematic Orchestra e la voce eterea di Heidi Vogel. Un finale sospeso, che lascia spazio alla riflessione e alla suggestione.
La prematura scomparsa di Austin Peralta ha privato il mondo della musica di un artista destinato a ridefinire i canoni del jazz moderno. Tuttavia, «Endless Planets» rimane il lascito sonoro della sua genialità, un ambizioso concept che continua a influenzare generazioni di succedanei, tanto che, nel corso degli anni, il disco è stato riscoperto da artisti ed appassionati, diventando un autentico cult. Oggi, ascoltare «Endless Planets» significa entrare nell’universo di Peralta, seguire il percorso di un jazzista che, pur avendo vissuto troppo poco, ha lasciato un’eredità indelebile nella storia della musica contemporanea. Perché il jazz, in fondo, non è mai un semplice genere musicale: è un linguaggio, una filosofia, un modo di esplorare l’ignoto. Il pianista losangelino, attraverso la sua visione dello scibile sonoro, ci ha mostrato inedite possibilità da sondare e ardite dimensioni sonore che ancora oggi continuano a vibrare.