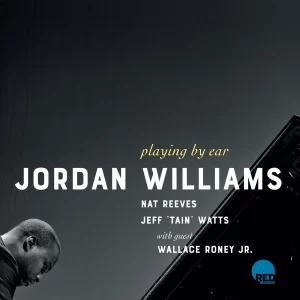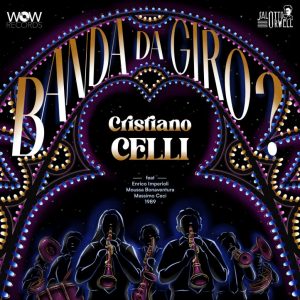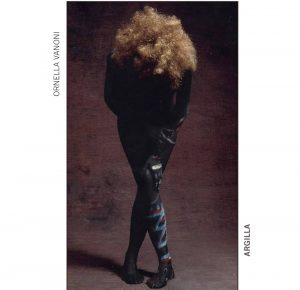Max Pizio: «Anche nelle dinamiche famigliari, si plasmavano per me curiosità e sperimentazione sonora»

Max Pizio
// di Guido Michelone //
D Con tre aggettivi come si definirebbe?
R Curioso, Impulsivo, Visionario
D Si ricorda la prima volta che ha ascoltato musica?
R Ricordo qualche tempo fa, i miei genitori mi ricordavano che all’età di 3 anni, grazie anche a delle registrazioni casalinghe su musicassetta da loro effettuate ancora con i mitici “stereo” anni ‘80, e dalle rimembranze: “ti dimenavi nel lettino con il mambo di Perez Prado, cercando di imitare le melodie di Mambo N. 5 o i riff di fiati di Patricia… con la testa cercavi di imitare i ritmi incalzanti dei fiati e della batteria…”. Effettivamente il primo ricordo vivido di ascolto della musica risale all’età di 6 anni, con mio padre che mi introdusse ai vinili di un “Daphnis et Chloe” o “La Valse”, di M. Ravel. Ricordo quella prima esperienza sonora come piacevolmente sconvolgente. In realtà la vicinanza ai suoni è sempre stata presente fin dalla tenera età, con mio padre musicista e insegnante di musica, e da una nutrita famiglia di parenti artisti.
D Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a diventare musicista? Quando nascono? In che ambienti?
R Quando si nasce praticamente in un ambiente quasi totalmente permeato dalle attività musicali, con tanto di svariati locali in casa, pieni di storia sonora (nonna percussionista, nonno pianista ceco, zio didatta ed editore musicale, partiture, strumenti di ogni tipo dalle tastiere, clarinetti, flauti, sassofoni, contrabbassi), è quasi impossibile rimanerne indifferenti. Anche nelle dinamiche famigliari, si plasmavano per me curiosità e sperimentazione sonora. Quando mio papà partiva per qualche Gig, con i suoi gruppi di musica da ballo o qualche sessione di Jazz, non vedevo l’ora di seguirlo e il far tardi la notte al ritorno, e nel frattempo memorizzavo stili diversi, repertori completamente differenti. E solo dopo qualche lezione sempre con mio padre al pianoforte e organo (tipo Farfisa), a 8 anni scoprii un sax soprano appartenuto allo “zio Sandro” (Alessandro Traversi, casa musicale Bellinzona). Senza nessuna pressione famigliare, e da parte di mio papà qualche “lezione”, iniziai inconsapevolmente un approccio da autodidatta, fino all’entrata in Conservatorio. Così all’età di 12-14 anni dirigevo il coro della chiesa del paese e suonando nelle ricorrenze, feste paesane, intrattenimenti nei ristoranti e carnevali, più tardi. Effettivamente non sono mai stato “spinto” da nessuno di loro e la scelta della vita musicale fu data più che altro da un aspetto “professionale”, vivendo già quell’ambiente dignitoso, chiaro, trasparente delle “prestazioni musicali” che in famiglia erano una base solida. La passione verso la ricerca, la passione per l’arte, venne compresa molto più tardi dal sottoscritto. Gli ambienti sonori in adolescenza viaggiavano tra il Metal (suonavo il basso elettrico in una cover band dei Metallica), accompagnavo i repertori delle balere dal liscio, alla musica leggera, con le orchestre da ballo alla batteria e sassofono, qualche ammiccamento agli Standard Jazz e i primi incontri con il Clarinetto (classico!), attraverso i corsi preparatori presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano, che all’epoca si chiamava AMSI.
D È d’attualità la riflessione sul ruolo dell’intelligenza artificiale, soprattutto nel settore produttivo, ma la cosa ha pure implicazioni artistiche. Immagino che lei, come compositore e interprete, abbia un suo punto di vista.
R Vivendo nel mio mondo compositivo, ancora con carta e penna, ed essendo cresciuto con strumenti datati, con i primi campionatori per trascrivere gli assoli fulminei e pieni di colori, le sfumature del sassofono o dell’EWI interpretati da Michael Brecker, rallentandone le velocità, loopers di ogni genere e modello, le prime trombe elettroniche di Steiner, e scoprendo solo negli anni ’90 le potenzialità dei software su computer, confesso che il problema sulle AI in campo musicale non mi hanno mai toccato veramente da vicino. Ma negli ultimi anni, disquisendo con produttori discografici, sound engineers e altri compositori, l’argomento mi rimanda ad alcune preoccupazioni sulle finalità e l’utilizzo speculativo di queste tecnologie anche da parte dell’industria musicale. Dal punto di vista storico ho riconosciuto un primo declino “occupazionale” nel settore della musica dal vivo (intrattenimento, musica da ballo), attraverso la comparsa delle prime tastiere “arranger”, “all-man-band”, e le “basi musicali” dalla metà degli anni ’80. All’inizio salutati con entusiasmo dal punto di vista della scoperta di nuovi suoni, compatti anche dal punto di vista “pratico”. Ma vivendo comunque l’atmosfera con orchestre di 6-12 elementi, il confronto non era possibile, sia a livello qualitativo che di fruizione. Questi mezzi, avrebbero dovuto rimanere nell’ambito “privato” e l’utilizzo per ingaggi professionali con remunerazione, disciplinati da regole. Ovviamente attorno a me iniziavo a vedere i primi musicisti disoccupati (soprattutto bassisti e batteristi, i più colpiti), i quali si vedevano sempre più “sostituiti” da macchine, più o meno gestite ancora da umani, senza grandi nozioni musicali. La capacità di sopravvivenza di tali disoccupati era dettata del background musicale e sicuramente dalla capacità di mettersi in discussione, quindi scegliere di non utilizzare questi mezzi oppure, se pur in parte, trovare nuove soluzioni di sopravvivenza: potenziare l’insegnamento, creare nuovi progetti sonori, ricercare nuove tecniche di composizione, re-inventarsi. In poche parole questa è la strada che scelsi, frequentando Berklee School a Boston e aprendo l’etichetta discografica Tetraktys Music Label nel 2005, maturando quindi 12 anni di esperienza in studio di registrazione. Ritornando ai nostri giorni, nel 2025 l’utilizzo delle AI nei vari settori musicali, ha già un impatto molto forte nel settore musicale, vi sono pro e contro, aspetti etici e legali che vanno considerati. L’intelligenza artificiale AI sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel settore musicale, portando con sé sia opportunità che sfide. Le tecnologie AI sono utilizzate per creare, produrre e distribuire musica, influenzando profondamente il modo in cui gli artisti e i produttori lavorano. Uno degli aspetti più interessanti dell’AI nella musica è la sua capacità di “assistere” gli artisti nella creazione di nuove opere sia dal punto di vista formale, testuale, armonico, stilistico di un brano pur non avendo in molti casi, nessuna nozione di composizione. Strumenti come software di generazione musicale e algoritmi che vengono proposti e raccomandati, stanno diventando sempre più comuni. Secondo un recente studio, circa il 25% dei musicisti utilizza strumenti basati sull’AI, principalmente per attività come il mixaggio e la separazione delle tracce. Questi strumenti consentono agli artisti di “risparmiare tempo” e di esplorare nuove sonorità, ampliando le loro possibilità creative. Nonostante i vantaggi, l’uso dell’AI nella musica solleva anche importanti questioni etiche. Molti artisti temono che l’AI possa minacciare la loro integrità artistica e i diritti d’autore. Ad esempio, alcuni musicisti hanno lanciato appelli contro l’uso dell’AI per clonare le loro voci o per creare opere che possano svalutare il lavoro umano, ampiamente giustificati. La questione della paternità delle opere generate dall’AI è complessa: chi è il legittimo autore di una canzone creata da un algoritmo? Queste domande rimangono senza risposta, mentre il settore cerca di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. Guardando al futuro, è chiaro che l’AI continuerà a influenzare il settore musicale. Tuttavia, è fondamentale che artisti, produttori e legislatori collaborino per stabilire normative che proteggano i diritti degli artisti e garantiscano un uso etico delle tecnologie. La musica, come forma d’arte, è intrinsecamente legata all’esperienza umana, e l’AI, per quanto avanzata, non può sostituire il valore delle emozioni e delle storie personali che ogni musicista porta nella propria creazione. Solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo sarà possibile trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto per l’arte e per gli artisti. Personalmente, per quanto riguarda la mia visione nel mondo della composizione, l’AI non è una minaccia: provengo da una generazione dove il mondo creativo è ancora basato tra un equilibrio intrinseco di emozione, ascolto e riconoscimento, e tramite solide basi accademiche. La vedo come un’opportunità tecnologica per la ricerca e la creazione di nuovi universi sonori. E’ innegabile che l’impatto negativo nell’ambiente professionale, ed in tutti i settori legati alla produzione dell’industria musicale diventerà sempre più palese, senza omettere l’impatto socio economico e culturale, che l’individualismo creativo, la minor comunicazione, e il minor scambio diretto con e tra musicisti, favorirà un degrado non indifferente, se non verranno applicate delle apposite regolamentazioni di utilizzo. Il problema complesso in tutte le sue sfaccettature rimane comunque l’aspetto di fondo speculativo sui diritti d’autore e il “pubblico dominio”, dove al nocciolo delle questioni si trovano essenzialmente i proprietari (le aziende che gestiscono) e i poteri che vengono conferiti alle AI. Segnalo in merito a questi argomenti la FIMI (Federazione industria musicale italiana) http://www.fimi.it/.
D Lei è appassionato sperimentatore di strumenti musicali non comuni: per certo conosce il Bercandeon (parente stretto della fisarmonica, pensato soprattutto per pianisti e organisti) e Fant (tastiera per quarti di tono), ma so che attualmente si è avvicinato al Glissotar (o Glisotar, nel web ho trovato ambedue le forme). Potrebbe descriverlo e, soprattutto, svelarci le caratteristiche che più le piacciono?
R Certamente il Bercandeon è il frutto della mente geniale e creativa di Fiorenzo Bernasconi, che ho avuto modo di conoscere come “il mio maestro di italiano alla Scuola di Commercio”. Anche se sono passati decenni i nostri incontri sparsi ci hanno portato sempre alla costruzione, creazione e supporto reciproci di qualche progetto visionario. Nella collezione di strumenti sperimentali, il Bercandeon resta ancora un posto nei sogni, e nella possibilità di provare questo strumento (spero presto). Per ora ho sotto mano “The Magic Bercandeon” dalla collana di Fiorenzo Bernasconi “Doremidolare. Strumenti per fare 4”, nel quale posso almeno “leggere” le composizioni originali dello strumento, scaturite da diversi artisti di mia conoscenza. Per quanto riguarda invece il Fant (tastiera a quarti di tono), ho l’onore di utilizzarne una versione donatami in uso dallo stesso inventore, e dopo averlo Installato all’Auditorio Stelio Molo RSI per le registrazioni del triplo album in co-produzione RSI RETE DUE “Specular Intersections” Scarkiss Ensemble Day #1#2#3 (ed. Tetraktys Music 2023) con le tecniche di composizione intersezioniste (F. Bernasconi, “Manifesto dell’intersezionismo speculare” edizioninuovaprhomos), ho avuto modo di rispolverarlo attraverso un gioco da tavolo chiamato “Dodici Ismi”. Quest’ultimo si propone come un mezzo di “composizione guidata”, simile al gioco dell’oca, con tanto di dadi a 12 facce. Esiste anche nelle versioni in 6, 7 e 24 microtoni. Attraverso una serie di lanci e un percorso con delle pedine, senza vincitori ne vinti, si costruisce una sequenza microtonale riplasmabile, armonizzabile e ritmabile, a propria discrezione. (tratto da Dodici Ismi https://www.facebook.com/groups/2605835112938968). Il Glissotàr (o Glisotàr) è stato un po’ il coronamento di un sogno che maturai nel 2005, durante la registrazione dell’album TWO DICE “Alea” (ed. Tetraktys Music 2005). In quel periodo componevo utilizzando il simbolismo del numero 8, ed ero alla ricerca di un Taragot, clarinetto conico di origine ungherese. Purtroppo non lo trovai per tempo e le registrazioni si conclusero con l’ausilio di un clarinetto contrabbasso. Così dopo quasi un ventennio, mi sono imbattuto nel Glissotàr (Glis-Tàr), strumento ispirato ampiamente al Taragot, un progetto innovativo dell’azienda ungherese Glissònic, ed il suo inventore Dàniel Vàczi, il quale passava giusto in vacanza con la famiglia, proprio dalle mie parti e mi ha portato personalmente, spiegandomi le basi del funzionamento, questo incredibile strumento a fiato in legno di amaranto (un custom made). Non avendo una meccanica, a parte i due porta-voci, è dotato di una fessura su gran parte della colonna d’aria fino alla giunzione con la campana, la quale viene seguita da uno speciale elastico magnetico leggermente sospeso e tendibile manualmente. Appoggiando le dita, come in una diteggiatura di un clarinetto, sassofono l’elastico chiude la colonna d’aria con la particolarità simile alla manicatura di uno strumento ad arco, agendo all’inverso. Più premo verso la base della campana, più i suoni diventano gravi e viceversa. Ne consegue che la costruzione dell’intonazione e dell’esecuzione micro tonale è facilitata proprio da questo poter “scorrere” con le dita, “glissare” con la totale libertà della colonna d’aria. Lo strumento è in Do, facilmente accordabile dai 430Hz fino a 444Hz, utilizzando una comune imboccatura da sax soprano, il timbro che ne consegue è molto ampio e differenziabile, simile al Taragot, vicino al clarinetto turco e al sax soprano. La gestione di circa 2 ottave e mezzo è praticabile senza indugio. La sfida è sicuramente quella di emettere con questo strumento “nuovi” tipi di intonazioni (scientifica, aurea, naturale), avendo la possibilità di muoversi nel temperamento mesotonico. Nonostante l’elaborazione e il riconoscimento di tali intonazioni, lo strumento resta agile e utilizzando anche posizioni convenzionali in rapporto alla chiusura/apertura della colonna d’aria, si possono ottenere articolazioni simili al sassofono, cromatismi chiari. Se dovessi paragonarlo ad un altro strumento potrei pensare ad una chitarra fretless. Con questo strumento ho potuto registrare alcune sequenze per Acqua-Il Musical e sperimentare dei raga indiani, o alcune tipologie di scale (Kurdistan) usate o nel Maqam arabo.
D La Società Italiana di Musica Contemporanea ha caldeggiato il suo ingresso, assieme a un altro importante compositore svizzero: Francesco Hoch. Che cosa si aspetta da questa proposta?
Questo ingresso, che devo riconoscere mi ha sorpreso non poco, è una ricca opportunità per entrare in contatto con una realtà creativa molto ampia nel numero e forte a livello qualitativo. Purtroppo in Svizzera, l’ambiente della Musica Contemporanea è ancora molto influenzato dalle entità culturali molto frammentate sul nostro territorio, e in alcuni casi, appannaggio di pochissimi compositori che godono di un sostegno o che in un qualche modo sono coadiuvati dai Conservatori. I compositori “freelance” che non fanno parte di alcune di queste cerchie hanno la tendenza poi ad “isolarsi” ed evitare gli interscambi. E’ anche vero che le dinamiche che si instaurano nelle regioni provinciali, a volte precludono lo sviluppo di un certo tipo di ricerca che influenza poi anche l’universo della composizione. Questo invito è di grande motivazione per svolgere e continuare l’attività di composizione in un dominio che mi ha sempre intrigato ed incuriosito. La storia della SIMC ed i suoi illustri fondatori, coadiuvata dall’immagine di un compositore fondamentale come F. Hoch, è ancora più motivante, e sicuramente nel futuro prossimo porterà a nuove collaborazioni e scritture.
D Lei declina il nome “musica” in molti modi, tra i quali c’è l’ambito terapeutico. Mi parlerebbe delle esperienze in corso?
Un bellissimo progetto nato quattro anni or sono, grazie all’interazione con il Dr. Ruggieri, geriatra e Primario presso la Clinica Hildebrand in Svizzera, e che comprendeva la messa in discussione della possibilità di recupero cognitivo di mio padre, all’età di 89 anni. Stava perdendo un po’ motivazione ed interesse nel suonare, nell’interagire anche a causa della perdita progressiva dell’udito, con il conseguente declino generale. Si pensava all’inizio di stimolarlo ad un’attività sonora e di “risveglio” della memoria sonora e quindi portare dei benefici generali e ad un miglioramento generale della qualità di vita. Visto che il paziente era mio papà, e che era stato in contatto con la musica fino alla sua dipartita, il caso era particolarmente delicato. Dopo alcuni mesi di “somministrazione” di vecchie canzoni, ascolto, vecchie partiture di sua lettura, ha ripreso fiducia grazie al “risveglio” delle reminiscenze, il ricordo delle posizioni assunte sul proprio sassofono, e la fisarmonica, l’hanno aiutato a “ricollegare” in un qualche modo le memorie e i ricordi, tanto che è riuscito ad intrattenere musicalmente un incontro con gli utenti e i parenti di un centro anziani che frequentava più o meno regolarmente. Dopo questo evidente “successo” abbiamo pensato di proporre presso un Centro Diurno Terapeutico (Pro Senectute), questo progetto. Ovviamente la mediazione e le considerazioni a livello medico ci hanno consentito di tracciare e costruire un progetto pilota, che abbiamo poi riassunto come una “somministrazione di informazioni”, ad un gruppo di pazienti compromessi e l’abbiamo chiamato “Ti suono una vecchia canzone…”.Tra il razionale terapeutico e riabilitativo di un incontro musicale, improvviso temi di vecchie canzoni, sfoglio partiture, utilizzando un vetusto giradischi, coinvolgendo i pazienti. Nella persona malata di demenza, le progressive difficoltà nell’essere compresi possono generare un frustrante senso di insuperabile e scorante isolamento relazionale con il proprio ambiente socio-famigliare. I soggetti affetti non sono completamente in grado di comunicare i loro bisogni fondamentali e per questo e loro malgrado, divenire vittime, del relativo impoverimento psicosensoriale che finisce per intrattenere l’isolamento sociale. Attraverso l’ascolto musicale possiamo sentire riaffiorare alla coscienza emozioni profonde e con esse anche un senso di identità e di appartenenza all’ambiente. Questi intrinseci e specifici effetti dell’ascolto possono venir dati come definitivamente e irrimediabilmente perduti per i malati con demenza avanzata. Eppure, come accade nei soggetti “sani” e psico-sensorialmente integri, il riascolto in gruppo di sonorità o melodie note e di successo può fare da naturale sottofondo sonoro per rievocare insieme episodi legati alle memorie giovanili. La rimemorazione che ne consegue può anche contribuire a risvegliate capacità abbandonate o assopite nel profondo della nostra memoria esperienziale. Al “catalogo” dei metodi che ricadono sotto il termine musicoterapia si può oggi ricorrere per trattare con intento terapeutico persone di tutte le età e patologie. Negli ultimi decenni sono stati promossi approcci complementari utili anche nei soggetti anziani affetti da demenza ad uno stadio avanzato della patologia che per conseguenza, hanno perso una parte o l’interezza della capacità comunicativa verbale (afasia). Per questi pazienti l’ascolto musicale può rappresentare il mezzo ausiliario transizionale immediato per aggirare le difficoltà comunicative. Intesa in senso terapeutico relazionale, la stimolazione emotivamente coinvolgente effettuata attraverso l’approccio musicoterapico può anche promuovere la comunicazione tra terapisti e utenti malati come anche tra utenti stessi. È stato sperimentato, che l’ascolto musicale è in grado di veicolare sensibili effetti positivi, sebbene temporanei, sull’umore, sulla vigilanza e persino su parametri fisiologici vitali come pressione arteriosa e respirazione. Le tracce mnestiche relative delle melodie che abbiamo ascoltato e/o appreso durante le nostre singolari biografie continuano a risiedere “silenziosamente” nel catalogo musicale archiviato dal sistema delle memorie individuali. Come è prassi per tutti gli archivi anche nel cervello, il materiale è organizzato per categorie coerenti al fine di facilitare il suo recupero per rinnovate fruizioni a richiesta e a posteriori. L’input sensoriale uditivo prodotto dal riascolto – anche passivo – di una nota, un accordo o un’intera traccia melodica, rappresenta il codice che arriva al cervello: il nostro personale archivista. È esperienza comune, che il riascolto di alcune melodie possa suscitare immediatamente vividi e specifici ricordi. L’attivazione di questa traccia autobiografica ci rimette in contatto con un momento preciso o un’epoca del nostro individuale passato. Anche se “scoloriti”, questi ricordi sono a loro volta il veicolo per “ripresentarci” a noi stessi attraverso quel senso identitario che ci é caro, perché intimo e profondo. È noto, che con la loro progressione sintomatica, tutte le forme di demenza possono complicarsi con disturbi del comportamento. Il loro diverso spettro clinico ha un forte impatto sulla qualità di vita del paziente e rende molto difficile la comunicazione e la convivenza con famigliari e amici. Questi disturbi, definiti nell’insieme «sintomi comportamentali e psicologici della demenza» (SCPD) si “sommano” ai deficit cognitivi già presenti. La loro incidenza aumenta con l’evoluzione storica naturale della malattia . Gli SCPD si possono manifestare sotto forma di apatia, depressione, agitazione, ansietà e irascibilità. Possono anche dar luogo a profondo disorientamento con allontanamenti da casa o dal luogo di cura, aggressività, allucinazioni, deliri o comportamenti sessualmente inappropriati per la perdita dell’inibizione legata alle convenzioni sociali apprese durante lo sviluppo. I sintomi possono fluttuare a tal punto che il malato può passare dall’apatia all’agitazione improvvisa e viceversa. I SCPD sono fra cause principali di ospedalizzazione o di ricovero precoce in istituto. Possono anche portare il personale o i familiari curanti a trascurare i pazienti assumendo atteggiamenti inappropriati fino al ricorso irragionevole. Si tratta di situazioni assistenziali difficili da gestire e tali da provocare sintomi da esaurimento nei parenti-curanti come pure dei professionisti. Ma oggi, sono numerosi gli studi clinici che hanno verificato l’effetto benefico, inteso come riduzione di emozioni contrarie e negative che il malato può evocare attraverso il “suo personale” disturbo comportamentale. Una volta formulata la diagnosi di SCPD, l’etica della cura impone la ricerca e l’applicazione di ogni principio terapeutico che eviti la somministrazione d’emblée di farmaci con effetto psico-sedativo. Negli ultimi tre decenni il “catalogo” delle terapie non farmacologiche alle quali i professionisti possono attingere si è infoltito. Fra i tanti approcci terapeutici non farmacologici, quello che ricorre alla musica occupa un posto storicamente consistente e di riconosciuta rilevanza. Come già asserito più sopra, che il messaggio sensoriale veicolato da uno stimolo o da materiale sonoro possa comunicare non verbalmente immediatamente con il nostro “Sé” è esperienza comune a tutti. Questo effetto è proprietà che può diventare terapeutica, laddove la stessa riesca a suscitare emozioni e a far riaffiorare ricordi psicologicamente gradevoli e benvenuti. Effetti attesi che sono stati osservati e misurati da studi effettuati in tutte le patologie psichiatriche croniche. Più recentemente anche nelle persone affette dai disturbi cognitivi e comportamentali della demenza. Ascoltare, come anche fare musica di persona, può dunque costituire un approccio con valenze terapeutiche per recuperare alla memoria ricordi, emozioni come anche prestazioni cognitive e che possono avere effetti antagonizzanti sull’ inarrestabile perdita di capacità indotta dalla malattia. I benefici attendibili perché già osservati negli studi clinici nei pazienti affetti da demenza, include fra i principali:
- rimemorazione di momenti e emozioni dell’autobiografia personale e del passato collettivo;
- affioramento e rinnovata partecipazione a soggettivi e positivi stati d’animo;
- ritrovamento del senso di appartenenza alla propria vita, a quella famigliare, di amici e dell’ambiente culturale di appartenenza;
- gestione non farmacologica del disagio psico-cognitivo o motorio espresso in primo piano;
- modalità alternativa di promuovere l’interesse e la partecipazione al gruppo quando altri approcci risultano inefficaci;
- promozione del movimento ritmico interiore, della fluidità e forza vocale in subordine laddove il paziente decida di accennare passi di danza anche la rievocazione di vecchi schemi motori appresi; un training motorio anche a basso impatto articolare e cardiovascolare è auspicabile per ragioni salutari a tutte le età. Fondamentalmente e in sintesi, anche quando vi ricorriamo in modo aleatorio nella quotidianità, la stimolazione psicosensoriale indotta dall’ascolto musicale può contribuire a migliorare la qualità alla nostra vita. Per le sue intrinseche caratteristiche essa si presta quindi naturalmente a essere utilizzata come medium terapeutico in tutte le fasce dell’età contribuendo al mantenimento di prestazioni cognitive, come pure delle inclinazioni emotive e di partecipazione sociale.
D Lei ha avuto il ruolo di coordinatore musicale in Acqua, un musical che naturalmente ha coinvolto un gran numero di persone. Lo spettacolo ha sempre fatto il “tutto esaurito”, un successo, insomma. Ma questo va inserito in un contesto particolare, quello della Svizzera Italiana, che conta meno di 400.000 abitanti, ossia un decimo scarso di quelli dell’area metropolitana milanese. Mi domando: tanto impegno non cozza contro la natìa ristrettezza geografica e linguistica? Per uscire da questa empasse è naturale pensare all’Italia. Avete prospettive in questo senso?
R Acqua-Il Musical è in primo luogo un’operazione che ho definito nei dossier di presentazione, come una “vasta operazione socio culturale”, e che ha avuto inizio quasi 5 anni or sono. Attraverso una fitta organizzazione di volontari in un primo momento, si è provveduto a formare attori non professionisti e a creare il livello adeguato per poter interagire in seguito con professionisti del settore. Il lato formativo ha coinvolto, vista la natura originale dell’opera (ispirato alla vera storia di Radwan, immigrato Somalo che viene accolto in Ticino), anche i temi della prevenzione al razzismo e alla condivisione e agli scambi socio culturali di diverse etnie. Logicamente anche dal punto di vista musicale sono state proposte diverse scelte tematiche di origine multi-etnico ed è stata effettuata una ricerca accurata nei vari stili, abbracciando diversi generi musicali. Chiaramente il coordinare 16 attori, 11 musicisti dal vivo, e altrettanti tecnici tra sound design, luci, costumi, non è stata un’operazione semplice, anche perché l’associazione non profit che ha promosso il progetto, operava quasi esclusivamente in forma di volontariato, e con pochi sostegni da parte di alcune fondazioni dislocate in Svizzera. Il carico amministrativo era svolto in gran parte dalla mia società di consulenza tecnico-musicale CSRM Consulting, negli ultimi due anni la situazione era diventata molto complessa anche dal punto di vista finanziario, amministrativo e contrattuale, ma sostenibile. L’idea era quella di proporre un progetto multi lingua con dei sopra titoli durante gli spettacoli e potersi proporre in altri Cantoni e altri paesi tramite i dipartimenti culturali delle ambasciate svizzere nel mondo. Effettivamente i costi di produzione erano molto elevati a fronte di pochi (e per fortuna) concreti aiuti da parte di tre fondazioni e un nutrito contingente di piccoli contributi di sostegni a livello di soci associati, ma per l’estero si sarebbe contato sulla formazione di altri attori in loco, sostenuti da altrettante associazioni non profit. Come coordinatore avevo proposto a livello amministrativo una collaborazione inter cantonale e con l’aiuto di organizzazioni molto importanti come Soccorso operaio Svizzero, poter proporre lo spettacolo promuovendo la lingua italiana oltre Gottardo. A suo tempo erano state effettuate diverse proposte nei teatri dell’area di Milano, ma non ho avuto un seguito, se non un timido interesse da parte del Teatro di Varese. Quindi l’unica via per poter portare il Musical in Italia, era poter contare su sostegni e sponsor, che purtroppo non sono giunti come ci si aspettava. E’ si vero che quando si vuole sensibilizzare il pubblico e creare un outcom positivo tutto sommato, con dei temi così attuali, si rischia anche di incappare in meccanismi “politici” e mi sono ritrovato con la negazione di sussidi da parte di alcuni enti pubblici apparentemente preposti all’uopo. Durante l’ultima replica “sold out” presso il Teatro di Locarno nel 2024, grazie ai festeggiamenti dei 40 anni di SOS Ticino, ho potuto constatare per la prima volta (dopo 9 spettacoli) un trend economico positivo, e il rinnovato interesse da parte di alcune manifestazioni importanti come “Festival dei Diritti Umani Lugano”, “Settimana contro il Razzismo SCR”. Una delle soluzioni proposte, dopo la registrazione della colonna sonora in co-produzione RSI avvenuta nelle sessioni tra novembre e aprile 2023-24, con tutti i musicisti dell’”Aktè Ensemble”, il “Coro Cantemus” e alcuni attori dello Staff, una ventina di musicisti ospiti, era di ridimensionare l’organico e potersi proporre anche in teatri con capienze più modeste, utilizzando delle basi elaborate poi in studio in post-produzione e adattate allo spettacolo. Nonostante le ristrettezze economiche della produzione esecutiva, la continuità garantita e la volontà da parte mia nella direzione musicale e amministrativa, l’associazione che ha sostenuto e promosso il progetto, ha inspiegabilmente sospeso a fine dicembre 2024 Acqua-Il Musical, senza una motivazione chiara e professionale. Fortunatamente sia il pubblico che ha già potuto gustarsi Acqua, i partecipanti stessi, i professionisti, tra attori, staff tecnico e musicisti, e alcuni promoters che ne hanno potuto saggiare la profondità e la qualità dello spettacolo, desiderano un ritorno del progetto… quando? … à suivre…
D Cosa rappresenta e cosa significa per lei il jazz?
Potrei affermare, dopo oltre 30 anni di attività musicale, il Jazz, rappresenta ancora un progetto di vita, in continua evoluzione e trasformazione. Volatile, impermanente, se non per i documenti sonori, numerosissimi, che ho registrato e pubblicato. Ho iniziato nei pochi locali fumosi a propormi con gruppi di jazz tradizionale, a vivere quei luoghi nel caos totale dove pochi ascoltavano e davano il meglio di se nel chiacchierare più forte possibile (dal verbo francese “jazer”). Non ho vissuto questo movimento sonoro permeato dall’attivismo politico, dalle forme di protesta, essendo dalle nostre parti una “cultura di rimbalzo”, ma sempre comunque in contrasto nel periodo del Conservatorio, dove per altro non mi era permesso, se non proibito nel peggiore delle situazioni, di suonare “musica moderna” come altri generi musicali, e dedicarsi esclusivamente al clarinetto “classico”. Mi dicevo sempre perché denigrare questo universo di espressione ritmica e improvvisazione? Oltre la passione che maturavo man mano per le voci del sassofono più autorevoli, come Sonny Rollins, Joe Henderson, Wayne Shorter, Coleman Hawkins, costruendo i primi “stilemi” nel mio vocabolario Jazzistico, si accendeva sempre più quel contrasto che mi ha portato a completare gli studi classici con ottimi voti ed interesse, soprattutto per la musica contemporanea, ma soprattutto a cercare di comprendere quei linguaggi, quelle forme di improvvisazione e più tardi seguire uno stile di vita sonoro che mai mi sarei aspettato. Grazie a quei contrasti con l’accademismo mi sono ritrovato a vincere una borsa di studio per Berklee a Boston, e condividere un vissuto sonoro con delle guide di grande valore e sicuramente degli esempi di umiltà: Jim Odgren, Kenny Werner, Jerry Bergonzi, Joe Viola e non da ultimo Garrison Fewel. Passando dai locali più infimi, alle prime esperienze discografiche, dai silenzi assoluti degli studi di registrazione, senza lasciare per altro le formazioni di jazz acustico, man mano che la passione cercava di comprenderne i meccanismi a livello didattico, nello sviscerare teorie e filosofie, mi ritrovavo nel periodo “didattico” a Berklee come studente di orchestrazione e in seguito a viaggiare in tour con diverse formazioni, scoprivo l’”intellettualismo nordico, in contrapposizione al sanguigno e grove del Sud e dell’Est, e ancora mi tuffavo in produzioni più di nicchia, o di ricerca. Poi, con l’avvento di una discografia più personale, con influenze anche di musica classica e contemporanea, molti promoters di festival erano scettici e dubbiosi nel proporre i miei progetti, perché lontani dalla “tradizione” (secondo il loro parere) da ciò che è usanza, consuetudine, in parole povere dal business puro e semplice. Il Jazz sia in composizione che in esecuzione, è plastico, rimane intangibile, quindi riproporre lo stesso stile, o un simile linguaggio, il ripetersi o l’imitare è una pratica che mi risulta sempre più estranea. Mi diverte comunque insegnare, e donare delle basi didattiche valide e profonde nell’ambito jazzistico: la Fusion, Il Modern Jazz, sempre molto affini, proporre delle analisi sulle orchestrazioni delle colonne sonore dei compositori più autorevoli. Ho perseverato e ascoltato le parole di un musicista come mio papà, che ha sempre seguito la sua strada, rispettando sia un’etica professionale che artistica, così mi sono ritrovato nei grandi festival, nei maggiori teatri un po’ in tutto il mondo, dove il pubblico attònito e silente, si impregna di sonorità e sorprendentemente si immedesima nelle mie composizioni. Ho dovuto però imparare in tutti questi anni di attività musicale, ad abbandonare tutta la concezione teorica, matematica, conscia nella totalità della performance, per entrare in questo mondo magico anche del Jazz, dell’improvvisazione e dell’interazione con gli altri musicisti, designando come un unicum sonoro e di energie correlate e in continua espansione, nel pubblico, oppure in uno studio di registrazione. Grazie a questo percorso, mi sono reso conto che questo Jazz, fa parte di una continua ricerca, auto critica, messa in discussione, rivalutazione, e in contrapposizione a quando si “chiude” un mix in studio, o meglio si rinuncia nel continuare a metterci mano, questo modo di esprimermi e ricercare, non avrà un inizio, neppure una fine.
D Quali sono infine i suoi prossimi progetti?
R Dopo la fase di stallo e i contraccolpi subiti durante e dopo il periodo di pandemia, i progetti di produzione e una buona parte delle live perfomances si sono drasticamente ridotti inducendomi a delle scelte mirate. “L’ Aktè Ensemble” con Fausto Beccalossi, Claudio Farinone, Elias Nardi e Paolo Pasqualin, rimane una formazione che persiste nel panorama progettuale e che continua a permeare il mio interesse e la mia curiosità verso le sonorità del mediterraneo, medio-oriente compreso. Nel campo della ricerca mi sono prefissato di riprendere e rivedere un mio progetto originale intitolato “Nautilus IV-III-II”, legato alla sperimentazione di diversi tipi di accordatura del passato, applicata agli strumenti a fiato moderni, indi la sperimentazione sull’Akai EWI di temperamenti diversi. Nei progetti di arrangiamento, per l’occasione del 150 esimo dalla nascita di Maurice Ravel, sto preparando un adattamento della “Pavane pour un infante defunte” e il secondo tempo del “Quartetto per Archi in Fa maggiore”, per clarinetto contrabbasso, percussioni, flauto traverso e quartetto d’archi. A causa di una recente distonìa oro-facciale, ho dovuto limitare e ancora selezionare l’attività concertistica e di produzione, così mi posso concentrare sulla ricerca e le produzioni come sound designer. Riguardo all’impegno sociale, sono presidente dell’Associazione AGO, fondata di recente e con sede nel Grigione Italiano. Coadiuvato da professionisti nel settore dell’industria musicale, AGO promuove attività differenziate di scambio, formazione nel campo delle arti sceniche, consulenze tecnico-musicali, servizi amministrativi in diversi settori artistici e di produzione. Parimenti organizza eventi musicali, sonorizzazioni di mostre d’arte, promuovendo spettacoli e performance ad ampio raggio, inter scambi di progetti e artisti a livello internazionale. Sono membro della Commissione Cultura Monte Ceneri e nella realizzazione e promozione di attività letterarie e sonorizzazioni di eventi, principalmente presso la Casa dei Landfogti, unitamente ad altri luoghi storici sempre dello stesso Comune.