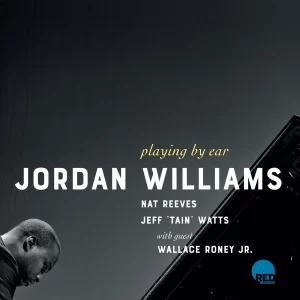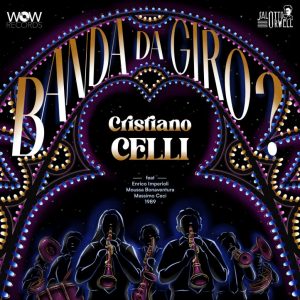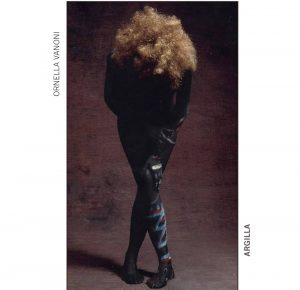Claudio Fasoli / Kenny Wheeler con «Welcome»: quando il jazz diventa pensiero, veicolo poetico e sparizione controllata (Soul Note, 1986)

«Welcome» non è un disco a tema, né un lotto di prove solistiche, bensì un organismo vivente, articolato attorno ad un’estetica dell’impermanenza e dell’ascolto reciproco. L’interazione tra Wheeler e Fasoli non si basa su call and response né su gerarchie improvvisative, ma su una grammatica comune fondata sulla leggerezza, sull’assenza di peso retorico e sull’equilibrio tra scrittura e voce interiore.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Kenny Wheeler e Claudio Fasoli hanno avuto occasione di collaborare, ed uno degli esiti più rilevanti del loro incontro viene documentato nel disco «Welcome», pubblicato nel 1986 per l’etichetta Soul Note. Questo album, oggi oggetto di meritata riscoperta da parte di collezionisti e studiosi, testimonia un momento di particolare fecondità per il jazz europeo, in cui la convergenza di personalità affini produceva un linguaggio elegante e fortemente individuale, ben distante dagli stereotipi mainstream.
In «Welcome», Fasoli guida un ensemble cameristico e meticolosamente calibrato, che accoglie Wheeler in qualità di ospite, ma in realtà l’interazione fra i due rivela un equilibrio profondo, non gerarchico, in cui le voci s’intrecciano come linee contrappuntistiche in una partitura fluida e sempre mobile. Il gruppo include anche Jean-François Jenny-Clark al contrabbasso e Daniel Humair alla batteria, due personaggi cardine dell’avant-garde europea, capaci di operare sul crinale fra pulsazione e rarefazione, ancoraggio tonale e disgregazione ritmica. Il disco si struttura come un insieme coeso, non frammentario, in cui ogni traccia s’inscrive in una poetica della continuità, della tensione verso l’unità formale pur nel libero fluire dell’improvvisazione. Wheeler vi appare in stato di grazia, con il suo flicorno emana un calore meditativo che ben si sposa con il fraseggio essenziale e affilato di Fasoli, mai ridondante, sempre pronto a lasciare spazio all’ascolto. I due non si rincorrono, né si sovrappongono, ma sembrano piuttosto disegnare a distanza una forma condivisa, come due calligrafie che, pur diverse, rispondono alla medesima idea di silenzio, di sospensione e di tensione verso un altrove. Nonostante la registrazione si collochi a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, periodo spesso segnato da produzioni sovraccariche e da derive fusion, «Welcome» si distingue per una sobrietà formale ed una lucidità di pensiero che lo rendono anacronistico nel miglior senso del termine. Il suono appare asciutto, privo di compiacimenti timbrici, tutto è votato alla ricerca di una sintesi fra forma ed improvvisazione, lirismo ed astrazione. Questa collaborazione rappresenta una convergenza emblematica di due modi di intendere il jazz non come territorio di appartenenza identitaria, bensì come linguaggio aperto, capace di assorbire il silenzio europeo, la ricchezza del pensiero formale e la libertà dell’improvvisazione afroamericana senza mai ridursi ad semplice collage. «Welcome» costituisce non soltanto un documento storico di alto profilo, ma anche una manifestazione limpida di quel jazz traslato di cui entrambi, Fasoli e Wheeler, sono tra i più lucidi interpreti; un jazz che non rinnega le sue radici, ma le sublima in un tempo altro, più riflessivo, più appartato, più vicino alla poesia che all’intrattenimento.
«If Only» apre il disco con un’atmosfera di lieve tensione sospesa, quasi un’ipotesi mai del tutto formulata, incarnata nella scelta di un tempo moderato e di un fraseggio fluido ma trattenuto. Le note di Wheeler si dispiegano con ampi intervalli, tratteggiando una linea melodica che sembra inseguire un ideale sfuggente, un rimpianto non dichiarato. Fasoli risponde con un sax dal timbro tenue, quasi un sussurro, come a confermare questa dimensione di sottrazione emotiva. La struttura armonica si fonda su accordi di nona e undicesima che fluttuano senza risoluzioni definitive, conferendo all’insieme una qualità «aperta» e vagamente indefinita. L’interazione ritmica, affidata a Daniel Humair e Jenny-Clark, appare discreta, oscillante tra marcature liquide e sospensioni che favoriscono l’ampiezza spaziale del dialogo. La tromba (o più spesso il flicorno) di Wheeler si sovrappone con discrezione, introducendo una linea melodica costruita su intervalli ampi, quasi a mimare l’eco di un pensiero che si srotola nel vuoto. L’armonia si appoggia su accordi sospesi, con quinte e none lasciate aperte, mai chiuse su risoluzioni cadenzali: una grammatica che predilige la suggestione tonale piuttosto che l’affermazione funzionale. Nel proseguo, «Invisible Sound» intensifica l’indagine sul piano dell’astrazione sonora: il titolo allude con efficacia a un’impronta acustica che si percepisce senza manifestarsi direttamente. Il sax soprano di Fasoli percorre sentieri improvvisativi segnati da dinamiche mutevoli e timbri sfumati, come sospesi in un ambiente rarefatto. La tromba di Wheeler, meno lineare, costruisce fraseggi ricchi di cromatismi e intervalli dissonanti, evocando un paesaggio emotivo denso di ambivalenze. La struttura armonica qui si sposta verso un uso più frequente di scale modali e passaggi per cluster, quasi a suggerire un’eco delle avanguardie europee, ma filtrate da un lirismo mai tradito, trasformando il dialogo tra Wheeler e Fasoli in un vero e proprio contrappunto timbrico. Il sax soprano, qui impiegato da Fasoli con misura quasi ascetica, insegue le inflessioni liquide del flicorno, generando un intreccio che richiama certe astrazioni della Third Stream, ma senza la freddezza accademica che spesso le accompagna. Si avverte una pulsazione sotterranea, più suggerita che dichiarata, che guida l’improvvisazione verso uno sviluppo orizzontale, svincolato da climax o strutture tripartite. La terza composizione, «Emptiness», costituisce un vero e proprio fulcro espressivo e concettuale del disco. Il titolo si fa manifesto attraverso una musica che sfida ogni pienezza e compiutezza, privilegiando l’idea del vuoto come forma sonora. Wheeler modula su intervalli ampi, ma con una soffusa malinconia, attraverso frammenti melodici che sembrano citazioni interiori, reminiscenze di un blues spettrale, purissimo nella sua assenza di cliché. La tonalità si sfalda in un’ambiguità modale, quasi debussiana, in cui il centro tonale è sempre ritardato, dislocato, evocato più che nominato. Dal canto suo, Fasoli accarezza note lunghe, quasi sospese, che si adagiano su una base ritmica volutamente rarefatta e destrutturata. L’armonia si sottrae a ogni riferimento tonale stabile, oscillando fra accordi sospesi, pedal point indefiniti e improvvisazioni libere, senza cadere però nel caos. L’estetica dell’assenza si traduce in un invito all’ascolto attento, a cogliere il valore di ogni silenzio e di ogni pausa.
Con «Epic», il disco introduce un contrasto netto, in cui la brevità e l’intensità del pezzo evocano un gesto quasi aforistico. Fasoli suona con un controllo del respiro e della dinamica che sfiora l’ascetismo, dove ogni nota distilla un frammento di silenzio inciso, un stilla di luce in penombra. Wheeler, da par suo, disegna linee che ricordano certi lamenti modali mediorientali, in un contesto armonico che alterna triadi aumentate, accordi di settima con la quinta diminuita e impasti tonali senza gerarchie. Il contrabbasso di Jenny-Clark non fornisce fondamento, ma interferenze armoniche, quasi armonici artificiali inseriti con sapienza nel tessuto sonoro. Nonostante la durata ridotta, la traccia non rinuncia all’opulenza espressiva, mentre la ritmica si fa più marcata. L’approccio armonico, pur restando complesso, predilige passaggi più definiti, con accenti improvvisi e tensioni dissonanti che sembrano interrompere il fluire del tempo in modo quasi teatrale. Fasoli risponde con un contrappunto serrato, spezzato, capace di restituire la frammentarietà implicita nel titolo. Il titolo successivo, «Oblivion», riprende e approfondisce il clima di sospensione meditativa, mentre si percepisce la sensazione di un lento dissolversi, di una scomparsa progressiva che trova nella musica la propria traduzione più efficace. Wheeler articola frasi dai contorni sfumati, spesso sul registro grave, mentre Fasoli adopera un approccio più rarefatto e accennato, giocando con il timbro del sax per sottolineare la dimensione eterea del pezzo; si avverte una tensione lirica più esplicita, pur sempre trattenuta, specie dove Wheeler tocca il registro acuto con un controllo timbrico che non cerca mai l’esplosione, ma la vibrazione interna, quasi intima, della nota. Fasoli sembra ripercorrere la memoria del jazz, ma senza nostalgia. Le sue linee ricordano Tristano, Warne Marsh, ma anche il Debussy più rarefatto. La sezione ritmica mantiene un’andatura fluttuante, con un uso sapiente del silenzio e delle pause, mentre le scelte armoniche si muovono fra modi dorico e lidio, alimentando un senso di immobilità dinamica. «Sagittario» introduce una componente più narrativa, quasi programmatica, tanto che il nome rimanda a un archetipo simbolico di dinamismo, movimento e tensione verso il bersaglio. La musica riflette questa idea attraverso un aumento del respiro melodico e una maggiore articolazione ritmica. Wheeler affonda la sua linea in un fraseggio più lirico, con passaggi diatonici alternati a momenti di dissonanza studiata, mentre Fasoli amplia il proprio registro, passando dal soprano al tenore con una flessibilità che conferisce varietà timbrica al dialogo. Le armonie si fanno più esplicite, con moduli che richiamano la tradizione jazzistica ma reinterpretati con sensibilità contemporanea, creando un effetto di sospensione tra passato e presente.
Il penultimo motivo, «Zen», racchiude in sé la quintessenza della filosofia estetica del disco. La musica si fa essenziale, contemplativa, sospesa nel tempo. Wheeler e Fasoli si cimentano in un dialogo in cui la rarefazione è parola d’ordine, dove ogni nota risulta misurata, ponderata, quasi un segno calligrafico. La sezione ritmica, delicata e attenta, si pone al servizio di un discorso che privilegia la qualità del suono e la sua spazialità. L’armonia si dispiega attraverso pedali minimi e accordi sparsi, spesso privi di funzione tonale, mentre l’approccio improvvisativo privilegia la sottrazione piuttosto che l’aggiunta, con pause e silenzi che definiscono lo spazio stesso del discorso. Chiude il lavoro, in modo emblematico, la traccia eponima «Welcome», ossia una breve meditazione, un invito sommesso a entrare in uno spazio di ascolto e riflessione. Wheeler sussurra note dal flicorno con una dolcezza intima, mentre Fasoli risponde con poche frasi essenziali, creando un contrappunto lirico che sembra simbolizzare il dialogo tra due anime musicali affini. L’armonia è trasparente, quasi evanescente, e il tempo dilatato all’estremo, come per sottolineare la funzione di apertura e chiusura che il pezzo esercita nell’economia complessiva del disco. Nessun epilogo trionfale, nessuna sintesi, piuttosto, un invito all’ascolto continuo, alla percezione del non-finito come gesto musicale. Le armonie si disfano in campi tonali aperti, senza centro, mentre Wheeler affida alle ultime note un’emozione trattenuta e irreversibile. Il sax di Fasoli sembra rispondere da lontano, come se la musica stesse già svanendo, non nella memoria, ma nel tempo stesso.
«Welcome» non è un disco a tema, né un lotto di prove solistiche, bensì un organismo vivente, articolato attorno ad un’estetica dell’impermanenza e dell’ascolto reciproco. L’interazione tra Wheeler e Fasoli non si basa sul call and response né su gerarchie improvvisative, ma su una grammatica comune fondata sulla leggerezza, sull’assenza di peso retorico e sull’equilibrio tra scrittura e voce interiore. In questo incontro, il jazz si trasfigura, oltrepassando il concetto di linguaggio identitario e divenendo, per contro, forma del pensiero, veicolo poetico ed occasione di sparizione controllata.