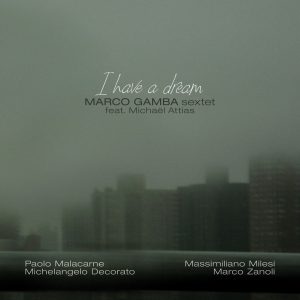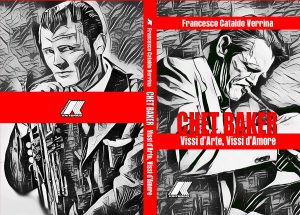Architetture dell’imprevisto. Ritratto di Brad Mehldau con cornice ed ingrandimento

Brad Mehldau
La sua scrittura armonica si basa su una profonda conoscenza della tradizione tonale, ma non si limita a riproporla: la piega, la espande, la interroga. Le progressioni armoniche, spesso costruite su modulazioni impreviste e su sovrapposizioni di tonalità, generano un senso di instabilità controllata, in cui la tensione non viene mai risolta in modo prevedibile.
// di Francesco Cataldo Verrina //
La traiettoria artistica di Brad Mehldau si distingue per una tensione costante tra spontaneità e rigore formale, tra l’urgenza dell’improvvisazione e la consapevolezza strutturale del compositore. Fin dagli esordi negli anni ’90, la sua produzione ha privilegiato la dimensione del trio, ambito nel quale ha saputo rinnovare radicalmente il linguaggio pianistico jazzistico, senza mai indulgere in manierismi o citazionismi compiaciuti.
La serie discografica intitolata «The Art Of The Trio», pubblicata tra il 1996 e il 2001, rappresenta un corpus emblematico per comprendere l’evoluzione del suo pensiero musicale. In questi lavori, Mehldau affina un lessico espressivo che si nutre tanto della tradizione afro-americana quanto della letteratura pianistica europea, con riferimenti che spaziano da Brahms a Bill Evans, da Schubert a Keith Jarrett. L’eloquenza narrativa delle sue linee melodiche coabita con una polifonia interiore che sovente sfocia in veri e propri contrappunti improvvisati, sostenuti da un interplay cameristico con i suoi partner storici, Larry Grenadier e Jorge Rossy, poi sostituito da Jeff Ballard. Accanto alla dimensione del trio, Mehldau ha coltivato con pari intensità il repertorio solistico, come testimoniano «Elegiac Cycle» e «Places», due raccolte concepite come cicli coerenti, in cui ogni componimento si relaziona agli altri secondo una logica tematica e affettiva. In queste opere, l’elemento autobiografico si fonde con una scrittura che riflette una profonda interiorizzazione della forma-sonata e della variazione, rielaborate attraverso il prisma dell’improvvisazione. L’incontro con Jon Brion ha aperto una nuova fase nella sua produzione, inaugurata da «Largo» e proseguita con «Highway Rider», in cui l’organico si espande fino a comprendere un’orchestra da camera. In questi lavori, il pianista sperimenta soluzioni timbriche inedite, accostando strumenti acustici ed elettronici, e articolando le sezioni secondo una logica cinematografica, più prossima alla suite sinfonica che alla forma jazzistica convenzionale.
Le influenze che hanno plasmato l’universo musicale di Brad Mehldau sono molteplici e stratificate, e si riflettono in una scrittura che sfugge a ogni classificazione rigida, muovendosi con naturalezza tra idiomi diversi e apparentemente inconciliabili. Fin dalla giovinezza, Mehldau ha mostrato un’attenzione particolare per la musica classica europea, in particolare per il repertorio romantico tedesco. Compositori come Johannes Brahms, Franz Schubert e Robert Schumann hanno lasciato un’impronta profonda nel suo linguaggio armonico e nella concezione formale delle sue composizioni. Questa eredità si manifesta non solo nella scelta di materiali tematici, ma soprattutto nella capacità di costruire archi narrativi ampi, in cui ogni elemento trova una collocazione organica all’interno di un disegno coerente. Accanto a questa matrice colta, si colloca un interesse altrettanto marcato per il jazz afroamericano, in particolare per la scuola di Thelonious Monk, Bill Evans e Keith Jarrett. Da Monk, Mehldau ha ereditato l’inclinazione per l’irregolarità ritmica e l’uso di dissonanze angolari; da Evans, la raffinatezza timbrica e l’interplay cameristico; da Jarrett, l’idea di un flusso improvvisativo continuo, capace di trasformare ogni frammento melodico in un racconto compiuto. Non meno rilevante è l’influenza della musica pop e rock, che Mehldau ha sempre considerato come parte integrante del proprio orizzonte espressivo. Artisti come The Beatles, Radiohead, Nick Drake, Elliott Smith e persino gruppi di rock progressivo come Gentle Giant e Rush hanno alimentato la sua immaginazione sonora, offrendo spunti per riletture che non si limitano alla trascrizione, ma si configurano come veri e propri atti di reinvenzione.
Nel corso degli anni, Mehldau ha inoltre assorbito suggestioni provenienti dalla musica elettronica, dalla canzone d’autore americana e dalla tradizione liederistica europea. Non si può trascurare l’influenza della letteratura e della filosofia. Nella sua autobiografia «Formation: Building a Personal Canon» (2023), il pianista cita autori come James Joyce, Thomas Mann, Harold Bloom e Terry Eagleton, delineando un paesaggio intellettuale che informa in profondità la sua visione dell’arte. La musica, per lui, non è mai un semplice esercizio tecnico, ma un atto di riflessione, un modo per interrogare il mondo e se stessi attraverso il suono. Le influenze che hanno alimentato la scrittura e l’estetica di Brad Mehldau non si esauriscono in un elenco di riferimenti stilistici, ma si manifestano come tensioni vive, come forze in dialogo che modellano ogni gesto musicale. In questo senso, la sua musica non si limita a riflettere ciò che l’ha preceduta: la rielabora, la interroga, la trasforma in un linguaggio personale che si rinnova costantemente. Negli ultimi anni, questa attitudine si è ulteriormente intensificata attraverso collaborazioni che hanno messo in luce nuove sfaccettature del suo pensiero sonoro. L’incontro con il chitarrista Julian Lage, ad esempio, ha dato vita a un dialogo intimo e serrato, in cui la chitarra acustica si è fatta specchio e contrappunto del pianoforte, in un gioco di riflessi che richiama la musica da camera più raffinata. Allo stesso modo, il sodalizio con il sassofonista Immanuel Wilkins ha aperto uno spazio di esplorazione lirica e spirituale, in cui la voce del sax si è intrecciata con le armonie cangianti del pianoforte in un flusso continuo, privo di cesure.
Nel 2023, il pianista di Jacksonville ha partecipato a un progetto collettivo dedicato alla figura di Leonard Cohen, contribuendo con una rilettura di «Famous Blue Raincoat» che ha suscitato unanime consenso. In questa interpretazione, la voce del pianoforte si è fatta quasi confessionale, restituendo la densità poetica del testo con una delicatezza che sfiora il silenzio. Non si tratta di un semplice omaggio, ma di un atto di assimilazione profonda, in cui la canzone diventa materia viva da plasmare. Parallelamente, il pianista ha intensificato la sua attività compositiva su commissione, con nuove opere per ensemble misti, tra cui un ciclo di brani per clarinetto, violoncello e pianoforte, scritto per il trio di Anthony McGill e pubblicato nel 2024. In queste pagine, la scrittura si fa più rarefatta, quasi ascetica, e lascia emergere una dimensione meditativa che si nutre di silenzi, sospensioni e risonanze. Tutto ciò conferma una traiettoria che non conosce stasi, ma si alimenta di incontri, letture, ascolti e riflessioni. Mehldau non si limita a suonare il pianoforte: lo interroga, lo mette in discussione, lo reinventa ogni volta come se fosse la prima. La sua musica non cerca mai l’effetto, ma la verità del momento, quella verità che si rivela solo a chi ha il coraggio di ascoltare senza preconcetti.
Il suo approccio all’improvvisazione si distingue per una tensione dialettica tra controllo e abbandono. Ogni performance si configura come un laboratorio di idee, in cui la materia tematica viene scomposta, analizzata e ricomposta secondo traiettorie imprevedibili. L’attenzione alla microstruttura del discorso musicale si accompagna a una visione architettonica dell’intero brano, in cui ogni episodio trova la propria collocazione all’interno di un disegno più ampio. Numerose sono le collaborazioni che hanno arricchito il suo percorso: da Joshua Redman a Pat Metheny, da Lee Konitz a Charles Lloyd, fino a incursioni nel repertorio extra-jazzistico con artisti come Willie Nelson e Joe Henry. In ambito cameristico, spiccano i lavori con le voci di Renée Fleming e Anne Sofie Von Otter, per le quali ha composto cicli liederistici di rara intensità, come «Love Sublime» e «Love Songs», in cui la scrittura pianistica si fa ora sostegno lirico, ora controcanto drammatico. La sua attività compositiva ha trovato espressione anche in ambito orchestrale, con lavori come «Variations On A Melancholy Theme» e «Three Pieces After Bach», in cui l’eredità del contrappunto barocco viene filtrata attraverso una sensibilità armonica novecentesca, senza mai perdere il contatto con la pulsazione ritmica del jazz. Mehldau non si limita a reinterpretare il repertorio standard, ma lo reinventa, spesso accostandolo a brani provenienti dal mondo del rock, del pop e della musica elettronica. In questo equilibrio instabile risiede la forza della sua musica, capace di coniugare l’intelligenza analitica con l’emozione immediata, la complessità con la chiarezza, la densità con la trasparenza.
Negli ultimi anni, Brad Mehldau ha proseguito il suo percorso artistico con una serie di collaborazioni e progetti che confermano la sua instancabile curiosità musicale e la capacità di dialogare con linguaggi eterogenei, mantenendo intatta la coerenza della propria voce espressiva. Tra le collaborazioni più significative si distingue quella con Christian McBride, contrabbassista di riferimento nel panorama jazz contemporaneo. I due artisti, legati da un’amicizia di lunga data, hanno condiviso il palco in diverse occasioni, tra cui un recente duo al Big Ears Festival, in cui l’intesa musicale ha raggiunto vertici di rara intensità. Il pianista ha descritto l’esperienza come «gioiosa e al tempo stesso vertiginosa», sottolineando l’eleganza e la profondità del fraseggio di McBride, capace di fondere swing, lirismo e autorità espressiva in un equilibrio sempre mobile. Nel 2023, Mehldau ha preso parte al progetto «Long Gone», accanto a Joshua Redman, Brian Blade e lo stesso McBride, proseguendo una collaborazione che affonda le radici negli anni ’90 e che ha già dato vita a lavori come «Mood Swing» e «Round Again». In questo contesto, il pianista si muove con disinvoltura tra scrittura collettiva e improvvisazione, contribuendo a un discorso musicale che si nutre di memoria condivisa e rinnovamento continuo. Parallelamente, il pianista ha intrapreso un dialogo con l’eredità della musica colta europea, culminato nella pubblicazione di due album solistici nel 2024: «After Bach II» e «Après Fauré». Il primo rappresenta un’estensione del progetto After Bach del 2018, con nuove interpretazioni di preludi e fughe dal Clavicembalo ben temperato, accostate a composizioni originali che ne riflettono l’impronta contrappuntistica. Il secondo, concepito in occasione del centenario della morte di Gabriel Fauré, include trascrizioni di brani del compositore francese e nuove composizioni del pianista di Jacksonville ispirate alla sua scrittura armonica e alla sua poetica timbrica. Nel 2022, l’album «Jacob’s Ladder» ha segnato un ulteriore punto di svolta. In questo lavoro, il pianista ha esplorato le connessioni tra jazz, rock progressivo e spiritualità, attingendo a fonti eterogenee che vanno da Gentle Giant a Rush, da Emerson, Lake & Palmer a Periphery. Il disco, concepito come una riflessione musicale sul racconto biblico del sogno di Giacobbe, si articola in suite complesse e stratificate, in cui la voce del pianoforte si intreccia con elettronica, voci infantili e interventi di artisti come Mark Guiliana, Becca Stevens e Timothy Hill. Queste esperienze recenti testimoniano una continua espansione del suo orizzonte espressivo, in cui la dimensione jazzistica si apre a contaminazioni sempre più audaci, senza mai perdere il senso della forma e della narrazione. Mehldau si conferma così non solo come interprete raffinato, ma come autore di un pensiero musicale che si nutre di memoria, invenzione e ascolto reciproco.
Il rapporto di Brad Mehldau con figure come Bill Evans, Chick Corea, Keith Jarrett e Herbie Hancock non si esaurisce in una linea genealogica, ma si articola come un dialogo complesso, fatto di affinità, divergenze e rielaborazioni personali. Ognuno di questi pianisti rappresenta un nodo fondamentale nella storia del jazz moderno, e Mehldau si confronta con ciascuno di essi non come epigono, ma come interlocutore critico. Con Bill Evans condivide una sensibilità armonica raffinata e una concezione del trio come organismo cameristico, in cui le voci si intrecciano in un contrappunto fluido e paritario. Tuttavia, se Evans tendeva a privilegiare un lirismo introspettivo e una cantabilità sospesa, Mehldau introduce una tensione più marcata tra struttura e improvvisazione, tra ordine e disgregazione. L’influenza di Evans è evidente soprattutto nei primi lavori, ma viene progressivamente filtrata attraverso una grammatica più articolata e una sintassi più nervosa. Keith Jarrett rappresenta per il pianista di Jacksonville un punto di riferimento imprescindibile, non solo per l’approccio solistico, ma anche per la concezione della performance come atto di immersione totale. Entrambi condividono una visione del concerto come esperienza trasformativa, in cui l’improvvisazione si sviluppa come un flusso ininterrotto, capace di generare forme complesse a partire da nuclei minimi. Tuttavia, mentre Jarrett si affida spesso a un’estetica del flusso spontaneo, Mehldau tende a costruire architetture più sorvegliate, in cui la logica formale non è mai disgiunta dall’urgenza espressiva. Chick Corea, con la sua versatilità stilistica e la sua inclinazione per la sperimentazione timbrica, ha offerto a Brad un modello di apertura eclettica. Sebbene il pianismo di Mehldau sia meno percussivo e più introverso rispetto a quello di Corea, entrambi condividono una curiosità inesauribile per le contaminazioni, che li ha portati a esplorare territori che vanno dalla musica classica alla fusion, dal flamenco all’elettronica. Herbie Hancock, infine, rappresenta per Mehldau una figura di sintesi tra tradizione e innovazione. La sua capacità di reinventare il linguaggio jazzistico attraverso l’uso dell’elettronica, del funk e della sperimentazione armonica ha lasciato un’impronta anche nei progetti più audaci del pianista, come «Largo» o «Mehliana: Taming The Dragon». Tuttavia, Mehldau si distingue per una maggiore propensione alla verticalità del pensiero armonico, mentre Hancock privilegia spesso la dimensione orizzontale del groove e della pulsazione. In questo intreccio di influenze, Mehldau non si limita a raccogliere un’eredità: la rielabora, la mette in discussione e la trasforma in un linguaggio che, pur riconoscibile nei suoi riferimenti, si afferma come voce autonoma e inconfondibile. Se vuoi, possiamo ora approfondire il confronto con uno di questi pianisti in particolare, oppure analizzare un brano in cui queste influenze si manifestano in modo emblematico. Dal punto di vista musicologico, il metodo strumentale di Brad Mehldau si distingue per una sintesi sofisticata tra rigore compositivo e libertà improvvisativa, in cui ogni elemento tecnico è al servizio di una visione estetica coerente e stratificata.
La sua scrittura armonica si fonda su una profonda conoscenza della tradizione tonale, ma non si limita a riproporla: la piega, la espande, la interroga. Le progressioni armoniche, spesso costruite su modulazioni impreviste e su sovrapposizioni di tonalità, generano un senso di instabilità controllata, in cui la tensione non viene mai risolta in modo prevedibile. L’uso frequente di accordi quartali, di sovrapposizioni politonali e di armonie sospese contribuisce a creare un’atmosfera ambigua, in bilico tra trasparenza e densità. Il fraseggio si articola secondo una logica narrativa, in cui ogni cellula melodica si sviluppa come un’idea autonoma, capace di generare ramificazioni impreviste. Il pianista predilige linee spezzate, spesso costruite su intervalli irregolari, che si alternano a momenti di lirismo disteso. Il suo tocco, sempre calibrato, varia da un attacco percussivo e asciutto a un legato vellutato, con una padronanza timbrica che gli consente di evocare registri orchestrali anche nel contesto solistico. L’uso del cromatismo non è mai decorativo, ma funzionale alla costruzione di tensioni interne al discorso musicale. Le linee cromatiche ascendenti o discendenti si intrecciano con le armonie sottostanti, generando un senso di movimento continuo, spesso in contrasto con la stabilità apparente della pulsazione. In questo senso, Mehldau si avvicina più alla logica del contrappunto che a quella dell’accompagnamento tradizionale. Dal punto di vista ritmico, il suo vocabolario si distingue per una notevole varietà di accenti e suddivisioni. L’alternanza tra figure puntate, sincopi e spostamenti metrici produce un effetto di sospensione temporale, in cui il tempo sembra dilatarsi o contrarsi a seconda delle esigenze espressive. In alcuni casi, come nelle sue interpretazioni di standard o di brani pop, Mehldau gioca con la percezione del beat, spostandolo sottilmente per creare un senso di instabilità controllata. L’indipendenza delle mani è un altro tratto distintivo del suo stile. La mano sinistra, lungi dal limitarsi a un ruolo di sostegno armonico, agisce spesso come voce autonoma, capace di generare linee contrappuntistiche complesse o di introdurre cellule ritmiche che dialogano con la mano destra. Questo approccio, che richiama la scrittura pianistica di Bach e di Brahms, si traduce in una tessitura polifonica che arricchisce la densità del discorso musicale. In definitiva, il metodo strumentale del pianista di Jacksonville si sostanzia come un laboratorio di possibilità espressive, in cui ogni parametro – armonia, ritmo, timbro, articolazione – viene indagato con rigore analitico e sensibilità poetica. La sua musica non si limita ad essere suonata: si pensa, si costruisce e si ascolta mentre prende forma.