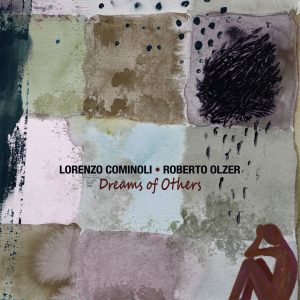«Assentamento»: Rogério Tavares canta Chico Buarque, un racconto armonico tra parola, voce e memoria (Egea Records)

Non si tratta di un semplice omaggio a Chico Buarque, ma di una restituzione affettiva e politica, dove la musica diventa luogo di resistenza e di affiliazione. Il disco si staglia come un lavoro collettiva, un romanzo corale o un film d’autore. E come ogni opera riuscita, non si esaurisce in un ascolto, ma si sedimenta lentamente nel tempo.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Nel corso della seconda metà del Novecento, l’Italia ha accolto musicisti brasiliani in fuga da un regime che aveva silenziato la parola e irrigidito il canto. L’insediamento della dittatura militare nel 1964 non ha soltanto interrotto una stagione di fermento culturale: ha costretto molti artisti a cercare altrove uno spazio dove continuare a pensare, scrivere, suonare. Alcuni hanno trovato rifugio in Europa, e tra questi, l’Italia ha rappresentato non solo un approdo, ma un terreno fertile per nuove contaminazioni.
Antonio Pecci Filho, in arte Toquinho, fu tra i protagonisti di questa stagione. Chitarrista virtuoso e compositore raffinato, collaborò con Vinícius de Moraes, poeta e diplomatico, anch’egli esule. In Italia, i due realizzarono il celebre album «La vita, amico, è l’arte dell’incontro» insieme a Sergio Endrigo e Giuseppe Ungaretti, un’opera che univa poesia, musica popolare brasiliana e canzone d’autore italiana. Il disco fu un manifesto di dialogo tra culture, dove la saudade brasiliana incontrava la malinconia mediterranea. Un altro nome centrale è Jim Porto, pianista e cantante originario di Rio Grande do Sul. Arrivato in Italia negli anni Settanta, si stabilì a Roma, dove divenne figura di riferimento del locale Manuia a Trastevere, vero laboratorio musicale della diaspora brasiliana. Qui si esibì con artisti come João Gilberto, Tania Maria, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Marisa Monte e Djavan. Le sue jam session coinvolsero anche jazzisti italiani come Roberto Gatto e Michele Ascolese, creando un ponte tra la bossa nova e il jazz europeo. La musica brasiliana non rimase confinata nei circuiti etnici o jazzistici. Ornella Vanoni collaborò con Toquinho e Vinícius, dando vita a «La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria», album che portò la MPB (Música Popular Brasileira) al grande pubblico italiano. Lucio Dalla, Fabrizio De André e altri cantautori furono influenzati da ritmi e tematiche brasiliane. De André, in particolare, scrisse «Princesa», brano in parte in portoghese, ispirato ad una storia vera di marginalità e resistenza. Il jazz italiano degli anni Settanta si aprì alle sonorità brasiliane grazie a questi incontri. Le armonie sofisticate della bossa nova e le metriche della samba si fusero con le improvvisazioni europee, dando vita a un linguaggio nuovo. Festival, rassegne e locali come il Manuia divennero luoghi di sperimentazione, dove la musica non era solo intrattenimento, ma anche testimonianza politica e culturale. Questa stagione non fu solo musicale, ma fu un momento di convergenza tra letteratura, cinema, poesia ed impegno civile. I brasiliani portarono con sé una lingua sonora viva, fatta di ritmo, sofferenza, parole e poesia, e gli italiani offrirono ascolto, spazio e complicità. Il risultato fu una delle più fertili contaminazioni artistiche del Novecento.
La presenza di artisti come Rogério Tavares, non si limita ad una collaborazione occasionale, ma si attesta come una tessitura costante, un dialogo che ha attraversato generazioni e linguaggi. Le voci brasiliane, portatrici di una memoria ferita ma non spenta, si sono intrecciate con le sonorità mediterranee, dando vita ad una forma espressiva che non appartiene più a una sola geografia. In «Assentamento», questo intreccio si manifesta con chiarezza. Non si tratta di un semplice omaggio a Chico Buarque, ma di una restituzione affettiva e politica, dove la musica diventa luogo di resistenza e di affiliazione. Le armonie costruite da Roberto Taufic, il fraseggio di Tavares, il clarinetto di Mirabassi, il pianoforte di Eduardo Taufic, le voci femminili che si alternano con misura e intensità, mentre tutto concorre a costruire un racconto che non si limita alla nostalgia, ma si apre alla possibilità di una nuova lingua comune. Questo idioma non ha bisogno di traduzioni. Vive nei timbri, nei silenzi, nelle modulazioni. E trova nel suolo italico non una semplice ospitalità, ma una seconda patria sonora. Come nei romanzi di Milton Hatoum, dove la memoria dell’Amazzonia si mescola con le tensioni urbane, o nei film di Ruy Guerra, dove il paesaggio diventa metafora dell’anima, anche qui la musica racconta un viaggio che non si conclude, ma si rinnova.
Non siamo alle prese con un tributo e neppure con un esercizio di stile. «Assentamento» rappresenta un atto di riconoscenza, un gesto di affiliazione poetica, un attraversamento consapevole dell’universo lirico di Chico Buarque de Hollanda. Rogério Tavares, voce discreta e mai invasiva, si muove con rispetto tra le pieghe di un repertorio che non ha bisogno di essere reinventato, ma soltanto abitato con intelligenza. Il disco nasce da un’intesa profonda tra Tavares e Roberto Taufic, artefice degli arrangiamenti ed interprete raffinato alla chitarra classica e alla viola caipira. Attorno a loro, una costellazione di musicisti che non suonano per accompagnare, ma per dialogare: Gabriele Mirabassi, il cui clarinetto non commenta ma suggerisce; Eduardo Taufic, che al pianoforte costruisce spazi di sospensione e misura; Roberto Rossi, Andrea Taravelli, Barbara Piperno, Marco Ruviaro, ciascuno con un ruolo preciso, mai decorativo. La presenza di ospiti come Silvia Donati, Cristina Renzetti, Barbara Casini e Vince Abbracciante non funge da ornamento, ma nasce da una scelta di affinità. Le voci femminili s’innestano con naturalezza nel parenchima sonoro, senza alterare l’equilibrio del progetto. Tavares, nato nel nord-est del Brasile, porta con sé una memoria musicale stratificata: dalla canzone romantica di Lupicínio Rodrigues alla sofisticazione della Bossa Nova, passando per le voci più radicali della MPB. La sua traiettoria, iniziata tra le mura domestiche e proseguita nei locali notturni di Natal, si è consolidata in Italia, dove vive dagli anni Ottanta. Ciononostante, la sua voce non ha mai smesso di appartenere al Brasile. La fisarmonica di Abbracciante in «Futuros Amantes» aggiunge una piega malinconica, mai enfatica. La scaletta risulta composta da dieci brani, selezionati con cura e senza concessioni all’ovvio. «Assentamento», che dà il titolo all’album, diventa un vero documento programmatico. Il disco, stato registrato al Duna Studio di Russi è stto finalizzato in Brasile, nello studio ET Natal, da Eduardo Taufic. Anche questo dettaglio tecnico racconta una geografia affettiva, un ponte tra due mondi che non si escludono, ma si completano.
«A Violeira» apre il disco come un prologo. La voce di Rogério Tavares si muove su un impianto armonico che richiama le forme modali del nord-est brasiliano, con la viola caipira di Roberto Taufic che evoca le corde di João Cabral de Melo Neto: secco, essenziale, mai decorativo. Il canto risulta narrativo, quasi parlato, come nei film di Glauber Rocha, dove la voce non è mai solo suono, ma strumento di denuncia. «Futuros Amantes», con la voce ospite di Silvia Donati e la fisarmonica di Vince Abbracciante, introduce una dimensione più lirica. L’armonia si apre, si distende, lasciando spazio ad una malinconia priva di rassegnazione. I riferimento va a Clarice Lispector, dove dominano l’attesa, il tempo sospeso ed il futuro come spazio interiore. Il canto si fa intimo, quasi confidenziale, con un fraseggio che non cerca l’effetto ma la verità. «As Vitrines» si attesta come il brano più cinematografico. Il clarinetto di Mirabassi disegna linee che ricordano le dissolvenze di Central do Brasil di Walter Salles. L’armonia implementata su progressioni che non risolvono, lascia il senso in bilico. La voce di Tavares dà l’idea che sia leggermente trattenuta, come se stesse osservando da dietro un vetro, appunto. Il testo, già di per sé evocativo, viene trattato con pudore, senza enfasi. «Não sonho mais» innesca un punto di rottura. L’armonia diventa più scarna, il canto più diretto, entrando nel territorio di Rubem Fonseca, dove allignano la disillusione e la fine del sogno, mentre la realtà si appalesa con piglio deciso. Il piano di Eduardo Taufic lavora per sottrazione, lasciando che siano le pause a parlare. «Assentamento», componimento eponimo, diviene il centro gravitazionale del disco. L’armonia si srotola su un impianto tonale che si apre a modulazioni inattese, come i romanzi di João Ubaldo Ribeiro, dove la narrazione si sposta senza preavviso. Il canto mostra un anelito collettivo, corale, come in un film di Fernando Meirelles, in cui sono presenti la comunità, il territorio,e la resistenza. Dal canto suo, la voce di Barbara Casini aggiunge una dimensione rituale, quasi liturgica. «João e Maria» tratteggia con nostalgia il momento dell’infanzia e della memoria. Il mandolino di Marco Ruviaro richiama le sonorità del choro, ma con una delicatezza che rimanda a O Quatrilho di Fábio Barreto. L’armonia risulta semplice, ma non banale ed il canto narrativo, ma con una tenerezza che non scade mai nel sentimentalismo. «Injuriado», con Cristina Renzetti, assume i toni di una dichiarazione quasi politica. L’armonia si mostra tesa e il ritmo incalzante, varcando il territorio di Chico César e di Jorge Amado, in cui riaffiorano la denuncia, la rabbia, ma anche l’ironia. La voce appare tagliente ed il fraseggio serrato. Le percussioni di Roberto Rossi non accompagnano, ma sembrano incalzare un inno di lotta. «Trocando em Miúdos» è il momento della resa. L’armonia diventa più jazzistica, con progressioni cromatiche che ricordano le colonne sonore di Nelson Pereira dos Santos. Il canto risulta spezzato, frammentato, come se stesse cercando di ricomporsi. Il flauto di Barbara Piperno aggiunge una dimensione onirica, quasi surreale. «Bye Bye Brasil» si sostanzia come il brano più esplicito nel suo riferimento cinematografico. Il titolo stesso richiama il film di Carlos Diegues, e l’arrangiamento ne conserva lo spirito: viaggio, disincanto e modernità. L’armonia si muove sulle sabbie mobili accordali, mostrandosi instabile. La voce si esprime con consapevole, scevra però da ogni cinismo. «Vai Trabalhar Vagabundo» chiude il disco con ironia. L’armonia è giocosa, il ritmo sincopato ed il canto teatrale, quasi cabarettistico, come nei testi di Millôr Fernandes. Ma sotto la superficie, resta una domanda: chi lavora davvero? Chi decide il valore del lavoro? Ogni passaggio sonoro e canoro costituisce un tassello del mosaico che non cerca di spiegare Chico Buarque, ma di penetrarne l’essenza e rimodularla verso l’esterno, riattualizzandolo. La voce di Rogério Tavares rappresenta il filo conduttore, ma non il protagonista assoluto. Il disco si staglia come un lavoro collettiva, come un romanzo corale o un film d’autore. E come ogni opera riuscita, non si esaurisce in un ascolto, ma si sedimenta lentamente nel tempo.