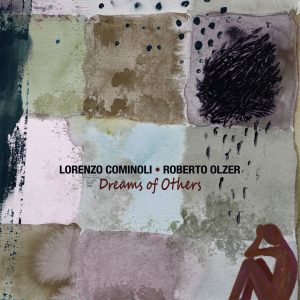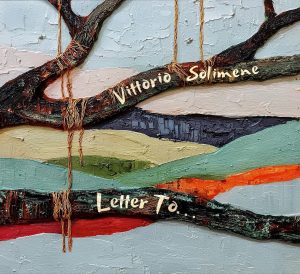La poetica pianistica di Sunna Gunnlaugs, tra il silenzio dei fiordi e il ritmo di New York

Sunna Gunnlaugs Trio
Gunnlaugs non cerca la vertigine del virtuosismo né l’enciclopedismo stilistico, ma privilegia un minimalismo poetico che fa della sottrazione un valore. Le sue armonie tendono a dispiegarsi con lentezza, secondo logiche di attesa e chiarificazione; le modulazioni non sorprendono per spigolosità, ma per la delicatezza con cui si inseriscono nel parenchima melodico.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Sunna Gunnlaugs si palesa come un raro esempio di jazzista contemporanea, costantemente in equilibrio fra radicamento ed apertura, fra la quiete contemplativa delle coste islandesi e l’irrequietezza pulsante di New York. Cresciuta a Seltjarnarnes, minuscolo comune affacciato sull’oceano e distante pochi chilometri da Reykjavík, si avvicinò alla musica attraverso l’organo, strumento domestico e duttile che le permise sin da giovanissima di cimentarsi con repertori eterogenei, dalle marce e dalla polke alle melodie dei Beatles, fino alle valzeristiche figurazioni di Strauss. In questa prima fase, la percezione del pianoforte rimase legata ad un mondo severo, intriso di formalismi accademici ed, ai suoi occhi, privo di autentico trasporto. La rivelazione giunse con l’ascolto di una registrazione del trio di Bill Evans. Quell’esperienza aprì in lei un varco emotivo ed intellettuale, mostrandole come il pianoforte potesse farsi veicolo di intimità, libertà espressiva e sottile lirismo.
Nel 1993 la giovane pianista decise di trasferirsi a New York, epicentro del jazz e crogiolo di influenze transnazionali, dove frequentò i leggendari club di Manhattan, assorbendo l’energia delle jam-session ed osservando da vicino i grandi protagonisti della scena. Questo periodo di apprendistato, trascorso tra ascolto e sperimentazione, alimentò la sua propensione compositiva e la convinse a imprimere una direzione personale al proprio linguaggio. L’approdo a Brooklyn segnò la nascita del suo primo lavoro discografico, «Far Far Away» (1996), realizzato con il sostegno del batterista Scott McLemore, futuro compagno di vita e sodale artistico. Il ritorno in Islanda non implicò alcuna cesura rispetto al fertile legame con New York, al contrario, Gunnlaugs seppe trasformare quella doppia appartenenza in una cifra stilistica. Il suo modulo jazzistico si nutre della lucentezza tematica e della sobrietà timbrica tipiche della sensibilità europea, senza rinunciare al vigore ritmico e all’urgenza improvvisativa che contraddistinguono le regole d’ingaggio statunitensi. Tale sintesi, lungi dall’essere un semplice compromesso, si configura come un territorio intermedio, capace di evocare il paesaggio nordico ed al contempo l’orizzonte metropolitano. La sua discografia, che annovera una decina di album, ha ricevuto plausi dalle più autorevoli riviste di settore, attestando il valore di un percorso coerente ed riconoscibile. Il trio stabile, formato con McLemore alla batteria e Þorgrímur Jónsson al contrabbasso, esprime un laboratorio privilegiato, in cui la continuità relazionale favorisce un interplay di rara intesa. La cifra strumentale dell’ensemble alterna un lirismo intimo, talvolta sospeso su fragili linee melodiche, a momenti di swing guizzante, generando una tessitura che sa attrarre tanto l’ascoltatore colto quanto il neofita. Il ruolo di ambasciatrice del jazz islandese, riconosciuto al trio nelle tournée europee e nordamericane, non si esaurisce in un compito di rappresentanza culturale, piuttosto, costituisce la la prova di come un linguaggio universale possa radicarsi in un contesto periferico e da lì proiettarsi su scala globale. In tal senso, Gunnlaugs s’immerge in quella medesima fonte immaginativa da cui hanno attinto figure come Björk ed Emilíana Torrini, dimostrando che l’Islanda, pur nella sua apparente marginalità geografica, continua a offrire un contributo peculiare e prezioso alle avanguardie musicali contemporanee.
Il riferimento dichiarato e fondativo di Sunna Gunnlaugs è il Bill Evans degli anni sessanta, che le rivelò come il pianoforte potesse divenire luogo di introspezione e di poesia sonora. Dalla lezione evansiana ella mutua la predilezione per la cantabilità delle linee, la ricerca di un fraseggio intimista ed una sensibilità armonica che tende a velare, più che ad esibire, la complessità della scrittura. Tuttavia, nella sua declinazione personale, tale impronta non conduce ad un epigonismo manierato, bensì ad una rielaborazione che tiene conto di ulteriori modelli afro-americani, dal lirismo di Keith Jarrett – erede diretto, ma più estroverso e propenso all’improvvisazione a flusso continuo – alla modernità tersa e percussiva di pianisti come Paul Bley e Brad Mehldau, nei quali la libertà formale convive con una forte consapevolezza architettonica. Il confronto fra Sunna Gunnlaugs e Chick Corea, pur avvenendo tra figure appartenenti a generazioni e contesti assai diversi, risulta illuminante per cogliere il modo in cui l’estetica pianistica possa assumere forme opposte partendo da un medesimo linguaggio, quello del jazz moderno. Corea, cresciuto nel pieno del fermento post-bop, costruì la propria identità su un virtuosismo poliedrico e su un’irriducibile curiosità per i linguaggi più disparati: dal free all’avanguardia elettronica, dalla fusion al dialogo con il repertorio classico. La sua scrittura armonica tende ad un cromatismo espanso, spesso fondato su dissonanze brillanti e su improvvise modulazioni che generano tensione drammatica; il fraseggio, energico e scintillante, viene governato da un’irruenza ritmica che riflette un temperamento da costruttore di mutevoli universi sonori. Gunnlaugs si colloca all’opposto, ossia non cerca la vertigine del virtuosismo né l’enciclopedismo stilistico, ma privilegia un minimalismo poetico che fa della sottrazione un valore. Le sue armonie, pur raffinate, tendono a dispiegarsi con lentezza, secondo logiche di attesa e chiarificazione; le modulazioni non sorprendono per spigolosità, ma per la delicatezza con cui si inseriscono nel parenchima melodico. Se Chick guarda a Kandinsky o a Miró – pittori della frattura e della proliferazione formale – Sunna si avvicina ad Hammershøi o a Morandi, artisti della misura e del silenzio eloquente. Sul piano emotivo le differenze sono altrettanto nette. Corea esprime una vitalità centrifuga, che cerca l’espansione continua e il dialogo con l’alterità, dall’incontro con la musica latina alle sperimentazioni elettriche. Gunnlaugs, pur parlando con la tradizione afro-americana, predilige una dimensione raccolta, quasi cameristica, in cui l’intensità nasce dall’intimità piuttosto che dallo slancio spettacolare. Ciò non toglie che vi siano anche punti di contatto. Ad esempio, entrambi concepiscono il trio come spazio relazionale, non come veicolo solistico, ed in entrambi il corredo accordale non si riduce a cornice, ma diventa sostanza drammaturgica del discorso. Tuttavia, laddove Corea tende a concepire il pianoforte come orchestra in miniatura, atto a moltiplicare le voci ed i punti prospettici, Gunnlaugs lo considera piuttosto un narratore discreto, intento a scolpire linee di senso più rare ma non meno pregnanti. In definitiva, Corea e Gunnlaugs sanciscono l’esistenza di due poli complementari: l’uno votato alla proliferazione, all’energia e alla sperimentazione caleidoscopica; l’altra orientata verso l’essenzialità, l’impalpabilità e la sedimentazione lirica. Nel loro confronto si delinea la dialettica stessa del pianismo jazz contemporaneo, oscillante fra ridondanza e sottrazione, fra esplosione e meditazione. L’influenza americana ed afro-americana non si limita ad un codice stilistico, ma investe anche la concezione stessa del trio: l’interplay con McLemore e Jónsson richiama l’approccio paritetico che, a partire da Evans e LaFaro, ha trasformato la sezione ritmica in un interlocutore creativo e non più subordinato. L’elemento ritmico, pur meno travolgente rispetto al vigore di un McCoy Tyner o di un Cecil Taylor, resta decisivo nella sua estetica, dove la pulsazione non viene esasperata, ma filtrata attraverso un senso di misura che conferisce all’insieme una qualità meditativa, senza rinunciare a momenti di slancio. Le affinità con i modelli statunitensi si percepiscono dunque nella concezione armonica sofisticata, nel ruolo dialogico degli strumenti e nella capacità di coniugare lirismo e improvvisazione. Le differenze emergono invece nella sottigliezza timbrica e nella chiarezza formale che Gunnlaugs predilige, quasi a rinfrangere un orizzonte paesaggistico nordico più che il fervore metropolitano americano. Se il jazz afrologico spesso si alimenta di tensione, urgenza e drammaticità, il suo linguaggio preferisce un respiro più evanescente, senza per questo perdere in intensità comunicativa. In tal senso, Gunnlaugs non si pone come semplice erede, ma come mediatrice culturale, poiché attinge al giacimento aurifero afro-americana che ha fatto della libertà esecutiva la propria matrice, ma la trasla attraverso un filtro poetico che le appartiene, coniugando l’opulenza emotiva del jazz statunitense con la levigatezza e la chiarezza di una sensibilità europea e nordica.

La vicenda di Sunna Gunnlaugs, pur inscritta in un’epoca assai distante ed in un habitat diverso, trova un possibile punto di contatto con quella di Jutta Hipp, la pianista tedesca che negli anni cinquanta approdò oltreoceano e divenne la prima donna europea ad incidere per la Blue Note. Se la Hipp rappresentò, nel pieno della stagione hard bop, un’eccezione quasi anacronistica per il suo tempo – non soltanto per la rarità della presenza femminile in una casa discografica che incarnava l’ortodossia afro-americana, ma anche per la capacità di mediare tra influssi europei e l’energia newyorkese – la pianista islandese, a distanza di decenni, sembra rinnovare quel gesto di attraversamento culturale, pur in condizioni radicalmente mutate. Entrambe si muovono lungo una traiettoria di doppia appartenenza: da un lato l’educazione musicale maturata in contesti europei estranei alla tradizione afro-americana, dall’altro l’immersione nella scena statunitense, percepita come fonte di autenticità e di legittimazione. Jutta, cresciuta nella Germania del dopoguerra, si confrontò con il linguaggio be-bop e hard bop tentando di assimilarne il lessico con rigore e rispetto, ma senza abbandonare una certa inclinazione alla nitidezza tematica e alla sobrietà formale. Sunna, a sua volta, pur avendo incontrato il jazz in una fase storica in cui la globalizzazione musicale ne aveva già attenuato le barriere, vive analogamente il rapporto dialettico fra un retroterra europeo segnato da un senso del colore e della misura ed il confronto diretto con la realtà newyorkese, che resta per lei imprescindibile. Le differenze sono però altrettanto significative. Per intenderci, la Hipp rimase spesso confinata in un ruolo marginale, segnata da un percorso esistenziale discontinuo e da un certo isolamento, mentre Gunnlaugs ha saputo consolidare una carriera stabile, costruita su un trio longevo e su una riconoscibilità estetica che ha incontrato ampio consenso internazionale. Laddove la pianista tedesca appariva costretta a collocarsi ai margini di una scena dominata da figure maschili, l’islandese agisce in un’epoca in cui la presenza femminile nel jazz, pur non del tutto paritaria, ha acquisito una maggiore visibilità e legittimità. La possibile relazione tra le due, dunque, non va intesa come continuità diretta, bensì come analogia simbolica, poiché entrambe testimoniano come un’artista europea, e per di più donna, possa confrontarsi con il cuore afro-americano del jazz non in termini di mera imitazione, ma come occasione per elaborare un linguaggio personale, oscillante fra appartenenze culturali diverse. Gunnlaugs, nel suo equilibrio fra limpidezza lirica e tensione improvvisativa, può essere vista come una prosecuzione ideale, più sicura e compiuta, di quella strada precocemente aperta da Jutta Hipp, rimasta per lungo tempo una rara eccezione nella storia del jazz.
L’accostamento fra Sunna Gunnlaugs ed Eugenia Canale consente di delineare un interessante parallelo fra due esperienze che, pur provenendo da contesti geografici e tradizioni culturali differenti, condividono una medesima tensione verso la costruzione di un linguaggio pianistico personale, sospeso fra rigore europeo ed apertura al patrimonio afro-americano. Canale, formatasi in Italia con una solida base classica, ha intrapreso un percorso nel quale l’eredità del jazz statunitense si confronta costantemente con una sensibilità mediterranea, nutrita di cantabilità e di senso narrativo. In Gunnlaugs, l’eco del paesaggio islandese si evidenzia nella trasparenza timbrica e nella predilezione per atmosfere contemplative; in Canale, al contrario, si avverte una radice legata al canto e alla tradizione lirica italiana, che si concretizza in un fraseggio più diretto, intensamente melodico, talvolta persino teatrale. In entrambe, tuttavia, la scelta del trio come nucleo espressivo rappresenta un atto fondante: l’interattività con il contrabbasso e la batteria non è mai mero sostegno, bensì terreno di reciproco ascolto e di costruzione collettiva. Le affinità si riconoscono nella volontà di sottrarre il pianismo femminile a una dimensione ancillare o marginale: sia Gunnlaugs che Canale rivendicano una voce autonoma, riconoscibile, capace di collocarsi accanto ai colleghi uomini senza concessioni. Le differenze si manifestano soprattutto nella temperatura emotiva e nella gamma cromatica. In effetti, la pianista islandese tende ad un minimalismo evocativo, ad un equilibrio calibrato tra lirismo e pulsazione, mentre Eugenia predilige un discorso più denso, in cui la matrice classica italiana si fonde con il lessico jazzistico, generando una tessitura che non teme il pathos. La relazione possibile, dunque, non va cercata in un’influenza diretta, ma in una sorta di convergenza ideale. Esse testimoniano come il jazz europeo contemporaneo non si limiti ad importare modelli americani, ma riesca a generare idiomi diversi, specchio delle culture d’origine. In questo senso, Gunnlaugs e Canale si offrono come due declinazioni complementari di un medesimo processo di assimilazione e trasformazione, capace di rendere il pianismo jazzistico femminile non più un’eccezione, ma una presenza pienamente legittima e autorevole.
Nella parabola discografica di Sunna Gunnlaugs vi sono alcuni titoli che non soltanto segnano momenti cruciali della sua maturazione artistica, ma offrono altresì l’occasione per cogliere le sfumature del suo pensiero musicale in rapporto ad un orizzonte estetico più ampio, che abbraccia le arti visive, la letteratura e persino il paesaggio naturale come fonte di risonanza interiore. «Far Far Away» (1996), concepito nel fervido clima newyorkese degli anni novanta, reca ancora l’urgenza di un apprendistato ed il desiderio di misurarsi con un vernacolo che sembrava quasi mitico per una giovane pianista cresciuta alle soglie dell’Artico. Le strutture armoniche, pur ancorate a moduli riconoscibili, già rivelano una tensione alla leggerezza e ad una pulizia formale che allude alla pittura nordica di un Vilhelm Hammershøi, dove le superfici sobrie ed i vuoti eloquenti valgono quanto le presenze. L’emozione si esprime in una mobilità febbrile, come un diario di viaggio che alterna pagine di slancio e momenti di di indagine interiore. Con «Mindful» (2002) la scrittura diviene più riflessiva, meno incline all’immediatezza giovanile e più attenta ad un equilibrio di pesi e misure. Le progressioni armoniche sono costruite con una cura quasi mercuriale, ma non vi è alcun compiacimento cerebrale, tanto che la musica conserva un respiro narrativo che può essere accostato al romanzo psicologico europeo, dove l’azione appare ridotta al minimo e tutto si gioca nelle pieghe della coscienza. La dimensione emotiva non risulta gridata, bensì suggerita, come nei gesti minuti che nei quadri di Vermeer condensano universi interiori. In «Long Pair Bond» (2011) il dialogo con Scott McLemore si fa elemento centrale. La relazione fra pianoforte e batteria non ha qui nulla di accessorio, ma si sviluppa come un vero contrappunto di timbri ed intenzioni. Il titolo stesso evoca un vincolo duraturo, e la musica sembra dar forma a una sorta di coreografia sonora, dove le pause, i silenzi, gli accenti misurati acquistano il valore di passi e sospensioni in una danza. L’armonia tende a rarefarsi, i giri tradizionali si dilatano, mentre l’emozione nasce da una delicatezza trattenuta, simile a quella di una poesia haiku, capace di condensare un intero paesaggio in pochi segni essenziali. «Ancestry» (2013) porta la riflessione su un piano più identitario. I riferimenti alla terra d’origine si fanno impliciti ma percepibili, come se i modi armonici e le linee melodiche custodissero un’eco di canti popolari islandesi, filtrati attraverso il prisma del jazz. L’emozionalità qui si avvicina a una forma di memoria collettiva, a una nostalgia che non indulge mai nel sentimentalismo. Vi si potrebbe cogliere un parallelo con la letteratura islandese contemporanea, che sa rielaborare i miti arcaici con linguaggio moderno, mantenendo intatta la forza evocativa delle origini. La scrittura pianistica, limpida e calibrata, diviene un ponte tra dimensione individuale ed appartenenza comunitaria. Infine, «Becoming» (2020) appare come il compendio di un percorso, un concept in cui la Gunnlaugs si rivela ormai padrona di un idioma personale, capace di equilibrare lirismo e vigore ritmico senza scivolare né nel manierismo né nella prevedibilità. La materia accordale si fa più sfumata, le progressioni modulano con naturalezza, e l’emozione si afferma come processo, non come dato immediato, al punto che si ha l’impressione di assistere a una metamorfosi sonora, analoga a quelle descritte dalle arti figurative contemporanee, dove l’immagine muta sotto lo sguardo dello spettatore. Il senso di divenire, suggerito dal titolo, rimanda a una condizione esistenziale oltre che estetica, come se la musica fosse lo spazio in cui l’identità si trasforma e si rinnova. Attraverso queste tappe, la pianista islandese ha saputo conferire al jazz un carattere che non rinuncia alle radici afro-americane, ma le rifrange con una sensibilità propria, capace di colloquiare con il paesaggio, la pittura, la poesia, trasformando ogni album in un atto estetico totale, un’esperienza che travalica i confini del genere per avvicinarsi ad una forma d’arte compiuta.