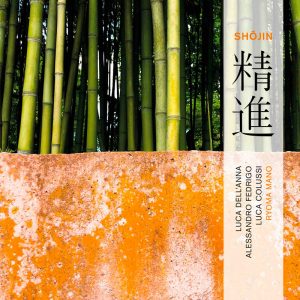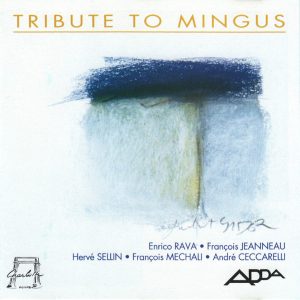Ted Hearne, compositore americano fa dialogare due culture: «Over and Over Vorbei nicht Vorbei»

In questo modo, il compositore indaga ricordo ed eventuali sensi di colpa collettivi, interrogandosi e interrogando su come la Germania ha affrontato nel suo presente e nel suo recente passato la Shoah e la violenza nazista. E su come gli Stati Uniti abbiano affrontato la schiavitù…
// di Gianni Morelenbaum Gualberto //
Cosa ricordiamo e come? Chi e cosa modellano la nostra memoria? Come possiamo ricordare eventi in cui non siamo stati coinvolti? E quale influenza ha la memoria sul presente e sul futuro? Ted Hearne, brillante e inventivo compositore americano, fra i più interessanti talenti della sua generazione (è nato nel 1982), va oltre e in “over and over vorbei nicht vorbei” affronta il processo individuale e collettivo del ricordo facendo dialogare due culture (quella tedesca e quella americana) su altri interrogativi: come le società affrontano la violenza del loro passato? E come le nuove generazioni guardano ai crimini dei loro antenati?
Fra opera e, come spesso accade nei lavori teatrali di Hearne, oratorio e cantata, l’autore rende credo ben cosciente omaggio all’arte di Kurt Weill, soprattutto quella inizialmente affermatasi negli Stati Uniti con “Johnny Johnson” e poi proseguita con “Street Scene” e “Lost in the Stars”. Frammenti di canzoni d’amore popolari (come “Stop! In the Name of Love” e “Das ist die Frage aller Fragen”) e di canzoni “intossicate” dall’ideologia mortifera (“Vörwarts! Vörwarts!”, inno della gioventù hitleriana, e “I Wish I Were in Dixie’s Land”, pagina celebre del minstrelsy americano e della sua parodia degli africano-americani) provenienti dal passato americano e da quello tedesco sono combinati in un’unica narrazione.
In questo modo, il compositore indaga ricordo ed eventuali sensi di colpa collettivi, interrogandosi e interrogando su come la Germania ha affrontato nel suo presente e nel suo recente passato la Shoah e la violenza nazista. E su come gli Stati Uniti abbiano affrontato la schiavitù, la sua effimera fine nel 1865 e la successiva Segregazione, come si sono posti nei confronti delle conseguenze e della continuazione del razzismo negli Stati Uniti. Soprattutto, egli si chiede come le nuove generazioni dovrebbero affrontare i crimini dei loro antenati.
L’uso di canzoni d’amore intende evidenziare “i contesti di colpe e di responsabilità, di vittime e di carnefice”, mentre il recupero di canzoni che avremmo forse dovuto dimenticare sottolinea l’umanità condivisa nell’orrore cosciente e perpetrato senza tentennamenti e lo smarrimento comune e collettivo di valori morali. Con disposizioni, sovrapposizioni e ripetizioni sempre diverse, i frammenti di testo si pongono in relazioni sempre nuove tra loro. Emergono connessioni che vengono costantemente scomposte ed evidenziate, per poi formarsi nuovamente in modo diverso. Lo smarrirsi e forse il ritrovarsi come umanità e come individui è il filo conduttore di un lavoro non privo di asprezze poetiche e che unisce voci e etnie di generazioni diverse: i cantanti statunitensi Eliza Bagg e Isaiah Robinson affiancano un interprete stabile della Komische Oper Berlin, Tom Erik Lie, e il coro giovanile berlinese dei Vokalhelden (fondato dai Berliner Philharmoniker nel 2013): essi sono accompagnati da un ensemble di strumentisti provenienti da diversi contesti stilistici sia americani che tedeschi, che creano una partitura che si affida fortemente alla musica elettronica. Le linee vocali attingono alle tradizioni popolari e operistiche, occasionalmente modificate dall’elaborazione vocale. Le armonie sono dense, i ritmi spesso meccanici, la polifonia si sviluppa accanto al groove, una sorta di indignazione mal trattenuta conferisce alla pagina una vitalità feroce.