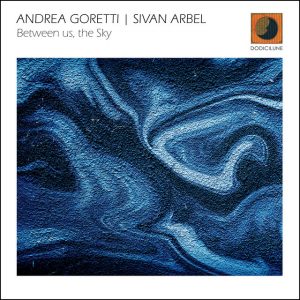«The Final Tour, Miles Davis & John Coltrane, Copenhagen, March 24, 1964»: due genialità già separate in casa

Le esecuzioni contenute nell’album sono un ibrido tra lo stile del primo storico quintetto davisiano ed i materiali solisti di Coltrane. Solo un anno dopo la sua incisione su vinile, «So What», viene restituita con un tempo notevolmente aumentato, passando dalla carezzevole passeggiata dalla versione originale a qualcosa di più teso ed oscuro, in cui Trane dà l’idea di essersi liberato dalle catene e dalle imposizioni del suo band-leader. A volte non sembra neppure che i due suonino sullo stesso palco.
// di Francesco Cataldo Verrina //
All’inizio del 1960, dopo aver registrato «Giant Steps» nel 1959, John Coltrane era pronto a intraprendere la sua carriera solista, lasciando il Miles Davis Quintet. La storia narra che il sassofonista non fosse entusiasta di prolungare il suo impegno con Davis per partecipare al faticoso tour europeo del Jazz At The Philharmonic, organizzato da Norman Granz, con diciannove date – escluso il Regno Unito – tra il 21 marzo e il 10 aprile. Si racconta che Miles avesse avuto non poche difficoltà a convincere Coltrane ad accettare l’ingaggio e che quest’ultimo alla fine si fosse arreso dopo molte insistenze e qualche incentivo economico da parte di Granz.
Gli operatori radiofonici europei si fecero trovare pronti per documentare e registrare le varie esibizioni, mentre il pacchetto turistico di Granz – Davis più l’Oscar Peterson Trio e lo Stan Getz Quartet – si fece onore attraverso Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Svizzera, Austria e Paesi Bassi. Nella maggior parte delle date la troupe al completo suonava in due locali e, poiché venivano coinvolti tutti e tre i gruppi contemporaneamente, i set erano limitati a circa quattro o cinque esecuzioni al massimo. In totale, The Final Tour raccoglie due spettacoli del 21 marzo all’Olympia Theater di Parigi, due live della notte successiva al Konserthuset di Stoccolma ed uno ripreso al Tivolis Koncertsal di Copenaghen tre giorni dopo: il fatico 24 marzo, a cui si riferisce la registrazione in oggetto. Il suono risulta impeccabile e le performance decisamente frenetiche, ma comunque convincenti. Il pubblico europeo, che sie era confrontando con recenti pubblicazioni di «Workin’ With The Miles Davis Quintet» (Prestige), uscito a febbraio di quell’anno e «Kind Of Blue» dato alle stampe nell’ottobre 1959, potrebbe aver percepito un cambiamento ed un lieve senso di smarrimento. Si nota, infatti, una certa frammentazione e alcuni atteggiamenti obliqui e fuorvianti, forse dovuti a un’evidente stanchezza verso un repertorio consolidato e risuonato più volte negli ultimi cinque anni. Nel concerto di Copenaghen del 24 marzo 1960, le composizioni sembrano subire una vera e propria decostruzione, rivelando un’intenzione a sperimentare e di andare oltre i confini della forma canzone. Come già accennato, Trane aveva già superato il concept sonoro davisiano del periodo, spinto oltremodo dalla necessità di ripulirsi, liberandosi dalla dipendenza e dall’uso di eroina. Non a caso, prima di riunirsi nuovamente a Miles, aveva tentato di dare una svolta alla carriera lavorando al soldo di Thelonious. La seconda e ultima adesione all’organico di Davis ebbe qualche risvolto differente: Trane si trasformò in una star, forte di un sostanzioso contratto stipulato nel 1958 con la Atlantic Records, mentre nell’aprile 1959, un mese dopo la prima sessione di registrazione di «Kind of Blue», aveva varcato l’uscio dell’Atlantic Studio di New York per iniziare a registrare le tracce di «Giant Steps», le quali avrebbero sancito un fulminante debutto per l’etichetta di Ahmet Ertegün e Herb Abramson. Le sessioni proseguirono per tutto l’anno solare, durante le quali Trane fissò su nastro anche materiale per l’album «Coltrane Jazz», un valido esercizio preparatorio allo «shape of Trane to come», parafrasando Ornette Coleman. Questi album lo aiutarono, comunque, a costruire ulteriormente una base di consenso personale, al netto delle varie collaborazioni come sideman. Ciononostante, durante lo stesso periodo, continuò ad incidere e suonare con Miles, imbarcandosi nel suddetto tour europeo.
Tutto ciò aiuta a comprendere come mai nel primo solco di questo disco, che cattura uno dei concerti già pubblicati come «The Final Tour: The Bootleg Series, Vol. 6», l’impresario jazz Norman Granz presenti tutti i musicisti, ottenendo applausi per ogni nome pronunciato, ma quando scandisce il nome di Coltrane, la folla impazzisce, applaudendo molto di più, se non altrettanto di quanto faccia per Miles. Le esecuzioni contenute nell’album sono un ibrido tra lo stile del primo storico quintetto davisiano ed i materiali solisti di Coltrane. Solo un anno dopo la sua incisione su vinile, «So What», viene restituita con un tempo notevolmente aumentato, passando dalla carezzevole passeggiata dalla versione originale a qualcosa di più teso ed oscuro, in cui Trane dà l’idea di essersi liberato dalle catene e dalle imposizioni del suo band-leader. A volte non sembra neppure che i due suonino sullo stesso palco. Con Miles solista in prima linea, il line-up evoca un’edizione vagamente più spigliata di coloro che, un anno prima, avevano realizzato «Kind of Blue», ma il loro modus operandi risulta ancora riconoscibile, mentre quando Trane si fa avanti, la performance collettiva prende fuoco. Coltrane aveva appena iniziato a superare le esplorazioni incentrate sugli accordi rintracciabili nelle sue modeste sedute per la Prestige, convertendole in escursioni più spirituali: la medesima sensazione si avverte durante il live di Copenaghen. Sebbene non ci siano divagazione eccessive o strilli perforanti, suoni che, presto, sarebbero arrivati a definire i confini esterni della sua perlustrazione pentecostale e trascendente, emergono altri marchi di fabbrica ed avvisaglie del suono coltraniano in divenire: l’abbandono del cool, l’andare oltre i confini del chorus da otto battute, l’uso di scale modali come veicolo per il carotaggio spirituale e, naturalmente, gli «sheets of sound» a cascata, in cui diventava difficile cogliere le singole note durante le sue corse tese alla ricerca di qualcosa di inedito, che potesse andare oltre i confini dell’improvvisazione di routine.
In superficie, «On Green Dolphin Street» si sostanzia come un veicolo fatto a posta per lo scandaglio di di Trane. La composizione, di Bronisław Kaper con testi di Ned Washington, era un tema cinematografico della MGM del 1947, quindi per lo più dimenticato fino a quando il sestetto di Miles non lo resuscitò in una registrazione nel 1958, a cui seguirono versioni del trio di Bill Evans, Wynton Kelly ed Eric Dolphy, le quali ne fecero uno standard jazz. Nell’esecuzione di Trane, però, sparisce il tipico modulo improvvisativo, mentre il sassofonista prende il volo ad ali spiegate. Dopo questo tour, Trane sarebbe tornato in studio con il gruppo di Miles ancora una volta. Ciononostante il figliol prodigo aveva abbandonato spiritualmente la «casa del padre», inoltrandosi verso altre latitudini sonore, che da lì a qualche tempo lo avrebbero consacrato nel fenomeno più importante e rivoluzionario del jazz del secondo dopo guerra. La versione in vinile del The Final Tour si configura come un specie artefatto, ossia costruito ad arte, nel quale è stato inserito materiale di una delle esibizioni europee, con «On Green Dolphin Street» diviso sui due lati del disco. Una pubblicazione più completa del tour è reperibile in «The Bootleg Series Vol. 6: Miles Davis & John Coltrane, The Final Tour» che, oltre al concerto di Copenaghen, accorpa altre take provenienti dall’Olympia di Parigi e dal Konserthuset di Stoccolma. L’album ha conservato esattamente lo stesso contenuto e, praticamente, il medesimo design dell’art work della ristampa di qualche anno prima su etichetta Gambit. La rimasterizzazione risulta leggermente più brillante, superando la qualità air-shot (registrazione radiofonica). In sintesi, il contenuto documenta un Coltrane che si allontana dal modulo classico, pur rimanendo nello spazio a lui concesso in «So What», «On Green Dolphin Street» e «All Blues», ognuno della durata di quasi quindici minuti.
La data del 24 marzo a Copenaghen, su LP da 180 grammi, non è solo emozionante, ma la qualità del suono risulta straordinaria e vibrante come quasi tutti gli album dal vivo nel catalogo di Miles. La vera differenza affiora dall’inedito modulo di John Coltrane, almeno fino a quel momento. La rivoluzione modale di Miles aveva allentato il suo stile, ma Trane, ansioso di decollare verso nuove orbite, trasformando i suoi «fogli di suono» in schegge e tempeste di fuoco, in questo disco, aumenta notevolmente l’assertività, tanto che i suoi assoli si mostrano lunghi e dilatati, mentre le sue linee melodiche si estendono chorus dopo chorus, con un tono a volte furioso. Le barre pur essendo suddivise in frammenti da 32 note, Trane le riadatta ai quei motivi familiari, suonando, in definitiva ciò che aveva a portata di mano, ma facendolo come nessuno avrebbe potuto immaginare e, tanto meno, sentito prima. Il contrasto risulta elettrizzante: Miles si culla ancora nel suo fraseggio «camminando sulle uova», mentre il line-up si sposta con puntiglio ed eleganza. Paul Chambers e Jimmy Cobb sono ancora l’asse portante della band, ma Wynton Kelly, che aveva suonato una sola traccia in «Kind Of Blue», stava colmando a tempo pieno il vuoto lasciato al pianoforte da Bill Evans, mentre lo slot dell’alto sax, un tempo ad appannaggio di Cannonball Adderley, era rimasto scoperto. Il quello scenario, però, il resto della compagine si allunga progressivamente, debordando: Cobb fa roteare i piatti più del solito, Chambers entra con l’arco e Miles – per metafora – inizia a calpestare anche alcune delle uova di cui sopra Altri quattro anni sarebbero passati prima che il trombettista – che si era fatto una reputazione, prima e dopo, come un innovatore irrequieto, persino un rivoluzionario – potesse riunire un altro organico seminale dotato di un’energia così contagiosa e rinnovabile. Fortunatamente la storia celebra anche un suo «secondo grande quintetto», con Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al basso, Tony Williams alla batteria ed, infine, Wayne Shorter subentrante al sassofono tenore: Shorter era stato stato il discepolo ideale di Coltrane e l’uomo che, nel 1960, egli aveva raccomandato a Miles quale suo sostituto.