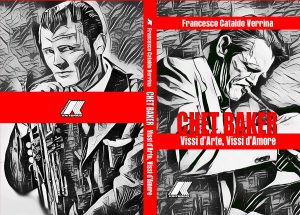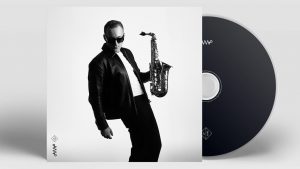Tra Kansas City e New York: Jimmy Rushing e la vocalità afroamericana del Novecento

Jimmy Rushing
La sua potenza interpretativa non era riducibile a mera forza sonora, Rushing padroneggiava infatti un fraseggio elastico, capace di innervarsi nelle pieghe ritmiche dell’orchestra con una precisione che gli derivava, verosimilmente, dalla sua originaria formazione strumentale.
// di Francesco Cataldo Verrina //
James Andrew Rushing (1901-1972) occupa una posizione eminente nella storia del canto afroamericano del Novecento, riconosciuto come una delle voci paradigmatiche del blues e dello swing. La sua notorietà si deve in primo luogo alla lunga militanza presso l’orchestra di Count Basie, dal 1935 al 1948, durante la quale la sua voce divenne uno dei tratti identitari del linguaggio basiano; meno frequentemente si ricorda come egli fosse anche un pianista di discreto valore, circostanza che emerge in alcune testimonianze filmiche e che aiuta a comprendere la sua sensibilità ritmico-armonica. Originario di Oklahoma City, veniva affettuosamente soprannominato «Mr. Five by Five», formula che alludeva con ironia alla sua corporatura imponente e che, nel contempo, contribuì a costruire una sorta di maschera scenica dietro cui si celava una personalità artistica di grande raffinatezza.
Il percorso di Rushing attraversa nodi cruciali della storia del jazz. Dopo l’ingresso, nel 1927, nei Walter Page’s Blue Devils, egli approdò nell’orchestra di Bennie Moten, per poi transitare, alla morte del leader, sotto la guida di Count Basie. In quel contesto la sua vocalità, collocata in un registro oscillante tra il baritono ed il tenore, s’impose con un’energia trascinante, tale da conferirgli il ruolo di voce emblematica dell’ensemble. La sua potenza interpretativa non era riducibile a mera forza sonora, Rushing padroneggiava infatti un fraseggio elastico, capace di innervarsi nelle pieghe ritmiche dell’orchestra con una precisione che gli derivava, verosimilmente, dalla sua originaria formazione strumentale. La definizione di Dave Brubeck, che lo proclamò «il papà di tutti i cantanti di blues», coglie bene la funzione genealogica della sua figura: Rushing fu, in effetti, un punto di riferimento imprescindibile per le generazioni successive di vocalist, che in lui riconobbero un modello di equilibrio fra radici popolari e sofisticazione jazzistica. Registrazioni quali «Going to Chicago» e «Harvard Blues» restano tra i momenti più rappresentativi della sua arte, così come la sua adesione allo stile del Kansas City jump blues, ereditato dall’orchestra di Moten e trasfigurato nelle celebri incisioni con Basie, da «Sent For You Yesterday» a «Boogie Woogie». La parabola artistica non si esaurì con l’uscita dall’orchestra basiana. Negli anni Cinquanta e Sessanta Rushing intraprese una carriera solistica di notevole rilievo, incidendo per diverse etichette e mostrando una sorprendente capacità di adattamento a contesti diversi, senza mai tradire la cifra originaria della sua vocalità. Memorabile anche la collaborazione con Duke Ellington per «Jazz Party» (1959), che restituì al pubblico l’immagine di un artista capace di inserirsi in universi orchestrali differenti, portando con sé l’inconfondibile vitalità della propria voce. La sua parabola si interruppe bruscamente nel 1971, quando gli fu diagnosticata una leucemia che lo condusse alla morte l’8 giugno dell’anno successivo a New York.
In Rushing s’incontrano la tradizione orale del blues, l’immediatezza comunicativa delle forme popolari e la consapevolezza formale del jazz orchestrale. La sua voce, al tempo stesso vigorosa e modulata, capace di alternare l’esuberanza declamatoria a momenti di lirismo più raccolto, continua a rappresentare una delle testimonianze più alte della trasfigurazione del blues in linguaggio moderno, incarnando quella funzione di ponte fra mondi e generazioni che solo i grandi interpreti riescono a svolgere. Un confronto con altri interpreti coevi permette di illuminare per contrasto i tratti peculiari di Jimmy Rushing e, al tempo stesso, di collocarlo entro un roster di cantanti blues e jazz che negli anni Trenta e Quaranta contribuirono a definire il lessico vocale afroamericano. Tra le figure più affini si colloca Big Joe Turner, con cui condivide l’appartenenza alla scena di Kansas City. Entrambi provenivano dall’humus del territory jazz e del jump blues, ma se Rushing privilegiava un fraseggio più controllato, sostenuto da un senso quasi orchestrale della scansione ritmica, Turner incarnava l’estroversione dello shouter, capace di farsi sentire sopra il frastuono delle sezioni di fiati e del pianoforte boogie-woogie. Rushing, rispetto a Turner, si distingueva per una gamma espressiva più sfumata, con un passaggio naturale dal registro baritonale a quello tenorile che gli consentiva d’intessere melodie più plastiche, meno urlate e più cesellate. Un parallelo interessante può essere tracciato con Joe Williams, che pure fu successore di Rushing nell’orchestra di Count Basie. Williams, sebbene erede diretto di quella tradizione, possedeva una vocalità più vellutata, intrisa di eleganza crooneristica, quasi proiettata verso il linguaggio del jazz moderno e della canzone d’autore. Rushing, al contrario, incarnava la potenza primaria del blues, con una timbrica calda ma ruvida, priva di orpelli, che restituiva una fisicità sonora immediata. In questa differenza si riflette anche la trasformazione del gusto. Non a caso, dagli anni Trenta al dopoguerra, il pubblico richiedeva progressivamente più raffinatezza formale, ed è proprio nella tensione fra queste due modalità che si misura la continuità tra i due cantanti. Altra figura con cui confrontare Rushing potrebbe essere Jimmy Witherspoon, la cui carriera si impose negli anni Quaranta. Witherspoon, pur debitore dell’estetica di Kansas City, sviluppò un fraseggio più vicino al parlato, con una capacità di sospendere il tempo e di colmare i vuoti ritmici. Rispetto a lui, Rushing appariva più ancorato alla spinta propulsiva dell’orchestra, meno incline al laid-back che sarebbe divenuto tipico dello cool. Non si possono trascurare, per completare il quadro, interpreti come Billie Holiday o Jimmy McPhail, sebbene stilisticamente distanti. Holiday, in particolare, rappresentava l’opposto complementare, ossia una voce fragile, intimista, giocata sulle inflessioni minime e sul tempo ritardato, mentre Rushing incarnava l’energia collettiva, la forza del coro tradotta in solista. Entrambi, tuttavia, condividono la medesima capacità di trasfigurare la materia del blues in arte espressiva, dimostrando come la voce potesse diventare strumento di invenzione pari al sassofono o alla tromba. In sintesi, le affinità di Rushing con Turner o Witherspoon sottolineano la comune radice del blues shouting, ma le differenze evidenziano la peculiarità di un cantante che sapeva integrarsi in maniera organica alla compagine orchestrale, senza mai rinunciare alla vitalità del blues. L’originalità di Rushing si manifesta proprio in questo equilibrio, ossia il saper essere voce di una big band ed, insieme, custode di una tradizione che affondava nelle radici più arcaiche della cultura afroamericana.
Cinque «dischi–soglia» per entrare nell’officina di Jimmy Rushing, ciascuno accompagnato da un’interpretazione emblematica. «The Decca Years (1937–1941) – Count Basie & Jimmy Rushing» rappresenta uno scrigno imprescindibile delle sedute con Basie, restituendo la fioritura del Kansas City sound e il ruolo di Rushing come voce-strumento. «Goin’ to Chicago Blues» e «Sent For You Yesterday (And Here You Come Today)» mostrano l’arte della microintonazione: appoggiature elastiche, glissandi misurati, uso consapevole del back phrasing per sospendere la battuta e poi rientrare sul four con autorità. Il timbro, largo e granitico, si colloca tra baritono e tenore con passaggi di registro rifiniti da lievi growl e consonanti percussive che incastrano la scansione della rhythm section. «Harvard Blues» offre un manuale di prosodia bluesistica, con sillabe posate come pedine ritmiche, semi–parlato che increspa la linea e la rende colloquiale senza perdere nobiltà. Ragionando per immagini, il pensiero va a John Ford ed alle sue architetture corali. La voce di Rushing, dunque, come figura in primo piano che tuttavia appartiene al paesaggio, non lo domina ma lo fa vibrare. «The Jazz Odyssey Of James Rushing, Esq.» (Columbia, 1957) rappresenta il ritratto di una maturità che trasferisce l’energia dello shouter in un contesto calibrato, quasi cameristico per equilibrio timbrico. Le letture lenticolari delle ballad evidenziano l’abilità nel portamento, con attacchi su fiato, chiusure smorzate e vibrato corto impiegato come segno d’interpunzione più che come ornamento. La dizione, priva di enfasi superflue, mette in rilievo il peso semantico delle parole; ogni vocale allungata diventa una lieve dilatazione metrica. Si avverte una consapevolezza architettonica classica come nei romanzi di Henry James, in cui la narrazione avanza per sottili slittamenti prospettici, mai per colpi di teatro.
«Little Jimmy Rushing And The Big Brass» (Columbia, 1958) è l’album che mette la voce a contatto con una compagine di ottoni dal taglio lucente. Le interpretazioni medio–veloci sono un laboratorio di time feel, dove Rushing poggia avanti sul tempo quel tanto che basta per generare spinta, poi arretra di mezza sillaba nelle code, creando una frizione elastica con i riffs dei fiati. Nei shout choruses l’emissione resta larga ma controllata, con attacchi netti su consonanti occlusive a scolpire la pulsazione, quasi un montaggio alla Hawks, fatto dialoghi rapidi ed incastri millimetrici, dove la brillantezza dell’ottone non soffoca il parlato, ma lo incornicia. «Brubeck And Rushing» (Columbia, 1960) nasce dal fertile incontro fra la geometria ritmica del quartetto di Brubeck e la cantabilità tellurica di Rushing. Le letture di standard bluesy e medium consentono di osservare come la voce si collochi dentro griglie armoniche più moderne, intelaiate su rubati brevissimi come cerniere fra cadenze plagal–dominanti, appoggi su estensioni di nona e undicesima lasciate affiorare dal pianoforte, fraseggio che dialoga con gli spigoli metrici brubeckiani senza irrigidirsi. Emerge un’arte del contrasto controllato, fatto di lucidità apollinea nell’accompagnamento e calore dionisiaco nell’emissione. Per analogia letteraria, una pagina di T.S. Eliot dove il fuoco emotivo è tenuto dentro una forma tersa. «The You and Me That Used to Be» (Bluesway, 1970) costituisce il testamento poetico che non cede al manierismo. Il tempo lento mette a nudo una tecnica respirazione profonda, frasi ampie cesellate da micro–rubati, consonanti spazzolate per non interrompere il legato; l’uso parsimonioso del vibrato conferisce gravità più che languore. Timbro scurito, grana più ruvida ma intonazione ancora ferma, tanto che la voce sta sulla nota con una consapevolezza drammatica che ricorda certi tardi monologhi di Orson Welles, dove ogni pausa pesa come un’inquadratura allungata, mentre l’eloquenza diventa etica del suono: niente effetto, soltanto verità fonica. Dalle registrazioni Decca con Count Basie al congedo con «Bluesway», il filo conduttore viene rappresentato dalla centralità del ritmo come principio organizzatore. Le interpretazioni più rappresentative mostrano tre tratti strutturali: controllo millimetrico del placement sillabico (la consonante come leva metrica); gestione sapiente dei registri con passaggi mascherati per addolcire gli acuti ed appoggi toracici asciugati per dare corpo ai medium; rapporto contrappuntistico con l’orchestra, mai semplice o solo sopra, ma voce che attiva e modifica il moto interno degli strati strumentali. Ne deriva una poetica della presenza, ossia Rushing non decora, ma innerva. Come in certo cinema classico, dove la star è al centro, tuttavia l’inquadratura continua a raccontare l’insieme.
Il giudizio di Nat Hentoff, che lo annoverava fra i «più grandi cantanti blues», riconoscendone un ruolo di catalizzatore nello sviluppo della musica afroamericana del dopoguerra, colloca Jimmy Rushing entro una genealogia in cui la voce non è soltanto strumento espressivo, ma anche veicolo di trasformazioni culturali. La sua capacità di incarnare, con immediatezza e autorevolezza, l’eredità del blues delle origini e di trasporla nel linguaggio del jazz orchestrale ne fece un modello per intere generazioni di interpreti, sino alle declinazioni più urbane del rhythm and blues nascente. Tale statura artistica trovò riscontro non solo nella memoria critica ma anche in riconoscimenti concreti. Rushing ottenne per quattro volte il titolo di Best Male Singer nei referendum di Melody Maker, ed altrettante volte nello stesso concorso organizzato dal Down Beat. Premi che non vanno letti come semplici attestati di popolarità, bensì come segni tangibili della sua centralità in un’epoca di transizione, quando il canto jazzistico cercava nuove modalità per confrontarsi con il mutato paesaggio musicale del dopoguerra. Un episodio particolarmente significativo resta la designazione, da parte di Down Beat, dell’album «The You And Me That Used To Be» (1970) come Jazz Album Of The Year, da intendersi non un riconoscimento tardivo o meramente celebrativo, ma la prova che, fino agli ultimi anni della sua carriera, Rushing rimase in grado di parlare con voce autentica ad un pubblico che si era ormai avventurato in territori sonori molto diversi da quelli degli anni Trenta. In quelle tarde interpretazioni, la materia blues non si presentava come reliquia, bensì come sostanza viva, duttile, capace di conservare intatta la sua forza emotiva ed, al contempo, di dialogare con un contesto estetico ormai trasformato. In questa traiettoria, i premi e gli encomi non rappresentano semplici corollari biografici, piuttosto essi attestano il permanere di un’autorità artistica che non si è mai prostituita al manierismo, ma che ha saputo riaffermarsi di volta in volta come necessità espressiva. Rushing rimane così figura paradigmatica non solo del blues shouting ma, più in generale, di una concezione della vocalità jazzistica come gesto drammaturgico, in grado di tenere insieme memoria collettiva ed invenzione individuale.