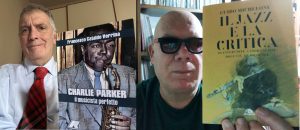Il suono che pensa: Evan Parker e l’improvvisazione come forma di sapere

Evan Parker
L’opera di Evan Parker si rivela nella sua natura molteplice e cangiante, ossia non uno sviluppo lineare, ma una spirale; non una biografia, ma un paesaggio psicoacustico in perenne mutazione, in cui il respiro diventa forma, il timbro pensiero, l’improvvisazione una filosofia incarnata.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Giungendo al mondo nella Bristol ancora segnata dai riverberi del secondo conflitto mondiale, il 5 aprile 1944, Evan Parker si avvicina alla musica in un’età in cui l’orecchio comincia appena a distinguere le sfumature dell’intenzione espressiva. L’incontro con il sassofono, attorno ai quattordici anni, non assume in lui i tratti di un’adesione mimetica ad un modello stilistico precostituito, bensì quelli più inquieti e germinanti di una fascinazione sonora che, pur trovando in Paul Desmond e John Coltrane i primi numi tutelari, non si arresta nella reverenza, ma s’insinua, già in nuce, in una volontà di oltrepassare, di slittamento percettivo e di alterazione dei confini fonici.
Iscrittosi nel 1962 alla facoltà di botanica presso l’università di Birmingham, Parker sembra inizialmente accogliere la prospettiva di un sapere razionalmente classificatorio, ancorato all’osservazione sistemica della natura. Tuttavia, un viaggio a New York – metropoli allora in piena effervescenza afro-sonora e laboratorio informale dell’avanguardia improvvisativa – determina in lui una discontinuità biografica ed epistemologica. La musica, da passione a vocazione totalizzante, reclama il primato assoluto; la botanica, pur non del tutto espunta dalla sua sensibilità analitica, si ritira in un angolo remoto del pensiero. Ritornato in patria, abbandona senza tentennamenti l’ambiente accademico e si trasferisce nel 1966 a Londra, scegliendo come crogiolo esperienziale il Little Theatre Club, uno spazio liminale in cui i margini tra teatro, musica e gesto performativo si confondevano nel nome di un’improvvisazione assoluta, non idiomatica ed anti-retorica. Attraversando con rigore quasi ascetico la galassia in fermento della scena free londinese, Parker partecipa attivamente alla formazione di un linguaggio collettivo che rifiuta sia l’imitazione del jazz afroamericano tout court sia la cristallizzazione eurocentrica della musica contemporanea. La sua traiettoria si configura, da subito, come una lunga interrogazione sulla possibilità stessa del suono, sull’identità del respiro, sulla torsione della linea melodica. La respirazione circolare, praticata con dedizione quasi monastica, non costituisce per lui un mero virtuosismo tecnico, bensì una strategia fenomenologica di dilatazione temporale, un artificio corporeo per sfuggire alla tirannia del silenzio obbligato, un’utopia acustica che ambisce a sospendere il divenire.
All’interno di tale orizzonte, la sperimentazione parkeriana si spoglia progressivamente di ogni vezzo narrativo, concentrandosi su strutture microcellulari, su processi di proliferazione timbrica, su arabeschi sonori che ricordano, più che certe pagine del jazz canonico, le incisioni di Escher, i paesaggi ipnotici di Piranesi o le costruzioni linguistiche di Samuel Beckett. I suoi assoli, specialmente quelli al sax soprano, evocano flussi ininterrotti che sfidano la linearità, moltiplicando simultaneità percettive e ambiguità formali. Una vera e propria scrittura del corpo che rifiuta la grammatica e istituisce, nella frizione tra fiato e metallo, un alfabeto visionario. Collaboratore instancabile, e tuttavia mai gregario, di figure centrali dell’improvvisazione europea quali Derek Bailey, Paul Lytton, Alexander von Schlippenbach, Barry Guy, Parker si colloca in una dimensione di co-autorato permanente, in cui l’ego solistico si dissolve in una pratica dell’ascolto radicale. Tale postura etica, oltre che estetica, lo distingue nettamente da molte derive solipsistiche del jazz contemporaneo, restituendo alla musica improvvisata quella tensione comunitaria che la lega, come nella riflessione del filosofo francese Jean-Luc Nancy, alla nozione di «essere-con».
Nel corso dei decenni, pur attraversando mutazioni stilistiche, dialoghi transgenerici ed ibridazioni elettroacustiche (si pensi alle esperienze con il gruppo Electro-Acoustic Ensemble), l’arte di Parker ha mantenuto una coerenza interna ferrea, una fedeltà intransigente ad una visione sonora che affonda le sue ragioni nel respiro stesso come materia plastica, nella complessità del tempo come flusso indeterminato, nella performatività come gesto irripetibile. In tal senso, la sua musica si colloca in un’interzona tra l’ascolto e la contemplazione, tra la scrittura ed il flusso di coscienza, trovando risonanze inattese nei film di Peter Greenaway, secondo secondo il sistema della musica aleatoria di John Cage e dello spirito accumulatorio di una enciclopedia, o nella pittura di Francis Bacon e nella filosofia della différance derridiana. Jacques Derrida gioca intenzionalmente con l’ortografia, sostituendo la «e» con una «a» nella parola francese «différence» per sottolineare come il linguaggio non sia mai pienamente presente a se stesso, ma sempre differito e rimandato. Più che un sassofonista, Evan Parker si rivela dunque un pensatore del suono, un artigiano del non detto, uno scultore d’aria che da oltre mezzo secolo interroga il senso del fare musicale senza mai cedere al decorativo, al rassicurante ed all’ovvio. Lontano da ogni ideologia della «purezza», il suo lavoro incarna una forma estrema di libertà critica, dove l’improvvisazione non è esibizione del sé, ma sismografo dell’instabile, lente d’ingrandimento dell’inudibile, atto di resistenza poetica in un’epoca di riproduzione incessante.
Benché immerso nello stesso humus culturale della cosiddetta British free improvisation, Evan Parker si distanzia in modo netto da molti dei suoi contemporanei sassofonisti, tanto per inclinazione estetica quanto per approccio tecnico. Piuttosto che inserirsi in una genealogia lineare che da Joe Harriott conduce a Trevor Watts, da Elton Dean a Lol Coxhill, Parker preferisce inscrivere la propria opera in una dimensione laterale, centrifuga, quasi ascetica, marcata da un’intenzione analitica e da un rigore metodologico che raramente trova equivalenti nella scena inglese. In Trevor Watts, ad esempio, si avverte una maggiore adesione all’impulso afro-jazzistico, filtrato attraverso la lente dell’improvvisazione radicale, ma ancora alimentato da una pulsione ritmica condivisa, da una verticalità espressiva che trova nel fraseggio incandescente una forma di trascendenza collettiva. Al contrario, Parker scarnifica la materia sonora, abolendo ogni riferimento idiomatico, svuotando il discorso musicale di ogni residuo narrativo, come se la nota dovesse giustificarsi nella sua nudità, nella sua pura insorgenza acustica. Dove Watts procede per accumulo energetico, Parker opta per la proliferazione timbrica, per il cesello microtonale e per la disarticolazione del fraseggio secondo logiche iterative, quasi ossessive. Elton Dean, con il suo timbro gutturale e la sua vocazione al lirismo obliquo, esplora più volentieri la zona di confine tra il jazz modale e l’improvvisazione aperta. La sua parabola s’intreccia con l’epopea dei Soft Machine e della Canterbury Scene, accogliendo influssi psichedelici e rockeggianti che raramente sìincontrano nell’universo parkeriano. Quest’ultimo, pur collaborando in modo sporadico con formazioni eterodosse, rifugge qualsiasi forma di contaminazione stilistica che comporti compromessi con strutture metriche o armoniche tradizionali. Dove Dean modula, Parker atomizza; dove Dean frange, Parker moltiplica per torsione.
La figura di Lol Coxhill, per molti versi affine nella predilezione per il sax soprano e nell’attitudine sperimentale, si discosta però sul piano dell’estetica complessiva. Se Coxhill insiste su una vena teatrale, ironica, a tratti dadaista, con inserti vocali, pastiche linguistici e citazioni parodiche, Parker rinuncia a ogni gestualità extramusicale, concependo l’improvvisazione come una disciplina mentale e fisica che esclude l’aneddoto, l’interpunzione umoristica, l’elemento cabarettistico. Nel gioco semi-serio di Coxhill si riflette una certa tradizione britannica del nonsense, da Edward Lear a Monty Python; nel rigore parkeriano si avverte piuttosto l’eco di una logica continentale, vicina al pensiero formalista di Adorno o alla scarnificazione beckettiana. Tecnicamente, Parker porta il sassofono, specialmente il soprano, verso territori inesplorati, mediante l’utilizzo sistematico della respirazione circolare, degli armonici multipli, delle tecniche estese e di un controllo millimetrico della pressione labiale. L’introduzione di una polifonia virtuale, ottenuta attraverso interferenze armoniche e battimenti, rappresenta uno degli esiti più radicali della sua poetica, quasi un tentativo di dissolvere la linearità monodica dello strumento in un campo acustico instabile, pulsante, multidimensionale. Tale ricerca non trova equivalenti strutturali negli altri sassofonisti britannici, nemmeno nei più arditi, i quali spesso si arrestano ad un livello timbrico-espressivo meno stratificato, meno sistemico. Se si dovesse individuare un parallelo fuori dal Regno Unito, si potrebbe forse evocare Anthony Braxton per l’intransigenza teorica, Roscoe Mitchell per la verticalità atomica del suono, o addirittura Giacinto Scelsi per la focalizzazione maniacale sul microintervallo e sullo spettro armonico. Tuttavia, Parker rimane un unicum nella scena inglese: figura liminale, al tempo stesso scienziato del suono e mistico dell’aria, il cui gesto performativo assume una dimensione quasi rituale, svincolata dalla comunicazione e tesa verso una forma di percezione alterata, prossima alla trance. In ciò risiede forse la sua più profonda divergenza: laddove molti dei suoi colleghi cercano ancora un dialogo, un’interazione, un’energia condivisa, Parker costruisce un ascolto in cui il silenzio non è assenza ma principio generativo, in cui la molteplicità del suono si dà solo come frattura della linearità, come esperienza liminale, come esercizio dell’inudibile.
Le relazioni tra l’opera di Evan Parker e quella dei grandi maestri del sassofono afroamericano del secondo dopoguerra si articolano in una trama densa, talvolta carsica, fatta più di deviazioni, frizioni e disallineamenti che di filiazioni dirette o emulazioni programmatiche. Il legame, tutt’altro che lineare, si rivela perciò più dialettico che genealogico, più epistemologico che stilistico, più critico che celebrativo. Il nome di John Coltrane, spesso evocato come il nume tutelare della ricerca parkeriana, rappresenta una presenza ossessiva, insieme luminosa ed irrisolta. Non si tratta, tuttavia, di un’influenza trasparente, bensì di un nodo di tensione permanente. Coltrane viene percepito da Parker come figura-limite, come vertice raggiunto e, proprio per questo, impraticabile. La sua «sheets of sound» – quell’intarsio fitto e instancabile di note che rompe la linearità temporale – viene da Parker assunta non per essere reiterata, ma per essere superata sulla scorta di uno scardinamento della forma e di un disinnesco della retorica espressiva. Dove Coltrane, anche nel periodo più astratto, conserva un afflato spirituale, una verticalità escatologica, Parker taglia deliberatamente il cordone ombelicale con ogni tensione trascendente, indirizzando la sua ricerca verso un suono immanente, fenomenologico e detritico. Albert Ayler, con la sua destrutturazione brutale della melodia e il suo utilizzo estensivo del vibrato come arma espressiva, viene filtrato da Parker in una chiave meno viscerale e più analitica. La sua frenesia lirica, capace di inglobare inni liturgici, marce funebri e fanfare apocalittiche, non trova pieno rispecchiamento nell’universo parkeriano, che rifugge la teatralità dell’invocazione. Tuttavia, un’eco ayleriana si avverte nella volontà di disarticolare il fraseggio, di spingere il timbro fino al suo punto di rottura, di concepire il suono come materia incandescente, come magma informale più che come discorso.
Ornette Coleman, pur essendo tra i fondatori della grammatica free, occupa una posizione laterale nel pantheon parkeriano. La sua poetica armolodica, basata su una libertà orizzontale dei parametri musicali, resta per certi versi troppo legata all’idioma jazzistico per essere accolta integralmente da Parker, che invece persegue una non-idiomaticità rigorosa, quasi dogmatica. L’influenza, se presente, si manifesta più come spinta alla liberazione da vincoli armonici e metrici che come modello formale. L’approccio collettivo di Coleman, la simultaneità delle voci, trova un’analogia solo parziale con le pratiche dell’AMM e delle formazioni parkeriane. Ciò che in Coleman ha ancora il respiro del blues, in Parker si trasforma in tessitura rizomatica, in reticolo sonoro svincolato da ogni gravità culturale. Più defilate, ma non meno significative, risultano le risonanze con Pharoah Sanders e Archie Shepp. Il primo, con la sua vocalità strumentale e il suo misticismo sonoro, incarna una forma di catarsi che Parker sembra osservare con rispetto ma senza aderirvi. La trance parkeriana, se esiste, non risulta estatica ma centripeta, non euforica ma iterativa, non salvifica ma analitica. Di Shepp, invece, Parker rifiuta l’enfasi politica, la teatralità del grido, l’intenzionalità semiotica. La sua si sostanzia come una scrittura priva di enunciato, una sintassi senza contenuto, un’archeologia del gesto che non intende «dire» alcunché, ma solo manifestare il suono nella sua pura alterità. In definitiva, Parker non è tanto l’erede di questi giganti quanto il loro doppio paradossale, il loro rovescio metodologico. Se i maestri afroamericani del secondo dopoguerra hanno agito per scardinamento interno del linguaggio jazzistico, spingendolo fino al collasso semantico, Parker agisce invece da fuori, partendo da una tabula quasi rasa, costruendo una pratica che, pur avendo attraversato il jazz, non si lascia definire in sua funzione. In tal senso, l’operazione parkeriana risulta affine a quella che in filosofia compie Gilles Deleuze nei confronti della psicoanalisi freudiana o che in pittura realizza Francis Bacon rispetto al naturalismo classico: non distruzione, ma disarticolazione; non negazione, ma deviazione strategica; non tradizione, ma contro-memoria. Tale atteggiamento lo rende un personaggio anomala, capace di dialogare con il patrimonio afroamericano senza replicarne le coordinate estetiche, mettendo in tensione il canone senza rinnegarlo, problematizzandolo da una distanza critica che è insieme ascolto e sovversione.
All’interno di una discografia vastissima, costellata da pubblicazioni che rifiutano ogni gerarchia canonica, cinque album si impongono – più per la loro funzione di snodo che per una supposta superiorità formale – come luoghi di condensazione poetica e di svolta ermeneutica. Attraversandoli con sguardo musicologico ed orecchio avvezzo alla complessità, si può ricostruire non già una parabola ascendente, ma una costellazione di gesti sonori che definiscono, ciascuno a suo modo, un’idea radicale del suonare. «The Topography Of The Lungs (Incus, 1970), la prima incisione ufficiale pubblicata da Parker, in trio con Derek Bailey e Han Bennink, segna un punto di rottura non solo con il jazz, ma con la stessa idea di interazione musicale tradizionale. Il titolo evoca un paesaggio interno, anatomico, in cui il fiato non è più semplice veicolo, ma principio generativo del suono. Emozionalmente, si ha l’impressione di assistere ad una conversazione tra tre entità corporee più che tra tre strumenti: la chitarra graffia, il sax incide e la batteria si disgrega in frammenti onomatopeici. Strumentalmente, Parker adotta un linguaggio che già sfugge alla fraseologia jazzistica, optando per una verticalità fonica che mira a saturare lo spettro più che ad ordinarlo. La notazione tradizionale, o meglio, la sua negazione, risulta sostituita da una scrittura gestuale, fatta di eventi sonori privi di incastro armonico, ma organizzati secondo una logica entropica. Musicologicamente, questo concept inaugura la pratica della non-idiomatic improvisation, concetto coniato da Bailey, configurandosi come atto fondativo di una scena che rigetta qualsiasi compromesso con la riconoscibilità tematica. «Monoceros «(Incus, 1978), registrato in solo al sax soprano, rappresenta una vera e propria teogonia acustica, in cui Parker inaugura una grammatica personale del suono, basata su respirazione circolare, multifonici, armonici nascosti e politimbrismo spurio. Ascoltandolo, si viene immersi in una corrente fluida, incessante, quasi ipnotica, che abolisce il tempo lineare a favore di una durata interna, ciclica e prossima a una forma di trance vigile. Strumentalmente, ogni nota è parte di un continuum che rinnega l’incipit e la fine, costruendo un organismo sonoro che si autogenera e si ripiega su se stesso. Dal punto di vista pentagrammatico, l’opera appare irriducibile, mentre nessuna notazione convenzionale potrebbe restituirne la complessità stratificata, la simultaneità delle altezze e la sfumatura infranote. Musicologicamente, «Monoceros» si colloca in una zona di confine tra musica e scienza acustica, dove ogni suono costituisce il prodotto di un microstudio del tubo, di un’esperienza fisico-meccanica del metallo e del fiato, secondo una logica prossima al laboratorio più che alla sala da concerto. Il soprano non canta, ma vibra, pulsa, sibila e si moltiplica.
In «Three Blokes» (Leo Records, 1994), realizzato insieme a Anthony Braxton e Roscoe Mitchell, Parker costruisce un dialogo non competitivo, bensì geometrico, fra tre pensieri sassofonistici radicalmente distinti ma intersecabili. L’emozione dell’ascolto nasce da un gioco di specchi, in cui l’identità sonora dei tre si rifrange in un’architettura polifonica che sembra sfidare la logica dell’ascolto unidirezionale. Strumentalmente, il confronto si gioca sul controllo del timbro, sul fraseggio disallineato e sull’uso dei silenzi come interpunzione significativa. In tal senso, l’album è quasi brahmsiano nella sua scrittura contrappuntistica, benché composto interamente in tempo reale. Musicologicamente, «Three Blokes» costituisce una pietra miliare nel pensiero dell’improvvisazione collettiva non gerarchica, in cui il potere dialogico non nasce dalla compatibilità idiomatica, ma dalla coesistenza di logiche divergenti, rese solidali da un’etica dell’ascolto assoluto. L’album è da considerarsi un trattato di diplomazia musicale è di polifonia eterodossa. In «Toward The Margins» (ECM, 1997), registrato con l’Electro-Acoustic Ensemble, il sasofonista inaugura una nuova stagione del suo pensiero sonoro, innestando l’improvvisazione acustica su un tappeto di elaborazione digitale dal vivo. Il suono non è più vincolato all’immediatezza della sorgente strumentale, ma si trasforma, si rifrange, si dissolve nella spazializzazione elettronica. Emozionalmente, l’ascolto evoca paesaggi siderali, corridoi della mente, memorie acustiche in decomposizione. Sul piano strumentale, Parker si confronta con la dislocazione del sé: il suono che produce non gli appartiene più interamente, ma viene riscritto in tempo reale dal live processing di Walter Prati, Lawrence Casserley ed altri. È il sassofono stesso che si duplica, si dilata e si diffonde. Il disco riflette sulla crisi dell’autore in epoca post-digitale, sullo slittamento della fonte e sul ruolo dell’interprete come dispositivo relazionale. La partitura, se mai esistesse, sarebbe un network, una mappa dinamica. Parker si fa mediatore tra il gesto corporeo e la sua trascendenza elettronica, tra la pelle dello strumento e la sua fantasmagoria digitale. «As The Wind «(Aum Fidelity, 2016), pubblicato dopo la morte del contrabbassista Paul Rogers, è stato inciso dal trio Parker–Guy–Lytton esteso a una formazione cameristica e si attesta come una sorta di epicedio sonoro, un affresco corale che coniuga tensione e leggerezza, drammaticità e sospensione. L’emozione viene filtrata, trattenuta, trasposta in un linguaggio orchestrale che lascia emergere echi da Webern, da Feldman e da certa musica spettrale. La presenza di archi, clarinetti, percussioni e interventi elettronici costruisce un continuum fragile e stratificato, in cui il sax di Parker agisce come un nervo scoperto ed un’emanazione lirica ma non sentimentale. Dal punto di vista musicologico, l’album riassume e sublima la traiettoria parkeriana, dove l’ascolto si dispiega in forme mobili, quasi calligrafiche, che sembrano scritte nell’aria piuttosto che su carta. Non si tratta di una sintesi, ma di una forma di anamnesi sonora, una retrospettiva non cronologica ma timbrica, una meditazione sulla memoria del suono come evento condiviso e già svanente. Attraversando queste cinque tappe, l’opera di Evan Parker si rivela nella sua natura molteplice e cangiante, ossia non uno sviluppo lineare, ma una spirale; non una biografia, ma un paesaggio psicoacustico in perenne mutazione, in cui il respiro diventa forma, il timbro pensiero, l’improvvisazione una filosofia incarnata.