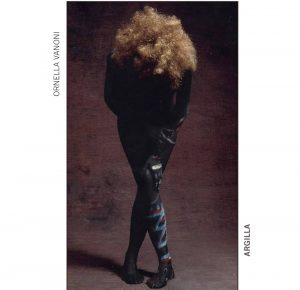Keith Jarrett con «Shades»: una dichiarazione audace e non convenzionale che testimonia la superiorità del quintetto americano (Impulse! Records, 1975)

La perlustrazione sonora è essenzialmente basata sulla telepatia di gruppo, infatti la compagine americana di Jarrett, geneticamente diversa – ma anche superiore per coesione e portato esecutivo – dalla sua formazione europea, prospera su un’improvvisazione a briglie sciolte ed un by-play senza limiti prefissati.
// di Francesco Cataldo Verrina //
«Shades» è certamente il disco di Jarrett con il baricentro più spostato in avanti, un album free form in piena regola, dove il pianista non fa solo accademia del pianismo improvvisativo, ma incarna uno spirito più decentrato, teso a toccare il lato più oscuro del jazz di quegli anni. Registrato nel 1975 insieme al suo successore, «Mysteries», l’album beneficia dell’inquietudine del potente quintetto americano: Dewey Redman (sax tenore), Charlie Haden (basso), Paul Motian (batteria) e Guilherme Franco (percussioni). La prima avvertenza per chi soffre di vertigini o per il cultori del piano solo di tipo termale, è che questo disco offre un’esperienza d’ascolto urticante che oscilla tra groove strutturati e puro caos. La perlustrazione sonora è essenzialmente basata sulla telepatia di gruppo, infatti la compagine americana di Jarrett, geneticamente diversa – ma anche superiore per coesione e portato esecutivo – dalla sua formazione europea, prospera su un’improvvisazione a briglie sciolte ed un by-play senza limiti prefissati. Mentre il contributo di Guilherme Franco rimane sottotono, l’intesa tra Redman, Haden e Motian è fertilizzante, alimentando una terreno che permette a Jarrett di esprimere la sua abilità sulla scorta di un pianismo sciorinato in scioltezza e contraddistinto da accordi percussivi, fraseggi rapidissimi e voicing che alcuni potrebbero trovano distraenti ma che, in quel dato momento storico, erano parte integrante dello stile proteiforme del pianista di Allentown. «»
«Shades of Jazz» apre l’album con un turbine di dieci minuti, quasi ballabile, un pezzo rovente in cui Jarrett e Dewey Redman espongono la melodia prima che il sassofonista svanisca rapidamente, lasciando la musica nelle mani dei sodali, con la sezione ritmica che imposta un groove potente prima che Redman conquisti il centro del ring. Il suo assolo si dimena tra elementi free e avant-garde, riportando alla mente le registrazioni degli anni ’50 di John Coltrane per la Prestige e facendo decollare il convoglio ad un livello superiore. Da sottolineare un’abbondanza di mormorii e ronzii da parte di Jarrett, intento a danzare sui tasti del pianoforte. «Southern Smiles» mantiene un’energia simile, ma con un’esecuzione più rilassata e sospesa, come suggerisce il titolo. Dal canto suo, Jarrett interrompe a tratti il flusso armonico con frustate accordali più distanziate, ma assestate con decisione.
La seconda metà del disco inizia con «Rose Petals», una struttura sofisticata ed atmosferica, che mostra il lato più cervellotico e sperimentale dell’ensemble, il quale distilla una ballata libera che richiama l’ultimo periodo di Coltrane, sia per il modus agendi di Motian, il quale esplora il kit percussivo in modalità Rashied Ali, sia per l’assolo di Redman, che parte dalla melodia per intraprendere un’escursione sonora ampia, perlustrativa ed, allo stesso tempo, introspettiva. Quando Jarrett prende le redini in mano, il suo operato si fa più contenuto, quasi da piano-bar, mentre Motian si adegua passando alle spazzole e trasformando radicalmente la struttura narrativa. Intorno al sesto minuto, giunge il primo assolo di Haden, che risulta estremamente minimale, lasciando che ogni nota risuoni nitidamente. Motian e Jarrett lo accompagnano con con un andamento delicato, quasi classico. L’energia cresce gradualmente e, nel finale, l’intero gruppo, Redman incluso, fa quadrato, suggellando il pezzo con una combustione lenta ma intensa. «Diatribe» chiude l’album, elaborando una sorta di sintesi di tutto ciò che era venuto prima. La melodia è sinuosa ed irregolare, quasi una fanfara circense, ma subito dopo l’enunciazione iniziale il line-up perde totalmente i freni inibitori. Charlie Haden alterna pizzicati rapidi e decisi ad un feroce lavoro con l’archetto, mentre Paul Motian e Keith Jarrett ne solidificano i contrafforti. Jarrett, in particolare, martella i tasti con un’intensità che rasenta il mood di Cecil Taylor. L’assolo di Dewey Redman è un festival del growl and skronk, tra suoni gutturali e striduli, mentre la batteria e le percussioni creano un substrato sonoro feroce, che riporta alla mente «The Magic Of Ju-Ju» di Archie Shepp, dove il sassofonista ruggisce per venti minuti su un flusso ritmico incessante. Intorno al sesto minuto, Jarrett torna a dominare la scena con una gragnola di note spulciate dal registro più basso della tastiera, mentre Redman strilla e graffia il suo sax in un vortice free-jazz. La band raggiunge un climax febbrile prima di riprendere la melodia iniziale e chiudersi la porta dietro le spalle.
Dopo il successo planetario di «The Köln Concert», una dimensione più collegiale come «Shades» appare più spensierata e spontanea, rivelando la propensione di Jarrett a sondare i confini estremi del jazz. Se alcuni passaggi possono sembrare caotici, l’interazione tra musicisti esperti e rodati rende il plot narrativo attraente ed imprevedibile al contempo. In definitiva, «Shades» è l’apoteosi dei contrasti, tra momenti di groove battente, esplosioni di furia incontrollata e frammenti di riflessione. Potrebbe non piacere a tutti gli appassionati di jazz, soprattutto a chi predilige le composizioni più liriche e introspettive di Jarrett. Tuttavia, per quanti subiscono il fascino del post-bop e dell’avant-garde, l’album rappresenta un tassello importante nel vasto catalogo del pianista.