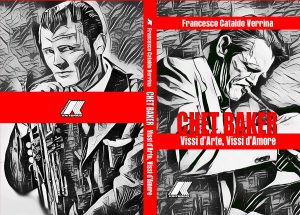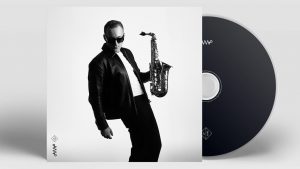Il testamento cromatico di Miles Davis: «Aura» dieci colori una sola anima

«Aura» si rivela non soltanto come un’opera di sintesi stilistica, ma come un atto testamentario in cui Davis affida alla musica l’ultimo ritratto di sé: poliedrico, inafferrabile, refrattario a ogni categorizzazione definitiva. Un lascito che, lungi dall’essere un epilogo statico, rilancia la sua eredità nell’orizzonte di una modernità inquieta ed inesauribile.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Concepito nel 1985 ma pubblicato soltanto nel 1989, «Aura» rappresenta un episodio cardine nella parabola creativa di Miles Davis, una sorta di epilogo visionario in cui si condensano memorie sonore e slanci avanguardistici. Non si tratta di un ascolto accomodante o consolatorio: il tessuto musicale appare intessuto di trame sintetiche, di stratificazioni timbriche che avvolgono ed al tempo stesso sfidano l’orecchio, come una superficie gelida sulla quale la tromba di Davis, agile e inafferrabile, disegna traiettorie imprevedibili. La freddezza apparente di certi passaggi elettronici non rappresenta che una superficie da infrangere, dove il fraseggio, lucente e tagliente, vi incide fenditure incandescenti, capovolgendo la percezione iniziale.
Il progetto prende forma su partitura di Palle Mikkelborg, autore di una suite concepita come mosaico sinestetico. Dieci movimenti corrispondono ad altrettanti colori, derivati dall’acrostico “M.I.L.E.S. D.A.V.I.S.”, sviluppati a partire da un nucleo tematico di dieci note. La struttura, lungi dal frammentarsi in episodi autonomi, si compone come un flusso ininterrotto, dove il materiale sonoro si trasfigura gradualmente, fondendo idiomi disparati: frammenti di rock e pulsazioni soul, armonie di matrice colta europea, pulsazioni reggae, echi blues. Tale compenetrazione di stili, lungi dall’essere semplice esercizio eclettico, si configura come un continuum narrativo in cui ogni elemento viene assorbito e riplasmato dalla personalità magnetica del solista. L’operazione registra un evidente debito verso la lezione di Gil Evans, ma attinge anche a un orizzonte più ampio, che comprende Charles Ives, Olivier Messiaen e Igor Stravinskij. Questi riferimenti non sono citazioni epidermiche, ma la scrittura orchestrale si avvale di impasti timbrici arditi e di contrasti dinamici che evocano tanto le architetture dissonanti di Ives quanto la policromia armonica messiaeniana. L’intervento della Danish Radio Big Band, con cui l’album fu inciso a Copenaghen, conferisce al tessuto orchestrale un respiro ampio e quasi cinematografico, capace di avvolgere la voce della tromba in una sorta di «Aura» – per riprendere il titolo – che le funge da amplificatore emotivo. Nonostante l’iniziale ritrosia della Columbia, la quale lasciò in sospeso la pubblicazione per quattro anni, Davis considerava «Aura» un autentico vertice della propria produzione tardiva, come egli stesso affermò nell’autobiografia: «Penso sia un capolavoro, lo credo veramente». Ascoltandolo con attenzione, si coglie la tensione tra ordine e disordine, tra la geometria della partitura e la libertà inventiva dell’improvvisazione, una dialettica che genera un’esperienza di ascolto cangiante, talvolta ostica, ma di innegabile fascino. La materia sonora, fitta come una tessitura di fili incrociati, si lascia attraversare da improvvise fenditure liriche, momenti in cui la tromba sembra sospendere il tempo, come se volesse sottrarre l’uditorio alla linearità della narrazione per proiettarlo in una dimensione estatica. «Aura» si rivela non soltanto come un’opera di sintesi stilistica, ma come un atto testamentario in cui Davis affida alla musica l’ultimo ritratto di sé: poliedrico, inafferrabile, refrattario a ogni categorizzazione definitiva. Un lascito che, lungi dall’essere un epilogo statico, rilancia la sua eredità nell’orizzonte di una modernità inquieta ed inesauribile.
L’architettura di «Aura» si apre con «Intro», una soglia sonora sospesa in una penombra di armonici e riverberi, in cui la Danish Radio Big Band disegna un orizzonte dilatato, quasi una distesa marina prima della tempesta. Il tema di dieci note che funge da matrice genetica dell’intera suite è qui esposto con discrezione, come un filo d’inchiostro tracciato sul foglio ancora intonso. Davis vi interviene con la tromba sordinata, trasformandola in un narratore che parla da lontano, evocando più che descrivere: l’impressione è affine a certi incipit cinematografici di Tarkovskij, dove il tempo pare congelarsi prima che la vicenda inizi a scorrere. Con «White» si entra in un chiarore abbacinante, dove l’orchestrazione predilige impasti luminosi, quasi accecanti, punteggiati da ostinati ritmici che suggeriscono un’energia trattenuta. La tromba si muove qui come un protagonista di film espressionista, proiettando ombre lunghe su un fondale lattiginoso. L’armonia si sviluppa attorno a modulazioni diatoniche che improvvisamente scivolano in zone cromatiche, generando un effetto di spaesamento, come un corridoio che si restringe mentre lo si percorre. «Yellow» introduce una pulsazione più marcata, dove le influenze rock si fanno percepire in una scansione ritmica regolare, quasi ipnotica. Il colore suggerito dal titolo si traduce in sonorità calde, vibranti, che si mescolano con interiezioni orchestrali taglienti. In certi momenti la tromba di Davis sembra quasi fendere il tessuto armonico come una lama, alternando frasi brevi, quasi aforistiche, a linee più distese, simili a monologhi interiori. Qui l’improvvisazione si appoggia su centri tonali stabili, che fungono da perno attorno al quale si avvolgono deviazioni modali, come in una spirale dorata. Con «Orange» il clima muta: il timbro complessivo si fa più terroso, il ritmo ondeggia con accenti irregolari che evocano un certo gusto reggae filtrato attraverso la lente dell’orchestrazione sinfonica. Il linguaggio armonico attinge a quarte sovrapposte e voicing aperti che lasciano spazio a riverberi e risonanze, producendo una sensazione di ampiezza. Il tutto si sostanzia come un movimento in cui il colore si percepisce come materia tattile, simile a certi fondali di Antonioni in cui il paesaggio diventa protagonista silenzioso. «Red» irrompe con un’energia quasi marziale, in cui la scrittura orchestrale adotta blocchi accordali compatti, talora dissonanti, che si scontrano e si sovrappongono come masse in collisione. Davis qui assume una postura più assertiva, articolando frasi che sembrano scudisciate. L’armonia si avvicina a certe soluzioni di Stravinskij, con poli-tonalità appena celate e un uso incisivo della tensione tra tritoni e quinte giuste. L’ascolto restituisce un senso di urgenza drammatica, affine a un’inquadratura serrata di Kurosawa prima di una battaglia. «Green» rappresenta una distensione, ma non pacificata, dove l’orchestrazione si fa più rarefatta, con linee melodiche affidate ai legni e lunghi pedali dei bassi. Qui Davis gioca su intervalli ampi, privilegiando quarte e quinte che creano un senso di apertura spaziale. Il verde evocato non è un prato solare, ma una radura ombrosa, punteggiata di luci filtrate, come nei boschi di «Dreams» dello stesso Kurosawa, dove il silenzio risulta carico di presagi. In «Blue» l’atmosfera diviene più introspettiva, mentre l’armonia, saldamente ancorata a centri modali, sembra arricchita da cromatismi sottili e sospensioni che generano un senso di malinconia sospesa. La tromba assume un carattere quasi vocale, piegando le note come sillabe di una lingua privata. Siamo al momento più vicino alla dimensione del cool davisiano, ma attraversato da una velatura nostalgica, come una fotografia virata al seppia. «Electric Red» riporta in primo piano un’energia pulsante e irregolare: l’impianto ritmico si frantuma in cellule asimmetriche, mentre l’orchestra tesse un tessuto fitto di cluster e accenti spostati. Le tensioni armoniche sono mantenute volutamente in sospeso, senza risoluzione, come in un montaggio serrato di Godard, dove le immagini si urtano senza cuciture rassicuranti. Con «Indigo» il flusso si fa più contemplativo, in una penombra armonica sostenuta da accordi plananti che scivolano lentamente da una tonalità all’altra. Il fraseggio di Davis appare ridotto all’essenziale, quasi a voler sottrarre più che aggiungere, in una logica che ricorda la sottrazione poetica di un haiku. L’orchestrazione sfrutta la profondità dello spettro sonoro, con bassi avvolgenti e timbri medio-gravi che amplificano il senso di intimità. Infine «Violet» chiude la suite con un gesto di sintesi, in cui il tema generatore ritorna, ma trasfigurato, come se fosse stato attraversato da tutte le esperienze timbriche ed armoniche precedenti. L’atmosfera è sospesa tra luminosità e malinconia, come nei finali aperti di Kieslowski, dove ogni risposta rimane implicita. La tromba di Davis non cerca un apice virtuosistico, ma si spegne in un soffio, lasciando l’impressione di un ciclo compiuto, un affresco policromo che si richiude su se stesso, restituendo all’ascoltatore un ritratto sonoro dell’artista in forma di luce.
All’interno della trama di «Aura», la scrittura di Palle Mikkelborg rivela un impianto tecnico che, dietro la veste evocativa e sinestetica, si fonda su un’architettura rigorosamente concepita. Il nucleo generativo di dieci note – derivato dall’acrostico del nome di Davis – non rappresenta soltanto un artificio nominale, ma diventa cellula melodica ed armonica, capace di generare tanto linee principali quanto contrappunti e progressioni secondarie. Gli intervalli scelti, con una prevalenza di quarte giuste, quinte e seconde maggiori, producono una sonorità aperta, quasi aeree, in contrasto con improvvisi addensamenti di seconde minori e tritoni che introducono tensione e inquietudine. La costruzione intervallare appare così bilanciata tra spazi ampi e attriti ravvicinati, un po’ come in certi disegni di Klee, dove la geometria è sempre attraversata da improvvisi slittamenti. Sul piano modale, Mikkelborg adotta un approccio che si colloca a metà strada tra il modale davisiano degli anni Sessanta e le espansioni cromatiche tipiche della musica colta europea novecentesca. Accanto ai modi dorico e misolidio, spesso utilizzati come griglie per l’improvvisazione, s’incontrano strutture miste che incorporano note estranee, creando scale asimmetriche dal sapore quasi messiaeniano. Questa commistione genera ambiguità tonale, in cui la percezione dell’ancoraggio si rivela spesso provvisoria, subito messa in crisi da modulazioni laterali che non obbediscono alla tradizionale logica di dominante, ma si muovono per poli, per affinità di colore e non per attrazione funzionale. Le modulazioni stesse sono condotte con una fluidità che ricorda certe transizioni cinematografiche di Kieslowski, dove il passaggio da un ambiente all’altro avviene senza soluzione di continuità, lasciando nello spettatore un’impressione di inevitabilità piuttosto che di rottura. I cambi di tonalità, spesso impercettibili nell’esatto momento in cui avvengono, contribuiscono a quell’effetto di una corrente sotterranea che lega i diversi movimenti della suite. Talvolta la transizione avviene per trasposizione intervallare diretta – ad esempio una cellula melodica trasportata esattamente a distanza di terza minore o di quinta giusta – altre volte attraverso la graduale sostituzione di note fino a ridefinire il contesto modale, come in un affresco in cui il colore dominante muta impercettibilmente. Un elemento di particolare interesse proviene dall’uso dell’armonia quartale, che funge da ponte tra le radici modali e l’eredità di Gil Evans, dove accordi costruiti per sovrapposizione di quarte creano campi sonori “sospesi”, privi di gravità tonale, sui quali la tromba di Davis può fluttuare senza vincoli di risoluzione. Nei momenti in cui il tessuto armonico si fa più fitto, compaiono cluster e sovrapposizioni politonali che ricordano tanto la durezza stravinskiana quanto la lucentezza timbrica di Messiaen, il tutto filtrato attraverso una sensibilità orchestrale che privilegia la sfumatura al colpo di scena. In questo equilibrio tra intervallo e timbro, tra modo e modulazione, la partitura di «Aura» non si limita a fornire un contesto alla tromba di Davis, ma diventa essa stessa un organismo vivo, capace di mutare forma e temperatura emotiva in tempo reale. È come se la scrittura di Mikkelborg avesse creato una struttura a labirinto – non nel senso di un percorso disorientante, ma come un reticolo in cui ogni corridoio conduce ad un’altra prospettiva sulla stessa figura centrale, quella di Miles, trasfigurata in suono e colore. In «Aura», la complessità intervallare e la raffinatezza modale di Mikkelborg si saldano ad un’idea di musica che trascende il mero esercizio compositivo. L’impalcatura armonica, pur sorretta da calcoli minuziosi, non si offre come oggetto di contemplazione astratta, ma piuttosto assembla la cornice invisibile di un ritratto in cui il soggetto, Miles Davis, si manifesta non tanto come interprete di una partitura altrui, ma come principio generatore dell’intera architettura. Il tema di dieci note, i mutamenti di colore orchestrale, le modulazioni senza attrito sono i mezzi attraverso cui la tromba può raccontarsi, alludendo più che dichiarando, come un personaggio di Bergman che, in controluce, rivela il proprio volto solo per frammenti.
L’intreccio fra rigore costruttivo e libertà improvvisativa produce un album, in cui la forma si piega alla narrazione emotiva che trova nella forma il proprio argine e la propria eco. Così come in filosofia la verità non è mai la semplice somma di proposizioni ma il processo stesso del loro dispiegarsi, in «Aura» il senso non risiede in un singolo movimento o in un climax finale, bensì nel continuum di tensioni, sospensioni e rivelazioni che legano l’inizio alla fine. Ogni colore musicale è un volto diverso dello stesso ritratto, eppure nessuno di essi esaurisce la figura; ogni passaggio armonico è una svolta di prospettiva, un cambio di luce che ridefinisce la percezione dell’intero. In quest’ottica, «Aura» non si limita a essere l’ultimo grande affresco della tarda produzione davisiana, ma assume la fisionomia di un’opera filosofica in musica, una meditazione sulla mutabilità e sulla permanenza, sulla necessità di trasformarsi senza mai recidere il filo che ci lega alla nostra essenza. Siamo alle prese con un concept discografico che, come certi film di Tarkovskij o Kieslowski, non offre soluzioni ma continua a risuonare nella memoria, spingendo l’ascoltatore a tornare sui propri passi per scoprire, a ogni nuovo ascolto, sfumature prima invisibili. Un’opera che si chiude con la stessa discrezione con cui si apre, lasciando nell’aria non una conclusione, ma una sospensione, come se Miles si fosse limitato a schiudere una porta su un orizzonte in cui il suono ed il silenzio, finalmente, si equivalgono.