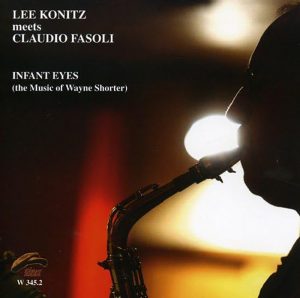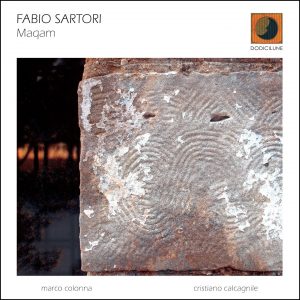Intervista a Giorgio Alberti, fratello minore di Alberto

Jimmy Villotti & Giorgio Alberti
// di Guido Michelone //
Fratello ‘minore’ di Alberto Alberti (1932-2006) impresario, jazzofilo, produttore discografico, Giorgio per anni è docente universitario nella Facoltà di Scienze Politiche a Bologna dopo importanti trascorsi in America Latina, sempre per motivi di ricerca e di studio. Giorgio è una testimonianza diretta lucidissima di quanto avviene nella Bologna del jazz dal dopoguerra agli anni Settanta (prima di partire per l’estero), sia da fan e ascoltatore sia da amico di molti jazzmen presentatigli da Alberto, come spiega in quest’intervista inedita ricca di curiosità note a un ristretto numero di jazzologi bolognesi.
D Giorgio, come nasce Il tuo rapporto con il jazz?
R Naturalmente per rispondere a questa domanda devo introdurre la figura di mio fratello Alberto, lui nato nel 1932 (e purtroppo mancato nel 2006), io invece nel 1936: ero un bambino, sto parlando dei primissimi anni del dopoguerra, 1946 e 1947 in casa circolavano i famosi V disc i 78 giri che venivano regalati dalle forze armate americane e che – da quel che ricordo io – erano più orientati verso le grandi orchestre e non tanto al nascente bebop. Quindi Alberto era un po’ ossessivo con questi dischi e, se gli piaceva una cosa, gli piaceva punto e basta: perciò metteva sul grammofono Glenn Miller, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Duke Ellington, Louis Armstrong tutto il giorno. Quindi io senza capire niente di jazz mi trovavo ad ascoltare swing e dixieland tutti i giorni per tre o quattro ore. Per vicissitudini familiari, appena finita la guerra, fummo trasferiti in centro in un piccolo appartamento dopo avere vissuto in una villa megagalattica fuori città e non i vicini di casa non sempre apprezzavano questa musica nuovissima alle loro orecchie.
D Ma c’è un punto di svolta nella tua carriera di appassionato o jazzofilo che dir si voglia?
R Era il 1948 Alberto aveva 16 anni, io 12 e mi chiamava con tutta una serie di soprannomi bizzarri come succede chiaramente da bambini e ragazzi. Una sera, primavera o estate del 1948, sotto la guida Ruggero Spiazzi – impiegato di banca e fanatico di Stan Kenton e poi grande organizzatore – e con amici intimi più vecchi di lui ci riunimmo in un posto molto conosciuto a Bologna, in una piazzetta chiamata Corte Galluzzi, dove loro fondarono l’hot jazz club di Bologna. All’inizio non c’erano soldi ma regolarmente il club organizzava serate dove si ascoltava il jazz grazie ai dischi a 78 giri; fu lì che passai dalle big bang ai piccoli gruppi dei geni che inventarono il bebop.
D Avevi dei jazzmen preferiti in quel periodo?
R Tre nomi resteranno per sempre stampati nella mia memoria: Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Thelonious Monk; di questi tre geni riconoscevo in Parker il capostipite, ma oggi non lo ascolto più di tanto, perché è ormai impresso in me il modo di suonare di Monk, il genio assoluto: nessuno ha mai suonato come lui prima e un sacco di persone hanno tentano di imitarlo dopo.
D C’erano altri bopper che attiravano la tua attenzione?
R Sonny Stitt, un grande sottovalutato ma con una propria personalità soprattutto quando suona il tenore non è affatto una brutta copia di Parker come alcuni sostengono. Il linguaggio di Dizzy è invece il linguaggio del 90% dei trombettisti formatisi in quegli anni, Miles Davis compreso.
D Ma cosa ti affascinava maggiormente di Monk?
R Era una persona estremamente simpatica e intelligente: ho ricevuto da un amico collezionista di recente un documentario che dura un’ora su uno dei primi viaggi che Monk fa a Parigi, dove rilascia quest’intervista a uno che appare lì come un idiota e Monk lo guarda come a dire: “Ma cosa dici, deficiente?”. Continua a chiedergli perché aveva il pianoforte in cucina e gli risponde seraficamente che era l’unica stanza grande che poteva ospitarlo. E, sempre nel documentario, c’è Monk imperterrito davanti a un piano che non fa altro che suonare i suoi pezzi più famosi, butta giù le mani come fosse un martello. Straordinario. Potrei andare avanti ore e ore a parlare della grandezza di Monk.
D Torniamo agli inizi della tua passione per la musica…
R Devo rimarcare una seconda svolta nella mia strada e riconoscere nel jazz una musica straordinaria con genialità assolute. In Italia allora, nella metà degli anni Cinquanta, di jazz c’è n’era poco, ad esempio Nunzio Rotondo a Roma, il Basso-Valdambrini Quintet a Milano. Anni dopo conobbi di persona Gianni Basso su una nave che ci portava da Genova a Barcellona; avevo con me un mangianastri e passammo tutto il tempo a parlare di jazz e ad ascoltarli sulle musicassette. Ma per me la seconda svolta avviene all’estero, quando nel 1956 – avevo 20 anni – ero andato a Londra e lì cominciai a frequentare i jazz club inglesi con musicisti straordinari: in primis il trombettista Dizzy Reece di origini giamaicane che poi incise dischi con la Blue Note di altissimo livello ad esempio con Hank Mobley. A Londra dunque agiva il quintetto di Reece con Ronnie Scott al sax tenore e una ritmica straordinaria: io almeno tre volte la settimana andavo a sentirli. Poi si aprì un nuovo club Menor House Club un po’ fuori con i Jazz Couriers composti da Ronnie Scott e da un Tubby Hayes dalla creatività incredibile. Scott l’ho rivisto per caso, anni dopo, nella sezione fiati che suona Manteca per Gillespie. Rimasi un anno a Londra. E questa musica cominciò a penetrare in me, musica difficile da avvicinare ma quando si riesce a cantare nella mente gli assolo è una gioia infinita.
D Cosa succede al tuo ritorno in Italia?
R Ero di nuovo a Bologna, dove venne a vivere il pianista Amedeo Tommasi mentre Alberto comincia le attività legate al jazz. Qui però devo fare un passo indietro e rifarmi a quando mi fratello andò in Inghilterra attorno 1953-54 e a Charing Cross conosce un ex pilota dell’aviazione inglese, tale Tom Collins, che possedeva un negozio di dischi piccolino, ma stracolmo di 78 giri e dei primi LP tutti importati dall’America: grazie a lui quindi in poco tempo si trovavano a Londra ad esempio tutti gli album della Blue Note Records. Alberto scoprì il negozietto e andava lì tutti i giorni, ascoltava e spesso comprava i dischi. E Collins disse ad Alberto di aprire un negozietto simile promettendogli che gli avrebbe mandato personalmente i dischi americani in conto vendita. Mio fratello ancora studiava Legge in Università ma era già molto preso dal jazz al punto che riusciva a sostenere pochissimi esami come si intuisce dal libretto con i voti che mostrava a nostro padre perplesso. E poi Alberto smise del tutto con gli studi per ‘mettere su’ questa piccola attività in via Orefici – ovviamente a Bologna – ne luogo dove più tardi Paolo – figlio che mio padre ebbe dalla seconda moglie – inventò la “Strada del jazz” in cui tutti gli anni si aggiunge una stella di un grande jazzista, oltre l’onnipresente targa commemorativa “Alberto Alberti manager che portò a Bologna il mondo”.
D Mi sembra che in quegli comunque Bologna iniziasse a riempirsi di grandi jazzisti…
R Certa la presenza di Tommasi e quella di un allora giovane Franco D’Andrea, e di un altri due giovani, Claudio Fasoli al sax tenore e Giovanni Tommaso al contrabbasso. Poi io nel 1963 abbandono questo paradiso, perché lo chiamò paradiso? Perché si vive a il jazz a stretto gomito con un gruppo di amici, dieci, dodici persone al massimo. Sono gli anni in cui Alberto andò alla RCA a Roma, ma vi restò solo un anno perché non si trovava bene e tornò a Bologna.
D Come si viveva e si agiva in questo vostro paradiso?
R C’era la leadership di un dentista che era l’unico di noi che aveva disponibilità economica, prendemmo una cantina in via Rizzoli: ad avere le chiavi e aprire la porta c’era una sola persona, un proiezionista che arrivava poco dopo mezzanotte dal cinematografo; e lo chiamavamo Stan Getz perché lui, piccoletto, comprato un sax tenore più alto di lui, oltre amare alla follia il sound del grande jazzista bianco. Dopo che il proiezionista apriva i locali, ascoltavamo jazz tutta la notte su dischi o dal vivo, perché si fermano lì musicisti straordinari, prima di tutti Chet Baker che a sua volta veniva curato gratis dal dentista, visto che soffriva spesso di un mal di denti che a volte gli impediva di suonare bene. Ma c’era anche il problema della droga che non riusciva a superare.
D Ci sono altri jazzmen magari oggi un po’ dimenticati che vuoi ricordare in quegli anni?
R Sì, rimasi amico di un batterista, Peter Littman, che restò a Bologna un anno intero, dopo che incise il disco Chet In Paris. E Peter arrivò proprio da Parigi dove avevano tenuto lui, Chet e altri due avevano tenuto un gran concerto all’Olympia. Allora si narrava questa storia: nel quartetto c’era un pianista molto giovane Dick Twardzik, straordinario monkiano, che morì in teatro nell’intervallo fra un tempo e l’altro di overdose che gli fece Peter, che poi venne allontanato (e sostituito per metà del disco). Io avevo un vantaggio nel gruppo d amici: parlare correttamente l’inglese per essere stato un anno in Gran Bretagna e Peter e Chet erano le persone che conversavano di più con me.
D Accennavi prima ai problemi di stupefacenti…
R Infatti un giorno, vedendo che stava male, dissi a Chet di farsi ricoverare: “Giorgio io ho paura – mi rispose – io mi drogo da quando ho 15 anni e non sai cosa vuol dire conoscere una realtà da non drogato”. Peter Littman ne faceva di tutti i colori: rubava le ricette mediche per procurarsi la codeina; una volta lo vidi da una fessura di un portone che si scolava una bottiglia di medicina, ma colto sul fatto negava; tipico dei drogato che negano sempre tutti anche di fronte all’evidenza. A un certo punto Littman ebbe, con Tommasi, un sassofonista svedese e altri due, un contratto in Egitto dove venivano pagati molto bene: tornarono con una giardinetta (le attuali station vagon) carica di sacchi di oppio e marijuana, che posteggiarono in via Rizzoli vicino a due bar frequentati da ragazzi-bene; e con l’auto ferma i musicisti stavano fumando quella roba, entrammo io e Cicci Foresti uscendo non ti dico come.
D Hai dunque stretto molte amicizie in quegli anni?
R Ci fu a Bologna un altro gruppo dove suonava il sassofonista belga Jacques Peltzer, con il quale diventammo talmente amici che la prima volta che venne in Europa Canniball Addereley per il Festival di Comblein La Tour (Liegi), io Foresti, Littman e pochi altri fummo ospiti a casa di Peltzer, il cui padre era diventato ricco grazie a una grande farmacia, dove Chet Baker si riforniva quasi regolarmente grazie al figlio all’insaputa del farmacista. Altri belgi del gruppo erano, molto simpatici, Bobby Jaspar al flauto e ai sassofoni e René Thomas alla chitarra che mi diceva di essere l’uomo più felice del mondo: “Ho la mia chitarra, mia moglie, la mia Cinquecento”, questi qui, i Belgi, improvvisavano serate tutte gratis.
D Contemporaneamente non comincia a decollare la carriera di Alberto?
R Sì nel 1957 ci fu il primo grande concerto al Teatro Duse con Gerry Mulligan, che venne finanziato dal principe Alvise Ercolani convinto, fra molte titubanze, benché l’iniziativa si rivelò un successo strepitoso. Qualche anno dopo c’è il secondo grande concerto, che dà ad Alberto la spinta di lavorare con il Comune: era il gruppo di Horace Silver che sanciva la distinzione fra West Coast Jazz e East Coast; condussi Silver, che amava vestirsi elegantemente in piazza Mercanzia da Cesare un bel negozio di abbigliamento, dove comprò due vestiti e un cappotto di cammello. Il negoziante vorrebbe regalargli due cravatte ma il pianista non osò accettarle e preferì pagarle. Ma della carriera di Alberto parleremo un’altra volta…


Il Prof. Giorgio Alberti è presidente onorario del Premio Perugia, Alberto Alberti per il Jazz.