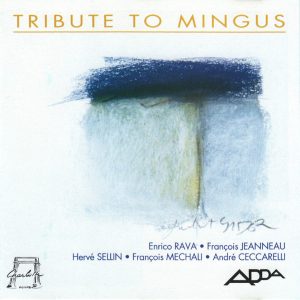John Coltrane, il dramma dell’anticipatore. Il 17 luglio del 1967 moriva una delle figure più emblematiche del jazz di tutte le epoche

// di Gina Ambrosi //
John Coltrane è stata una delle figure più geniali, ma al contempo più complesse ed enigmatiche della storia del jazz. Una volta Jimmy Cobb disse: «Miles non sapeva darsi pace per la partenza di Coltrane dal gruppo, perché John non si poteva rimpiazzare: con lui era come avere un’orchestra di sassofoni». La sua lunga discografia, per l’ascoltatore meno esperto, potrebbe apparire come una sorta di corsa ad ostacoli dove, man mano che si procede nel tragitto, le difficoltà aumentano. Per contro, tutto ciò è inversamente proporzionale al grado di maturità espressiva e compositiva del sassofonista. Per una facile comprensione, tale discografia va spacchettata e suddivisa in almeno cinque differenti periodi, che segnano altrettante tappe del «Trane-pensiero», fissando alcuni precisi punti di ancoraggio in quello che potrebbe essere, diversamente, un mare magnum, nel quale risulterebbe difficile districarsi o trovare un approdo.
Nella vita artistica di John Coltrane ci sono stati parecchi moti ascensionali, che non riguardano solo l’ultima febbricitante parte della carriera in preda ai demoni creativi, momento in cui il talento del sassofonista divenne un vortice espressivo in grado di delineare percorsi assolutamente inediti e non facilmente catalogabili, che rimangono tali, poiché troppo complessi per essere ridotti in vocaboli semplici per principianti o ad un volgare vernacolo jazz da work-shop per apprendisti stregoni. Per contro, non possono essere considerati funzionali al solo maneggio, alla promozione e alla diffusione dell’opera tout court. Perfino alcuni blasonati critici, in certi momenti della carriera di Coltrane, hanno stentato a comprenderne le finalità. L’unica divinità, a cui il sassofonista si sia immolato nel corso della propria esistenza, fu la «musikè», l’arte delle muse, che trasportava gli animi ben oltre i sensi, capace di incantare i devoti; insomma, sembrava che il sassofonista volesse dire velatamente alla musica: «Non avrò altra divinità all’infuori di te!». Ciò si presta molto ad un’analisi scarnificata, concreta e realistica del personaggio Coltrane che, a parte altre muse ispiratrici come le droghe o una sorta di pseudo-misticismo giustificativo, era un animo sensibile, subiva la vita e fu condizionato dall’andamento chiaramente difficile ed altalenante della carriera.
Red Garland esprime parole assai eloquenti, che inquadrano alla perfezione la figura del sassofonista: «Sì, ricordo la registrazione di «Invitation», come, del resto, ricordo tutte le altre effettuate con Trane. Come non potrei? Neppure Miles Davis potrebbe dimenticare ogni istante in cui ha soffiato accanto a quel colosso. Stare accanto a Coltrane è stato più che un’esperienza impagabile. Lui iniziava a soffiare e ognuno di noi veniva immediatamente catturato nella sua rete. Non potevi più uscirne fuori. Ma, in verità, nessuno di noi ha mai tentato di uscirne: era ammaliato, stregato, plasmato, annientato dalla sua musica, dalle note che quel sassofono sfornava a getto continuo, senza tregua, senza remissione. Note incandescenti che avrebbero potuto anche ustionarti. E tutte con un preciso significato. Trane non ha mai fatto nulla in cui non credesse fortemente e che non sentisse intensamente. Era un uomo sincero, un passionale. Si è distrutto suonando troppo. La creatività, che aveva dentro e non gli dava tregua, lo ha fatto morire. Invitation? Che dire. C’è tutto Trane in quel lunghissimo assolo. Tutta la sua arte, il suo cuore, la sua umanità. Dopo Charlie Parker è arrivato Trane. Poi, quando anche lui è scomparso, è rimasto il deserto. Arriverà un altro messia? All’orizzonte non appare nessuno». Oggi, ex-post, possiamo affermare senza tema di smentita, che all’orizzonte nulla di simile sia più apparso, se non tanti succedanei o replicanti spesso osannati dai critici, ma presto passati in cavalleria o riposti nel piccolo alveo della loro reale dimensione. Quando Coltrane avvicinava l’ancia alla bocca, tutt’attorno iniziava a svilupparsi un’aura di sospensione dal tempo e dallo spazio dei comuni mortali, mentre lui s’inabissava in un universo parallelo profondo ed oscuro, tentando di liberare la struttura armonica, denudandola sino all’intima tensione, quasi alla ricerca di un punto di rottura con la banalità o l’arte del prevedibile.
La spasmodica ricerca di una visione che potesse indirizzarlo verso un approdo, attraverso quell’infinita scomposizione di frasi e di schemi convenzionali, diventa il carburante di un motu proprio, cosi come una sorta di camera di decompressione creativa che il sassofonista aveva cocciutamente agognato, quale effetto catartico e rigenerante della sua arte in perenne divenire. A partire da un certo punto della carriera di Trane sembrerebbe che nella sua musica linguaggi e ritmi, fraseggi e strutture tradizionali venissero centrifugati per poi assumere forme inedite esposte in una nuova dimensione e con un vigore non comune. Un inarrestabile effluvio sonoro denso e magnetico, un sorgivo gorgo di espressività affrancata dalle catene del conformismo, lontana dal classico kit di montaggio usato da quanti in quegli anni operavano nell’ambito dell’hard bop straight-ahead. Forse in Coltrane viveva quello che molti studiosi chiamano «il dramma dell’anticipatore», ossia un divorante desiderio di andare oltre i limiti; un complesso stato che ha portato nel corso della storia geni come Leonardo da Vinci ad anticipare, anche di centinaia di anni, innumerevoli scoperte ed invenzioni. Al netto dell’ardimentoso paragone, la similitudine ha la funzione di sottolineare il concetto di «ansia creativa», non sempre facile da controllare.
Il biografo di Leonardo, Dmitrij Merezkovskij, lo definì: «Uno che si svegliava troppo presto mentre tutti gli altri attorno a lui dormivano ancora». La metafora è assai calzante anche per Coltrane, il quale, come il Da Vinci, precorreva il futuro ma si scontrava inesorabilmente con i limitati mezzi tecnici e l’ottusità del presente. Forse il merito principale di Leonardo, così come quello di Trane, è stato l’aver dimostrato che la ricerca della bellezza, dell’originalità e della verità non sono incompatibili. Tra arte e scienza, per Leonardo, non c’era confine, così come la musica per il sassofonista non aveva confini inesplorabili. Se ogni giorno migliaia di persone si accalcano al Louvre per vedere e fotografare la Gioconda, fenomeno unico al mondo, una ragione ci sarà, così come ancora milioni di persone ascoltano «A Love Supreme». Tutto ciò basta per definire il suo creatore un genio. Ciononostante l’ormone creativo sprigionato dalle ghiandole sonore di Coltrane aveva una contiguità ed una fisiologica compatibilità con tutto ciò che il mondo jazz aveva elaborato sino a quel momento, anche se dopo di lui quel microcosmo, perfetto in apparenza, non sarebbe stato più lo stesso. Con il fluire degli anni i precetti, le invenzioni ed i dettami di Coltrane sono diventati un ottimo terreno di coltura ed un paradigma ispirativo per intere generazioni di aspiranti jazzisti provenienti da ogni dove. In tanti hanno cercato di far tesoro degli insegnamenti e delle intuizioni del «maestro» al fine di oltrepassare il perimetro dell’omologazione, sicuramente più di quanto una certa critica, poco lungimirante, potesse prevedere. Il messaggio di Coltrane è diventato quasi ecumenico, per quanto l’analisi logica del Trane-pensiero non fosse del tutto facile da decifrare. Un pensiero ed un modus operandi che dividono spesso cultori e studiosi, tra «Apocalittici e Integrati». Del resto, come sosteneva proprio Umberto Eco: «Un pensiero non è un vero pensiero se non è divisorio, quanto meno manca di forza penetrante».
L’opera coltraniana è stata più volte analizzata e studiata sotto molti profili: compositivo, esecutivo, umano, ambientale. Specie sull’ultima fase della carriera del sassofonista sono stati sprecati e si sprecano ancora una serie di luoghi comuni: le posizioni in merito diventano nette ed antitetiche, per cui si parla di capolavori assoluti o di inevitabile e incomprensibile deriva verso il caos, tralasciando le sfumature intermedie che potrebbero agevolare la comprensione. Se sue parole sono alquanto chiarificatrici: «Non c’è mai fine. Ci sono sempre dei suoni nuovi da immaginare, nuovi sentimenti da sperimentare. Poi c’è la necessità di purificare maggiormente questi sentimenti, questi suoni, per arrivare ad immaginare allo stato puro ciò che abbiamo scoperto, in modo da riuscire a vedere con maggior chiarezza ciò che siamo. Solo così riusciremo a dare a chi ascolta l’essenza del nostro meglio».