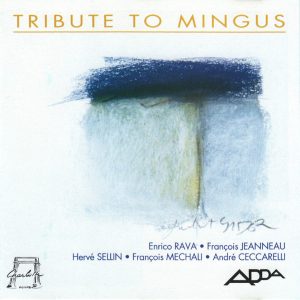La ricerca sulle influenze africane nel flamenco ha origini lontane
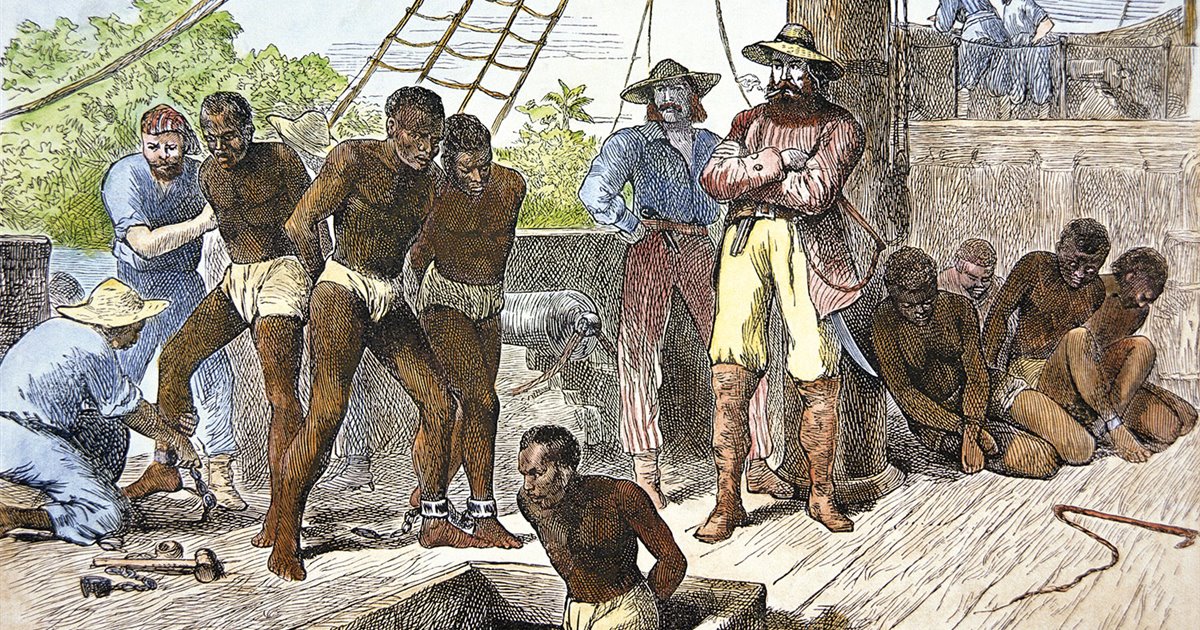
// di Gianni Morelenbaum Gualberto //
Diamo un’occhiata ai 30 secondi di un filmato: https://www.youtube.com/watch?v=QSC2QHJVRP0, realizzato dai Fratelli Lumière nel 1900, alla Exposition Universelle di Parigi. Esso riprende un gruppo di danzatori di flamenco (fu l’Esposizione Universale di Parigi del 1889 a diffondere le tradizioni musicali spagnole. Al Cirque d’Hiver fuono organizzate esibizioni di cante e baile flamenco, come quelli di Juana la Macarrona che si esibì per la prima volta davanti al pubblico francese. A tale evento parteciparono duecento ballerini e ballerine spagnoli che ballavano il fandango, il tango e altre danze popolari spagnole), in cui, ad accompagnare una ballerina si leva un danzatore dagli inconfondibili tratti africani. Si trattava di Jacinto Padilla, conosciuto come “El Negro Meri”, ballerino, toreador, acrobata che arricchì con la sua peculiare fisicità gli spettacoli di un cantante come El Piyayo e della famiglia gitano-barcellonese Farruco. La presenza di un ballerino afro-iberico non deve stupire, per quanto di essa si sia taciuto a lungo, figura posta al crocevia fra l’influenza afro-iberica- caraibica in quegli Stati Uniti da poco emersi da e una tradizione europea spesso volutamente dimenticata. Anche nel mondo musicale popolare spagnolo esiste un gruppo di palos flamenchi classificati come “cantes de ida y vuelta” (canzoni di andata e ritorno, alludendo al tragitto verso l’America Latina), e si ritiene che la maggior parte di essi sia influenzata dalla musica afro-cubana. Tra queste vi sono le Guajira, le Colombiana, le Milonga, le Vidalita, le Rumba.
La ricerca sulle influenze africane nel flamenco ha origini lontane. Già a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, lo studioso Jesús Cosano Prieto ha iniziato a interessarsi (a partire dal volume “Los Invisibles. Hechos y cosas de los negros de Sevilla”, Rústica, Sevilla 2017) e a rendere note a queste origini, fino ad allora materia solo per specialisti, sulla base del ruolo decisivo svolto dalla musica caraibica nella formazione del flamenco. Ma è solo di recente che più studi hanno iniziato a divulgare estesamente la presenza africana in Andalusia. Non tutti, ovviamente, hanno a che fare con il flamenco in sé: molte di queste ricerche ruotano attorno alla presenza di popolazioni dell’Africa occidentale (principalmente del Golfo di Guinea) a Cadice e Siviglia già prima della schiavitù. Isidoro Moreno Navarro (“La antigua hermandad de los negros de Sevilla”, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1997), professore di antropologia sociale all’Università di Siviglia, sostiene che all’apice dell’impero spagnolo la popolazione africana o meticcia a Siviglia raggiungeva il 15%.
Il ruolo decisivo degli africani nella storia e nella cultura spagnola e occidentale, non solo nel flamenco, è spesso reso invisibile. Si conosce il caso di Juan de Pareja, pittore schiavo e poi discepolo di Diego de Velázquez (che lo liberò nel 1651), il cui autoritratto il Museo del Prado si rifiutò di acquisire nonostante avesse la possibilità di farlo ed è attualmente esposto al Metropolitan di New York, dove è attualmente in corso una mostra intitolata “Juan de Pareja, Afro-Hispanic Painter” in cui si ricordano pure le ricerche di Arthur Schomburg, storico africano-americano della Harlem Renaissance che al pittore afro-iberico dedicò i primi, importanti studi. Pareja era originario di Antequera (Malaga) ed era di origine africana: in Spagna, e in particolare nelle città che hanno avuto un ruolo decisivo nella costruzione del mondo moderno (Siviglia e Cadice, come porti fondamentali per gli scambi commerciali nei secoli XV-XVII), c’è ancora oggi una certa resistenza a discutere del suo lavoro e della sua identità etnica.
Navarro cita numerosi riferimenti artistici, soprattutto nella letteratura del Siglo de Oro, in cui si parla della presenza africana. L’antropologo Miguel Ángel Rosales, autore di saggi in materia e di un affascinante documentario, “Gurumbé, canciones de tu memoria negra” (on demand su https://vimeo.com/ondemand/gurumbe/193403674, o stralcio su https://www.youtube.com/watch?v=CKkJomDwxkw) delinea il percorso storico: “Si fa sembrare che l’intera questione della tratta degli schiavi inizi in un momento specifico, alla fine del XV secolo. Gli schiavi erano già arrivati in Europa in precedenza, ma non in modo così sistematico, come valore merceologico e con volumi così elevati. Ciò che cambia è anche l’area geografica di questi schiavi: prima c’erano molti africani, ma anche schiavi, prigionieri di guerra. Furono i portoghesi a iniziare e gli spagnoli li seguirono rapidamente, sbarcando schiavi nel porto di Siviglia. Il fatto è che ciò non solo precede la tratta atlantica degli schiavi, ma che l’intera attività veniva svolta dal territorio iberico. Alcuni africani furono portati in America, ma molti rimasero. E’ vero che vi era grande richiesta americana di manodopera, ma la richiesta primaria nasceva prima in Andalusia e poi nel resto della Spagna. Siviglia divenne un grande porto di schiavi, e in seguito anche Barcellona e Cadice.
Siviglia, infatti, con l’importanza assunta dal commercio con le colonie americane, divenne una grande metropoli. Si cominciò a notare una differenza con il commercio delle piantagioni; qui c’era una certa interazione con la popolazione schiava, ma questo non significava che non venissero trattati in modo crudele e umiliante. C’erano anche molti matrimoni, che hanno dato origine a un’importanza culturale molto forte e hanno portato alla formazione di una popolazione afro-andalusa. Ora è marginale, ma ci sono alcune figure afro-andaluse che sono diventate importanti. Tutte queste ricerche stanno emergendo ora. La schiavitù in Spagna è stata studiata fin dagli anni Cinquanta, ma con stereotipi che vedevano la schiavitù come un oggetto di ostentazione o di lusso. Questa teoria è stata poi smantellata e si è cominciato a studiare l’interazione culturale. A Siviglia nel XVI e XVII secolo la popolazione nera e meticcia poteva essere tra il 10 e il 15%, il che deve aver avuto un’influenza molto forte. A livello archivistico, molto si può vedere sul tema delle cofradías (confraternite). Molte delle prime confraternite religiose erano composte da schiavi neri. C’erano arcivescovi che formavano queste confraternite e gli schiavi se ne appropriavano perché questo dava loro visibilità sociale e un luogo di incontro dove formare una comunità, essendo una popolazione totalmente emarginata e invisibile. Cominciarono ad avere un’influenza sulla musica, come molti popoli africani che hanno come grandi espressioni artistiche la musica e la danza, qui tutte le principali danze che nascono nella Penisola Iberica provengono dagli schiavi neri, come il cumbé. Vi era inoltre un rapporto con le colonie americane e si formarono sincretismi musicali. Quando nel XIX secolo nasce il flamenco, assorbendo molto di tutto questo, sintetizzando la musica popolare e creando quasi la prima musica moderna in Europa, lo fa con questi elementi, con un fattore africano molto importante.
D’altra parte, a Siviglia esiste attualmente una confraternita chiamata Los Negritos, e non molti sanno che si chiama così perché era una confraternita di neri, ed è la più antica confraternita di Siviglia. Ci fu un momento in cui ci fu una lotta politica ed etnica intorno alle confraternite, e le classi superiori riuscirono a togliere il posto principale che le confraternite di schiavi avevano, e molte di esse scomparvero. C’erano confraternite di schiavi in tutti i luoghi dove c’era una popolazione di origine africana, come Cadiz o Jerez. A parte il fatto che trovavo l’argomento affascinante, mi sorprendeva che non avesse goduto di una ripercussione più importante, che non vi fosse nulla a livello informativo al riguardo. In Spagna c’è sempre stato il desiderio di cancellare tutto ciò che riguardava il genocidio e il suo ruolo nella tratta degli schiavi. La Spagna, insieme al Portogallo, è quella che ha dato il via alla tratta degli schiavi, ha dato il segnale di partenza e gli olandesi e gli inglesi hanno copiato il modello. E sebbene la schiavitù arrivi fino al XIX secolo, la Spagna è stata l’ultimo Paese ad abolirla e i suoi effetti arrivano fino agli anni ’60 con il regime di Franco, quando la Guinea Equatoriale divenne indipendente. L’aspetto interessante della schiavitù, non come fatto storico, è che creò un sistema produttivo che si spinse finché la comunità internazionale iniziò a fare pressioni sulla Spagna perché lo abbandonasse, e produsse tutta una serie di stereotipi sugli africani che sono ancora vivi oggi e si proiettano sul fenomeno dell’immigrazione” (https://www.elsaltodiario.com/…/miguel-angel-rosales…).
Il flamenco è una forma d’arte giovane, consolidatasi come tale solo a metà del XIX secolo, e la ricerca storica e antropologica sulle sue origini è ancora più recente. “La narrazione delle sue origini ha cancellato l’influenza degli africani nella sua costruzione”, afferma Rosales. Le sue radici hanno sempre tenuto conto della partecipazione decisiva dei gitani come agenti determinanti che hanno sfruttato la propria cultura, alla quale hanno incorporato elementi del folklore dell’epoca e della musica andalusa. “Spesso si parla del flamenco come se fosse un universo estetico omogeneo”, spiega Rosales. “E bisogna inserire il pezzo mancante nella composizione di quella che è una forma artistica di origine popolare in Andalusia; non come origine di qualcosa che stava per essere creato, ma come forza di qualcosa che viene continuamente creato”. K. Meira Goldberg, in “Sonidos Negros. On the Blackness of Flamenco” (Oxford University Press, Oxford 2019) approfondisce alcune di queste problematiche. Ella sostiene che sia stata l’ossessione per la pulizia del sangue nel Siglo de Oro, che emarginava coloro che non potevano essere considerati cristiani di vecchia data per eliminare qualsiasi centro di potere estraneo alla monarchia cristiana, a imprimere al flamenco le caratteristiche che secoli dopo sarebbero state apprezzate nel XIX secolo e che Manuel de Falla, Federico García Lorca e altri intellettuali avrebbero finito per stabilire negli anni Venti. La danza libera e sensuale, di origine un po’ misteriosa e trasmessa solo all’interno delle famiglie, è ciò che in seguito sarà considerato il tratto più caratteristico del flamenco e, per estensione, fuori dalla Spagna, di ciò che è spagnolo.
Le immagini del “Negro Meri” riprese dai fratelli Lumiére fanno parte delle fiere del corpo organizzate all’inizio del XX secolo in Francia. I corpi cominciarono a essere esposti come se fossero sculture e all’Esposizione di Parigi il flamenco veniva già presentato come qualcosa di esotico: per le culture bianche eurocentriche non vi è distinzione fra negritudini e l’immagine dell’Andalusia con i suoi flamenco rientra in tale categoria”. Con il passare dei secoli, molti schiavi poterono acquistare la loro libertà e vivere nelle stesse comunità povere fuori dalle mura di Siviglia e Cadiz come i gitani, i moriscos e altri gruppi sociali considerati di rango inferiore per non essere antichi cristiani, per non avere la purezza del sangue. Quando si parla di “negritud”, può albergare in alcuni il sospetto che si voglia trascurare l’importanza dei gitani nella nascita del flamenco. In realtà, studi recenti recenti dimostrano che le comunità gitane vivevano in un contesto molto più etnicamente promiscuo, a stretto contatto delle comunità africane e moresche. Quello che taluni si propongono è di rileggere o mappare la storia per far emergere altre radici che hanno plasmato anche la storia del flamenco. E’ ciò che realizza con appassionante rigore Yinka Esi Graves, leader della compagnia “dotdotdot dance”, ballerina inglese di origini ghaniane e giamaicane, che nel flamenco recupera il senso collettivo delle festività africane e afro-caraibiche, l’abbandono estatico alla danza, la sensualità del tutto diversa dall’erotismo ispanico e caratterizzata da una vibrante vitalità atletica del corpo, la cui impressionante flessuosità indica una capacità drammatica peculiarmente forte e un rapporto con il suolo del tutto alieno alla civiltà europea. Il flamenco di Yinka Graves è frutto di un antico, elaborato, intricato processo di creolizzazione, la cui sofisticazione non è stata percepita per secoli dalla definizione di “esotismo” con cui l’eurocentrismo ha dannato tutto ciò che temeva o non capiva. Nella sua danza il flamenco non solo incontra il proprio passato, ma soprattutto il suo futuro.