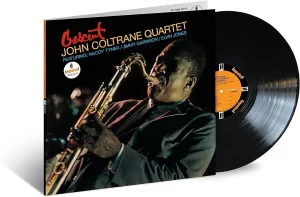Ethel Waters, il cosmopolitismo della musica improvvisata africano-americana essenzialmente urbana

// di Gianni Morelenbaum Gualberto //
È interessante, seppur ovvio, notare come in un’arte specificamente strumentale come il jazz il rapporto più esplicito con le tradizioni popolari fosse mantenuto attraverso il canto. Ciò ha stimolato un processo evolutivo dagli approcci fortemente originali, nei quali non si è perso di vista il rapporto con le origini così come uno specifico legame con la dimensione strumentale del linguaggio improvvisativo. La concomitanza fra l’emergere del jazz, l’eredità del “Black minstrelsy”, la diffusione del blues, l’avvento della discografia, l’affermazione di un’editoria africano-americana anche musicale, la sempre più forte presenza di artisti (e agenti) africano-americani sui palcoscenici teatrali di Broadway e nei circuiti del vaudeville doveva non solo esercitare un ruolo nell’ascesa della cosiddetta Harlem Renaissance ma doveva pure sviluppare, aldilà delle caratteristiche foniche e onomatopeiche della cosiddetta “novelty music”, le peculiarità del canto popolare africano-americano nel trapasso fra il blues rurale e il cosmopolitismo della musica improvvisata africano-americana essenzialmente urbana.
Vi è un legame forte fra interpreti nate nel blues come Mamie Smith, Bessie Smith, Alberta Hunter, Clara Smith, Ethel Waters, Lucille Hegamin, Trixie Smith, Ida Cox, Lovie Austin, Martha Copeland, Maggie Jones, Ma Rainey, Bessie Brown, Mary Stafford, Edith Wilson, Leona Williams, Irene Gibbons (Eva Taylor), Ethel Ridley, Rosa Henderson, e i risultati delle loro sempre più frequenti collaborazioni ed incisioni con accompagnatori e compositori provenienti dal jazz e dalla novelty music come Spencer Williams, Louis Armstrong, Fletcher Henderson, Clarence Williams, Noble Sissle, Thomas “Fats” Waller, Eubie Blake, James P. Johnson, Perry Bradford, Maceo Pinkard, Duke Ellington, Jelly Roll Morton, Henry Creamer, Edgar Dowell, Chris Smith, W. C. Handy, i quali ampliavano o modificavano il repertorio, aggiungendovi nuove interpretazioni e composizioni, per quanto talvolta limitate da un vocabolario musicale non particolarmente ricercato ma che pure, proprio per tale relativa semplicità, si dimostravano eccellenti veicoli per l’improvvisazione. “Maybe Not at All”, di Ethel Waters e Sidney Easton, fu registrata dalla stessa Waters per la Columbia Records il 28 ottobre 1925. I suoi accompagnatori, gli Ebony Four, erano Pearl Wright (la pianista scelta abitualmente dalla cantante) e due membri della Columbia “house band” di Fletcher Henderson, Joe Smith alla cornetta e Coleman Hawkins al sassofono baritono. Waters era sotto contratto con la Columbia da soli sei mesi quando incise “Maybe Not at All”, ma aveva registrato fin dal 1921 per etichette minori come Cardinal, Vocalion, Paramount e, soprattutto, Black Swan.
I tre minuti non sono una vera e propria interpretazione della pagina, ma una routine in cui l’artista dimostra le sue capacità e la sua duttilità di virtuosa vocale. Anche le due cantanti che imita, Clara Smith e Bessie Smith, erano artiste della Columbia: la reputazione di Clara Smith, che veniva indicata come la “Regina dei Moaners”, era seconda solo a quella di Bessie Smith, acclamata come “Imperatrice del Blues”. Ethel lancia il guanto di sfida alle sue nuove colleghe, sfidandone la giurisdizione sul proprio territorio: Clara Smith e Bessie Smith erano ben radicate nell’etichetta, avendo entrambe iniziato a registrare per essa nel 1923″. Sebbene sia un’aggiunta apparentemente incongrua al catalogo, “Maybe Not at All” si colloca perfettamente nel genere del vaudeville dell’impersonificazione femminile (da parte di uomini e donne), molto popolare nei primi tre decenni del secolo. L’arte esisteva su un continuum, da quella che cercava di riprodurre fedelmente a quella che esercitava una critica garbata, fino alla satira e alla parodia meno clementi. Come spiega Susan A. Glenn in “Give an Imitation of Me”: Vaudeville Mimics and the Play of the Self” (American Quarterly 50.1, 1998, pagg 47-76): “L’umorismo femminile sul palcoscenico assunse molte forme nei primi anni del XX secolo, ma quasi tutte le “funny women” utilizzarono un qualche tipo di comicità imitativa, e alcune ne fecero uso quasi esclusivo. Questo era vero per quella che un osservatore definì “l’epidemia” e un altro “il grande esercito” di imitatrici che si riversò sul palcoscenico del vaudeville a partire dai primi anni del 1900. La mimica e la parodia erano così popolari che una “rivista” musicale che si esibì a Chicago nel 1908 presentava diversi burlesque dedicati a tale tendenza, tra cui una canzone intitolata “The Imitation Craze”.
Sebbene anche gli interpreti maschili fossero coinvolti nell’”epidemia”, le imitazioni, soprattutto quelle di interpreti famosi, erano in gran parte appannaggio di interpreti comiche. Tra di loro c’erano le grandi attrazioni: Cecilia (Cissie) Loftus, Venita Gould, Gertrude Hoffmann, Elsie Janis e Juliet Delf (che, rinunciando al suo cognome e aggiungendo un punto interrogativo, si faceva chiamare semplicemente “Juliet?”). Queste artiste facevano parte di quello che si potrebbe definire un momento mimetico della commedia americana negli anni tra il 1890 e la fine degli anni Venti. Sul palcoscenico popolare del vaudeville e del musical revue ogni tipo di imitazione comica era in piena fioritura: il blackface minstrelsy, l’impersonificazione di genere, il burlesque, la parodia e la caricatura etnica. Ma si stava verificando anche qualcosa di nuovo. Mentre le performance delle donne imitatrici a volte comportavano l’impersonificazione di genere e l’imitazione di “altri” sotto il profilo razziale, il lavoro scenico di Juliet, Hoffmann, Loftus, Gould e Janis rappresentava anche una significativa rottura con tali tradizioni. A differenza di coloro che si dedicavano esclusivamente alla comicità della caricatura africano-americana e dell’impersonificazione di genere, i mimi del vaudeville andavano oltre le immagini generiche e stereotipate di etnia e di genere per approdare a quella che potrebbe essere meglio descritta come la commedia della personalità. Si trattava dell’imitazione, a volte in chiave satirica, dello stile e del repertorio particolare di individui specifici, soprattutto di noti interpreti femminili e maschili. Per la maggior parte del tempo impersonavano donne bianche come loro, donne che invidiavano o ammiravano.
Dal punto di vista dei mimi del vaudeville e del loro pubblico, era l’attenzione all’individuo piuttosto che a un tipo generico a distinguere la commedia della personalità da altre forme di umorismo mimetico. Come disse Cissie Loftus in un articolo del 1907, piuttosto che copiare “un tipo”, dove era necessaria solo “un’accuratezza generale”, le sue imitazioni richiedevano di “entrare dentro … e rivelare la vera personalità” “dell’individuo particolare”. Come scriveva Max Beerbohm: “La funzione propria del mimo è, ovviamente, come quella del parodista a parole o del caricaturista a tratto, quella di esagerare i punti salienti del suo soggetto in modo che, mentre ridiamo di un effetto grottesco superficiale, possiamo comprendere meglio l’anima del soggetto o, più propriamente, vedere quell’anima come appare all’interprete stesso” (Max Beerbohm, “A Play and a Mimic,” The Saturday Review, June 11, 1904, pag. 749). Ancora la Glenn ricorda e sottolinea: “La natura aggressiva e competitiva della mimica teatrale dei primi del Novecento era un esempio di celebrità femminile che utilizzava la celebrità di altri artisti per promuovere la propria carriera. Rendere omaggio agli altri era, in ultima analisi, un modo per attirare l’attenzione su di sé.” Come molti dei grandi imitatori del vaudeville, Ethel Waters iniziò la sua carriera come cantante e ballerina: per gli impresari la sua capacità di muoversi e di partecipare alle routine comiche era importante almeno quanto il suo canto. Il talento per la commedia e la danza l’aiutò senza dubbio a sopravvivere allo scemare della popolarità delle blues-women nella seconda metà degli anni Venti, ma il suo continuo successo fu probabilmente dovuto anche al suo approccio individuale all’arte del blues. Fin dall’inizio, la reputazione di Waters fu quella di un’interprete più raffinata rispetto alle sue coetanee, ed ella amava raccontare che un critico l’aveva definita la “Nora Bayes d’ebano” perché “era quella che non si abbandonava mai a urla e espressioni poco eleganti, ma cantava tutte le sue canzoni con raffinatezza”. Era anche più coinvolgente, trascinando il pubblico nella sua evocazione della miseria piuttosto che proiettarla in un’esibizione esteriore. Il cornettista Jimmy McPartland diceva di lei: “Cantava, amico, cantava davvero. Eravamo affascinati da lei. Ci piaceva molto anche Bessie Smith, ma la Waters era più raffinata (…) Aveva un fraseggio così meraviglioso, la qualità naturale della sua voce era così fine, e cantava in un modo(…)”.
E il modo lo spiegava bene la stessa Waters. “Poi cantavo “St. Louis Blues”, ma molto piano. Era la prima volta che quel tipo di pubblico nero ascoltava il mio il mio modo di cantare più controllato. E si sarebbe potuto sentire uno spillo cadere in quel pubblico di solito ruvido e chiassoso. Per anni erano stati abituati a “Bessie Smith e Ma Rainey”. Amavano loro e tutte le altre urlatrici. Io sono sempre stata in grado di fare riff, jam e growl, ma non ho mai avuto quell’approccio rumoroso”. “Maybe Not at All” è apparentemente una semplice routine di imitazioni. Waters inizia con una strofa e un ritornello secondo il suo approccio abituale, utilizzando una qualità vocale prevalentemente leggera che colora sollevando o abbassando la laringe, spostando la risonanza tra un “twang” nasale più grezzo e un lirico pseudo-“sob” più moderato; significativamente, si tiene lontana dal belting e termina il ritornello con una laringe nettamente abbassata. L’accompagnamento strumentale fa una pausa e lei annuncia: “Ora, come la signorina Clara Smith [che lei pronuncia “Schmidt”] canterebbe la stessa canzone…” Procede con un ritornello in piena regola, con tanto di twang e di interruzioni vocali consistenti in suoni ruvidi. Un’altra pausa ed esclama: “Ora mi preparo per l’imperatrice, Miss Bessie Smith-Lawd!”. Abbassando l’intonazione di una terza minore e rallentando il tempo, l’imitazione di Bessie Smith è condotta prevalentemente producendo suoni graffiati ed agendo sulle false corde.
In “Maybe Not at All”, Ethel canta una sua composizione, mai registrata da dalle due Smith. Grazie all’incisione, il pubblico poteva in qualche modo ascoltarle ripetutamente per giudicarne non tanto i meriti, ma la capacità della Waters di riprodurre i gesti stilistici e tonali di altri cantanti, alludendo con sufficiente accuratezza persino alle loro personalità. Inoltre, poteva anche meravigliarsi della sua abilità nello sradicare la propria personalità vocale distintiva per sostituirla con quella di un’altra. Viste le capacità mimetiche era probabilmente il caso che la vocalità di “Ethel Waters” riconosciuta come “autentica” fosse semplicemente la vocalità che l’interprete sceglieva più spesso per rappresentare sé stessa. Aldilà dell’abilità imitativa, che sottolineava la necessità di ogni interprete di dotarsi di caratteristiche individuali proprie uniche e irripetibili (esattamente come accade per il jazz e la musica improvvisata), Waters, seppur con ironia, segue una tradizione e porge un omaggio a due colleghe che, per quanto praticamente sue coetanee (le due Smith erano del 1894, Waters del 1896), si erano imposte prima di lei, stabilendo una lezione interpretativa duratura. In Ethel Waters l’impersonificazione era un tratto che comunque faceva parte della sua personalità, quella di un’interprete, a cavallo fra vaudeville, jazz, teatro musicale, cui forse solo Florence Mills poteva rapportarsi per sofisticazione. Era un modo tutto africano-americano di usare il corpo creativamente come vettore di una personalità complessa, sofisticata, erotica, policulturale, flessibile, duttile e profondamente urbana e americana, abile nel mescolarsi al gruppo come ad emergerne o a distaccarsene per passare ad un altro. Come spiegava bene la scrittrice e intellettuale Zora Neale Hurston, legata a Waters da forte amicizia: “È una delle persone più strane che abbia mai incontrato. Se la si frequenta a lungo, si possono vedere le diverse persone avvolte in lei. Proprio come guardare un fuoco all’aperto, il colore e la forma della sua personalità non sono mai gli stessi due volte. Ha talenti straordinari che solo la mancanza di un’istruzione formale le impedisce di mettere del tutto in mostra.”