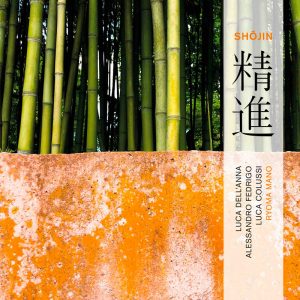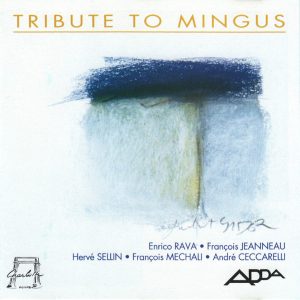“Però il jazz rimase”. Paola Silvia Dolci intervista Guido Michelone

//a Cura della Redazione //
A intervistare tocca stavolta alla giovane originalissima poetessa cremonese, autrice di numerosi volumi quasi sperimentali, in bilico tra lirica e narrativa. Paola Silvia Dolci pur lavorando come ingegnere civile, trova infatti il tempo e la passione per dedicarsi a mille attività culturali dal tradurre libri di letteratura e dirige la rivista indipendente «Niederngasse». Al proprio attivo vanta finora i dieci volumi Bagarre (Lietocolle, 2007), NuàdeCocò (Manni, 2011) Amiral Bragueton (Italic Pequod, 2013), I processi di ingrandimento delle immagini (Oèdipus, 2017), Bestiario metamorfosi (Gattomerlino Superstripes, 2019) e i recenti autobiografici Diario del sonno (LeLettere, 20219, Portolano (Mattioli1885, 2019), Dinosauri Psicopompi (Anterem, 2022), Abstine substine (Pièdimosca, 2023), oltre un libro segreto sotto pseudonimo nel 2021. Da sempre attratta dalle arti performative, anche grazie al diploma al Centro Nazionale di Drammaturgia, intrattiene con la musica un rapporto particolarissimo che la conduce ora a dialogare – in esclusiva per Doppio Jazz – con Guido Michelone, che, sul jazz, assieme a Francesco Cataldo verrina, è di recente tra gli autori più profili nella saggistica in volume.
D Guido, qual è il primo libro che hai letto? Ce lo racconti?
R Credo che sia Pinocchio, che tutti conosciamo, anche se alle elementari non amavo i libri ma i giornali a fumetti da Topolino al Corriere dei Piccoli. Val forse la pena ricordare il mio primo libro di jazz che ho letto: si tratta de I Grandi Del Jazz un volume di Franco Fayenz allegato a un cofanetto contenente un doppio Lp e un 45 giri di spiegazione che mia madre regalò a papà un Natale di tantissimi anni fa. Iniziai a sentire regolarmente quei due dischi antologici al Ginnasio e a leggiucchiare il Fayenz soprattutto le ultime parti dedicate agli sviluppi contemporanei (esclusi dalla raccolta che arriva a Parker e Gillespie). Poi un pomeriggio in libreria trovai Guida elementare al jazz sempre di Fayenz che, fin dalla copertina, mi sembrava più adatto alle mie esigenze: e lo lessi tutto d’un fiato anche perché era la trascrizione delle conferenze che teneva in quei primi anni Settanta (e che anni dopo ascoltai anch’io), dove trattava anche gli allora contemporanei (addirittura Keith Jarrett). Alla fine del liceo compravo regolarmente ogni mese la rivista Musica Jazz e da lì ho accresciuto il mio bagaglio culturale in merito al jazz.
D Qual è stata la tua prima esperienza significativa con la musica jazz
R La prima consapevole credo siano i primi dischi, tutti a 45 giri, che arrivarono a casa mia con l’acquisto di un giradischi quando già abitavo nel nuovo appartamento e dunque potevo avere quattro o cinque anni. Ma avevamo già la televisione, che trasmetteva qualcosa di jazz. Comunque ricordo ancora benissimo quando mia mamma, una volta arrivato in casa il giradischi, grazie a mio zio che lavorava come operaio in una fabbrica che li produceva, chiese, per provare l’apparecchio, proprio a mio zio di fare un salto in un negozietto dietro l’angolo a comprarci due-tre 45 giri per varare il funzionamento della bellissima fonovaligia. E torno con un Nat King Cole (Blue Gardenia, mi pare) e soprattutto il singolo September In The Rain di Frank Sinatra, lato B Blue Moon; purtroppo la collezione di 45 girti fu regalata non so a chi – e non da me – poco prima che mi sposassi e cambiassi casa. Peccato! C’erano cose bellissime. I 33 giri di mio padre invece ancora li ho e li ascolto tuttora.
D E come questa tua prima esperienza ha influenzato il tuo percorso professionale?
R È riuscita a mantenere in me vivo l’interesse del jazz nonostante i cambiamenti talvolta bruschi nei mie gusti musicali. Da preadolescente mi innamorati della musica beat o yé-yé allora di moda (metà anni Sessanta) che invece i mie genitori detestavano. Al Liceo seguii in parte le mode rock (prog e cantautori) mentre invece fui interessato a ritroso grazie a due miei compagni di classe a seguire rispettivamente i Beatles (di cui poi diventai tuttologo o quasi) e la musica classica (che non ho mai abbandonato, anzi in questi ultimi cinque-sei anni ho intensificato l’ascolto grazie alle mie recensioni discografiche per Il Manifesto). Però il jazz rimase, anche se nessuno dei miei amici lo ascoltava o ne era interessato. Quando mi iscrissi alla facoltà di Lettere a Torino diedi tre esami di Storia della Musica che erano solo sulla classica; non c’erano corsi di Storia del Jazz e della Popular Music come adesso, altrimenti li avrei frequentati al volo e avrei chiesto subito la tesi, tesi che feci in Semiologia, ma semiologia della musica, dove purtroppo, anche qui, il jazz era assente, come quasi tutta la musica pop (di cui il rock fa parte). Seguirono anni in cui intrapresi l’attività giornalistica locale, scrivendo anche di jazz, ma in genere di qualsiasi argomento culturale, con la speranza di fare il grande salto verso qualche testata importante. Visto che in me in quei primi anni Ottanta era sempre più forte la mia passione per il cinema mi iscrissi a una scuola di specializzazione (oggi sarebbe una laurea breve) in scienze dello spettacolo (cinema, teatro, televisione) nella speranza di rimanerci come assistente e poi come professore. Non andò proprio così, ma, sapendo della mia passione sempre più seria verso il jazz con le prime importanti collaborazioni (il mensile «Musica Jazz» in primis) fui chiamato a occuparmi di Storia della Musica e poi a fondare quello che nel giro di poco tempo si trasformò in master (oggi tra i master più longevi di tutt’Italia) dove mi crearono la cattedra in Storia della Musica Afroamericana (non solo jazz, ma anche blues, gospel, R’n’B, solo, funk, rap) che tuttora tengo.
D Quali sono le tue fonti di ispirazione principali quando scrivi sulle tematiche legate alla musica e al jazz?
R Qualche volta, quando è possibile, notizie di prima mano, ossia i jazzisti da me intervistati come nel mio recente volume Il jazz e l’Italia (Arcana, 2023), oltre i libri che leggo o studio. Per quanto riguarda il jazz credo di avere il 90% di quanto è uscito il Italia dal 1928 a oggi. Ma ho anche testi in lingua francese, inglese, spagnola, portoghese, rumeno, olandese, svedese. Poi le riviste, come Musica Jazz di cui posseggo quasi tutte le annate dal 1950 a oggi e molte altre testate ora defunte da «Jazz di Ieri e di Oggi» a «Blu Jazz». Trovo notizie anche in rete, ma occorre stare molto attenti e confrontarle con altre fonti. Tutto questo si riferisce alla saggistica, che, persino quando è divulgativa, deve sempre essere scientifica, ossia oggettivamente verificabile. E quando si scende nel gusto personale, dichiarare subito il proprio punto di vista e non far passare passioni individuali per leggi eterne, come accade a molti critici presuntuosi. Nel caso invece della mia fiction ispirata al jazz invento molto, proprio perché si tratta di ‘finzione’.
D Come definiresti l’importanza della cultura musicale nel contesto più ampio della società moderna e dell’istruzione italiana?
R Enorme! La definirei un’importanza enorme che però il mondo politico non riesce a valorizzare anzitutto nella scuola: la musica dovrebbe essere una materia basica assoluta dalle materne all’università. Una volta si diceva imparare a leggere, scrivere e far di conto e ora io aggiungerei e ‘e fare musica’ – e dico anche: teatro! – tutti insieme! Nella mia lunga esperienza di docente ho avuto in tal senso due fondamentali risconti: il primo in Conservatorio – unica istituzione dove possono iscriversi sia bambini sia adulti – con i miei allievi del corso di Laurea in Jazz motivatissimi. Quelli più motivati in assoluto! Persino più di quelli già laureati dei master in musica dove in molti si accontentano di continuare ad apprezzare i propri generi musicali (di solito, pop, rock e affini) e restano impermeabili alle novità (come il jazz) in una fascia d’età che invece dovrebbe essere di grande apertura mentale! Il secondo riscontro riguarda il liceo musicale che funziona soprattutto nelle materie come musica d’insieme dove un quattordicenne entra convinto di voler strimpellare la chitarra pop e già a metà anno, con ottima autodisciplina, è inquadrato in un’orchestra classica. Il lavoro di gruppo a scuola dovrebbe essere dunque maggiormente valorizzato nelle discipline performative come appunto la musica, ma anche il teatro o il cinema. Mi accorgo di aver parlato solo dell’istruzione italiana e non della società moderna. Però credo che in fondo la scuola sia la metafora di quanto avvenga nel mondo adulto dal lavoro al passatempo
D Ci sono particolari innovazioni o sviluppi recenti nel mondo della musica che ritieni abbiano un impatto significativo sulle generazioni future?
R La musica liquida è già da vent’anni una rivoluzione o una mezza rivoluzione, con grandi potenzialità, anche se poco sfruttate al meglio. Ma nella musica – come anche in pittura o in molti altri linguaggi artistici – si assiste spesso a un paradosso: ogni qual volta emerge una tecnologia che sembra soppiantare quanto fatto in precedenza, c’è poi anche un ritorno alla tradizione. Negli anni Cinquanta e Sessanta sembrava che il nastro magnetico della musica colta elettronica dovesse sostituire gli strumenti musicali tradizionali (perfezionati grosso modo dal Barocco fino a metà Ottocento), ma poi invece i compositori sono tornati a scrivere per orchestre, quartetti d’archi, ensemble di fiati o pianoforte solo. Idem con il jazz elettrico che non ha mai soppiantato quello acustico. E a livello di riproduzione sonora che dire del ritorno – accanto alla musica liquida – al vinile soprattutto nel jazz e nel rock?
D Qual è stata la tua esperienza più memorabile o gratificante come esperto di jazz e musicologo?
R Voglio subito precisare che non sono un musicologo in senso stretto: a livello universitario mi sono laureato in lettere moderne, sostenendo esami di storia della musica e di filologia musicale, oltre a dare la tesi in semiologia della musica, cercando gli studi innovativi e meno musicologici in senso classico. Del resto trovo alquanto limitante l’applicazione della musicologia tradizionale o classica a fenomeni come il jazz o il rock. Detto questo l’esperienza più memorabile riguarda invece il rock, ossia l’essere contattato dalla Oxford Universitry Press per compilare la voce Rock per la World Encyclopedia. Quelle più gratificanti sono i tanti libri sul jazz che ho pubblicato e che hanno creato invidie o gelosie presso molti colleghi al punto da venire boicottato nei giri delle recensioni e delle presentazioni in pubblico.
D Come credi che la musica, e in particolare il jazz, possa contribuire al dialogo interculturale e alla comprensione reciproca.
R Ci voglio credere e ci voglio sperare anche se dopo tanti anni di battaglie anche personali sono un po’ pessimista. La gente – almeno in Italia – è pigra nel senso che coltiva, dopo il lavoro, quasi sempre un solo interesse monotematico, senza saper o voler collegare i vari fenomeni esistenti. Ci sono scrittori che ad esempio leggono solo libri e non vedono una mostra, non guardano un film, non sento un disco di jazz o di classica o di rock. Ma ci sono anche cultori della classica che rifiutano il jazz e viceversa, il che è sbagliato. Io ascolto ogni tipo di musica! Ma anche tra i musicisti – i jazzisti ad esempio – tanti pensano solo a provare e suonare e non vanno ai concerti degli altri e non hanno il minimo desiderio di approfondire la conoscenza della storia del jazz, al di fuori di qualche solista che idolatrano fin troppo acriticamente.
D Vercelli è la tua città natale e l’ambientazione di alcune delle tue opere. In che modo la tua connessione con questo luogo ha plasmato la tua narrativa?
R Ho scritto due saggi su Vercelli – uno sulla musica Vercelli nel juke box, l’altro una guida turistica Vercelli 360° – e un lungo racconto che ha dato il titolo a una raccolta di racconti sempre più brevi, fino all’ultimo di mezza pagina, dal titolo Parigi a Vercelli. Nel racconto ho immaginato un regista francese che viene a vivere in incognito a Vercelli per prendersi una vacanza dal caos mediatico cittadino: ho voluto citare luoghi, come vie, piazze, ma anche bar e ristoranti che frequento, ma semplicemente per gioco. Un gioco letterario, ovviamente! Ma la mia città ha plasmato la mia cultura in negativo: è un luogo così privo di effervescenza intellettuale e artistica (tranne eccezioni individuali fin troppo autoreferenziali) da attivare in me una sorta di reazione a questo torpore, scrivendo, circondandomi di libri, dischi e quadri (comprati con soldi guadagnati onestamente) e organizzando, nel tempo, diversi eventuali che poi la città dimentica o rimuove a velocità supersonica, salvo poi riproporli senza di me e spacciando come novità assoluta intergalattiche.
D La tua saggistica si estende su jazz, cinema, rock e canzone. C’è un argomento che trovi particolarmente affascinante o che ritieni meriti ulteriori esplorazioni?
R Ho scritto anche libri sulla televisione (quando me ne occupavo in università) e sulle arti figurative (raccogliendo testi sparsi in riviste, dove c’è materiale anche per un secondo volume). E ho pubblicato un volume sullo sport (naturalmente sui rapporti tra sport e cultura, in particolare il calcio e le Olimpiadi) argomento che mi piacerebbe approfondire ovviamente secondo il mio punto di vista di uomo di cultura e non di giornalista sportivo che non sono. Anche la storia contemporanea mi piace molto ma non da scriverne un libro perché farei torto ai veri storici e io odio chi si improvvisa astronomo, filosofo, politologo o critico rock. Prima di pubblicare un saggio vero bisogna studiare. E tanto!
D La tua produzione spazia tra romanzi, racconti, poesie e atti teatrali. Come gestisci il dialogo creativo tra questi diversi generi letterari?
R Un tempo era proprio la musica – il jazz in particolare – a far da da tramite: ho pubblicato sei atti unici in un libretto intitolato Teatro Jazz e l’unico mio libro di poesie s’intitola Quasi dei blues. Per alcuni anni ho fatto spettacoli di jazz-poetry dove leggevo i miei testi interagendo con un jazzista o una jazz band. E cercavo davvero di trovare le interconnessioni tra i due linguaggi, non semplicemente declamando versi classici con sottofondo jazzistico: cosa che non significa nulla. Talvolta avevo addirittura in mente un jazzista ben preciso (che conoscevo bene) con cui lavorare. Ancora riguardo al dialogo creativo c’è un mio testo La scomparsa di Giuseppi Logan che ho più volte adattato a forma via via poetica, teatrale, narrativa. Ma è un’eccezione. Conosco le regole della lirica e quelle della prosa e della drammaturgia che sono assai diverse tra loro. Per quanto riguarda la differenze tra romanzi e racconti è solo una questione di lunghezza, anche se so benissimo che trattare un argomento in tre pagine è diverso che farlo in trecento, proprio a livello strutturale. Quasi sempre comunque i miei romanzi sono tanti racconti uniti da un fil rouge, perché amo le micronarrazioni, le storie concentrate in poche pagine evitando inutili descrittivismi o eccessive attese.
D Hai in programma nuovi progetti letterari? Quali temi o espressioni artistiche vorresti esplorare in futuro?
R Certo, vi sono sempre tanti progetti: ogni anno penso a qualche nuovo libro che poi non scrivo, perché richiamato all’ordine da alcuni editori che poi mi chiedono di lavorare su certi argomenti, verso cui non voglio dire di no, anche come sfida personale; ma parliamo sempre di saggistica musicale. Per scaramanzia non dico nulla sulle prossime pubblicazioni già in corso di lavorazione, ma concludo confessando che amerei molto tradurre in dialetto vercellese Il piccolo principe di Saint-Exupery, lavorare a un grosso volume illustrato – magari curare un’antologia delle migliori foto di jazz – e avere un mio romanzo stampato o ristampato da un editore di peso.