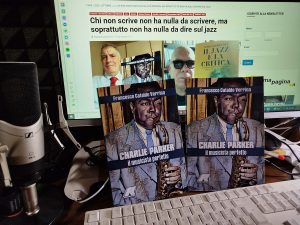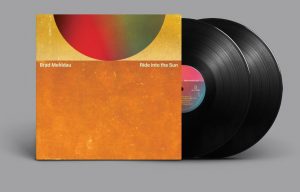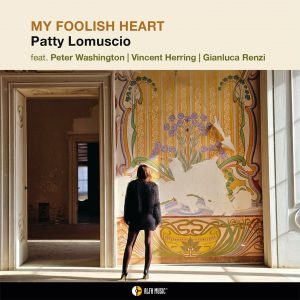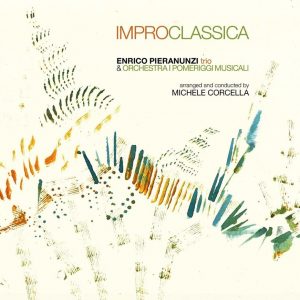CLAUDIO FASOLI INTERVISTATO DA GUIDO MICHELONE

Claudio Fasoli
// di Guido Michelone //
D. Claudio, ci racconti brevemente la tua vita di musicista?
R. Sarebbe molto lungo :in sintesi posso dirti che in famiglia ho ascoltato per anni musica classica che ho introiettato ormai a memoria e che mi ha fatto maturare e capire in “discorso sonoro “ della Musica da Monteverdi e Bach a Debussy e Ravel. Poi verso i 14 anni mi sono allontanato per ascoltare negli anni King Oliver e Jelly Roll Morton , oltre a Louis Armstrong e soprattutto Bix Beiderbecke. Poi rapidamente, intorno ai quindici anni ho affittato il prima saxalto dopo aver ascoltato Charlie Parker e soprattutto Lee Konitz che ho trovato affascinante e mi ha molto condizionato , soprattutto perché a quei tempi non c’erano libri né maestri a Venezia dove abitavo e quindi tutto si basava sugli ascolti. Poi sperimentai il sax soprano quando ormai vivevo a Milano , suggestionato da Coltrane , per poi passare dal sax alto al sax tenore dopo il periodo Perigeo , dato che suonavo l’alto con una concezione tenoristica.
D. Facile o difficile, per te, nel jazz, cominciare dopo i successi ‘rock’ col Perigeo?
R. Non vedo il problema dato che il Perigeo era palesemente un gruppo di Jazz-rock e quasi tutti noi provenivamo dal jazz che ha continuato ad essere il nostro filone di base , per alcuni da lungo tempo , nel caso mio da meno tempo . Ma il Jazz in quel periodo aveva scoperto il fascino degli strumenti elettronici ed era necessario sperimentare quel tipo di timbrica così innovativa e attraente non solo per noi .Moltissimi musicisti di Jazz come noto hanno desiderato capire cosa poteva uscire da quel connubio.
D. Parliamo del tuo strumento, il sax: come e quando l’hai ‘approcciato’? Meglio il tenore o il soprano?
R. Il mio rapporto tenore & soprano è praticamente 52 vs 48% quindi è un rapporto quasi paritetico. Dipende dalla tipologia di brano che pongo in essere e per quale dei due, in fondo, penso che risulti più pregnante per il mio gusto.
D. Quali sono i sassofonisti a cui ti sei ispirato e quali riconosci fondamentali nella storia del jazz?
R. Ovviamente l’elenco è lunghissimo ma cerco di sintetizzare storicamente: come “influenza” possiamo cominciare da Lee Konitz e Jackie Mc Lean , che però rimangono dentro di me con il loro pensiero, poi Coltrane e Shorter , che rimangono dentro e poi , se vuoi, Dave Liebman , Jan Garbarek , Gerd Dudek e Gato Barbieri , ma certo non sarebbe finita qui…più le influenze sono numerose meno se ne dipende e quindi questo è l’invito che faccio agli studenti : ascoltate tutti ! Tieni conto che il discorso dell’ ”influenza” per me , spesso interpretato banalmente, è invece molto complesso : per me è stato fondamentale capire “il pensiero e l’atteggiamento interiore” musicale di questi musicisti più che certi aspetti puramente strumentali o di linguaggio . Infatti fra le mie “influenze” non esito a mettere Bill Evans (pianista) Miles Davis, Herbie Hancock, Charlie Haden, Paul Chambers , Tomasz Stanko, Tony Williams , Elvin Jones, Jean-François Jenny Clark , Kenny Wheeler , Gato Barbieri, Mick Goodrick , Drew Gress , Justin Brown, Palle Danielsson, Tony Oxley, Matt Mitchell, oltre ad altri con i quali ho avuto l’occasione di suonare e registrare. Poi non voglio dimenticare e sottolineare quanto ho potuto capire e acquisire e imparare suonando insieme a tutti i musicisti italiani o europei o americani che ho frequentato nei miei gruppi, assolutamente nessuno escluso.
D. Ma che cos’è per te il jazz?
R. Sotto l’etichetta “jazz” si possano collocare tante musiche, tutte legittime e a volte affascinanti, piacciano o no. Il jazz è un linguaggio molto specifico e credo che le sue tipicità possano facilmente essere identificate: suono, pronuncia, atteggiamento mentale ritmico, estemporaneità, improvvisazione (entro o fuori strutture armoniche), armonia peculiare con suono peculiare (voicing), e potremmo anche continuare. Il jazz è una straordinaria opportunità per chi lo suona e per chi lo ascolta. È una musica unica al mondo. Il jazz ha saputo trasformarsi entrando in contatto con moltissimi generi musicali dalla bossa nova alla musica classica, dalle varie musiche popolari al rock. Il jazz sta soprattutto nel “come” e meno nel “cosa” si suona, anche in questo è la sua identità. Di certo la sua vitalità la troviamo nella possibilità di ibridarsi positivamente con altri ambiti, di farsi attraversare da culture, di assorbire sensibilità, di fondersi con stili, di recepire e di adattarsi, ma anche di anticipare lo spirito del tempo. Ecco, il jazz.
D. Quanto gioca l’improvvisazione nel tuo jazz?
R. Il mio modo di scrivere è partito dalla concezione del jazz degli anni ’60-70 in cui c’è una parte più o meno lunga caratterizzata dall’armonia, dal tempo e dalla melodia del tema; dopodiché al posto del tema iniziale si inventano dei nuovi temi improvvisando cioè è prevedibile una successione di soli! Da qualche tempo sto riflettendo e proponendo maniere diverse per costruire un brano: per esempio se la tradizione ci insegna a eseguire tema, improvvisazione e altro tema per finire, si potrebbe provare invece molto banalmente a destabilizzare un brano e seguire una sequenza che preveda un tema A, una improvvisazione su una struttura di un ipotetico brano C e un finale col brano B. Naturalmente dipende dai brani, non tutti necessariamente funzionano in una sequenza di questo tipo. L’ho fatto con il Gammatrio con Paolo Birro e Rudy Migliardi e con il quintetto con Patrick Muller, Glenn Ferris, Pietro Leveratto e Mauro Beggio. Una sequenza strutturale diversa è sufficiente a creare imprevedibilità e curiosità, può essere molto stimolante per chi ascolta e anche per chi suona ed è anche molto divertente. In realtà è come un gioco! Può anche essere paradossale. Ma ci sono modi infiniti di sviluppo possibile.
D. Che cosa significa per te l’improvvisazione musicale?
R. Qualcuno ha detto che un brano musicale scritto sul pentagramma dovrebbe suonare come una improvvisazione e che una improvvisazione dovrebbe suonare come un brano scritto. Questo principio sembra rispettato quasi sempre ed è cosa acquisita. Una volta Pablo Picasso ha fatto vedere come lui possa procedere o ama procedere quando dipinge improvvisando cioè senza preventiva elaborazione o prova di un soggetto: lo ha fatto su un pannello credo di grossa plastica trasparente in modo che la telecamera seguisse ogni suo gesto da dietro , ogni suo segno. Il pennarello guidato dalla sua mano ha espresso linee di grande forza e identità fin da subito ma poi altre linee si sono intrecciate e accumulate fino a confondere il disegno originale di una colomba, fino quasi ad ammutolirlo tanto che forse neppure era più completamente riconoscibile. quello era comunque il primo vero soggetto, il tema cui Picasso si riferiva nello sviluppo improvvisativo del suo pennarello che lo aveva mantenuto riconoscibile anche nel corso di una totale definitiva personalizzazione. Questo “improvvisazione” è un termine assai inquietante e destabilizzante per molti scettici: forse qualcuno dimentica che dai tempi di Bach, Beethoven e Chopin fino a Debussy e Ravel (e prima e oltre e non solo loro) i grandi compositori sono sempre stati grandi improvvisatori. Si narrano molti aneddoti in proposito e tutti degni di sicura fiducia. Per esempio non dimentichiamo che Chopin ha suonato in pochissimi concerti col pubblico , non più di due o tre decine , mentre invece nelle serate amava suonare molto volentieri per gli amici e amiche in gran numero, improvvisando o stravolgendo nelle sue composizioni le dinamiche e a volta la diteggiatura prevista e già scritta nella partitura e anche se la versione acquisita dall’Editore proponeva diversi consigli in proposito ; in uno dei pochi concerti effettuati in Inghilterra un brano già suonato nelle sequenza di un concerto venne poi risuonato come bis (encore) con un diverso criterio interpretativo : lo dicono suoi allievi che , desiderosi di sicurezze, per questa imprevedibilità avrebbero potuto anche impazzire!! Questo conferma la sacralità della partitura che ci è pervenuta (Alfredo Casella docet) ma non necessariamente rifiuta interpretazioni più personalizzate (Glenn Gould).
D. Più sembra un discorso alquanto complesso, dunque possiamo andare passo dopo passo o gradino per gradino?
R. Questo inizio è per me il primo gradino di un discorso più lungo e parla di “interpretazione” cioè della lettura di una partitura musicale con uno spirito personale ma non troppo , per così dire …Vale anche per gli attori che leggono poesie o testi di grandi poeti o scrittori del passato e del presente(nessuno può dire come Dante avesse amato leggere la Commedia, ogni interpretazione può essere legittima; nessuno potrebbe criticare invece Ungaretti per la lettura rauca e sofferta delle sue stesse liriche essendone lui l’autore). Questo inizio vuole cioè confermare che una pagina scritta può essere personalizzata nella sua lettura verbale o musicale, come è acquisito essere ovvio entro i limiti del buon gusto. Tutt’altra cosa è il gradino successivo cioè l’“improvvisazione”: ascoltiamo musica non-scritta suonata come se lo fosse, vale a dire con criteri lessicali, grammaticali, sintattici e sonori che potrebbero appartenere ad una partitura scritta ma che però non lo è. E questo desta impressione e/o scetticismo. Però, per sostenere il proprio pensiero gli stessi scettici parlano dell’”improvvisazione” improvvisando verbalmente su quel tema (perché nessuno in un dibattito si sogna di rispondere al suo interlocutore leggendo uno scritto, al massimo avrà preso degli appunti….). Tutto questo per dire che tutti noi improvvisiamo verbalmente fin da bimbi quando imitiamo i primi suoni dei genitori fino poi a imparare a parlare abbastanza per spiegare nostre piccole esigenze; successivamente a scuola studiamo la grammatica e la sintassi e i verbi etc. Questo è proprio una bella storia perché ci dice che non è necessaria a quella età la grammatica o la sintassi per spiegarsi e per dire ad esempio che si ha fame oppure che la pipì preme… È ovvio poi che lo studio e la lettura consentano di perfezionare tutti gli elementi necessari per raggiungere la correttezza nel parlare, per essere capiti meglio, per avere un lessico ampio e adeguato a varie situazioni colloquiali ed emozionali.
D. In maniera del tutto parallela tutto quello che hai appena descritto può avvenire anche nella Musica?
R. Certo, un giovane appassionato che desidera suonare Jazz sceglie uno strumento in base alle emozioni ricevute ascoltando album o concerti. Sceglie uno strumento per apprendere come suonarlo ma spesso non si rende conto che ciò che deve apprendere è soprattutto un linguaggio perché infatti il Jazz è un linguaggio musicale così come lo è il Barocco, il Romantico, il Contemporaneo, etc. ciascuno riconoscibile per alcuni caratteri specifici che ciascun ascoltatore si aspetta di riconoscere quando ascolta Telemann nel primo caso Schumann nel secondo Stockhausen nel terzo etc. Quindi per apprendere il Jazz (che è tante cose diverse) l’ascolto è importante quanto lo studio strumentale così come succede per l’apprendimento delle lingue straniere : non bastano cioè i libri per imparare il Jazz (come con le lingue straniere), il 50-60% dell’apprendimento è legato all’ascolto che consente di coglierne le peculiarità sonore come inflessioni, accenti , pronunce , ritmi, intonazioni delle frasi , suoni specifici, etc, come avviene nel linguaggio parlato . Riflettiamo su suoni diversi per lettere uguali, per esempio pensiamo quanto è diverso il suono della lettera R in francese, spagnolo, inglese, italiano, etc; pensiamo a quanto può essere suono diverso il simbolo della nota Do nelle diverse interpretazioni e/o improvvisazioni nei vari linguaggi musicali. Con questo linguaggio Jazz sarà possibile improvvisare usandone tutte le peculiarità che lo contraddistinguono e che ho nominato… in questo modo si arriva a capire (e accettare) che si può improvvisare con le caratteristiche lessicali tipiche del linguaggio chiamato convenzionalmente “Jazz”. Chi inizia a improvvisare sarà come un bimbo che inizia a parlare balbettando. Il tempo e lo studio e l’ascolto forgeranno poi i musicisti che di questo linguaggio si serviranno per comunicare emozioni a chi li ascolterà. Ci vorrà anche una decina d’anni ma funzionerà.
D. A cosa pensi infine quando suoni o improvvisi?
R. Ascolto il mio suono e propongo un pensiero nel quale riconoscermi , sostanzialmente deve emozionarmi
D. Ritieni che il jazz si debba occupare di politica o della realtà sociale?
R. Scrive Derek Bailey: «In fin dei conti l’improvvisazione, per chi suona e per chi ascolta, è una trasformazione del mondo e di noi stessi. È un esercizio che crea un nuovo universo acustico la cui creazione rappresenta una nuova visione dell’organizzazione estetica, etica e politica delle nostre vite». È una considerazione vera perché la musica improvvisata per sua natura è ostile alla ripetizione inopportuna e inadeguata e quindi alla conservazione. In questo è un forte atto politico di messa in discussione della situazione pianificata e prevedibile. Il discorso del jazz – senza necessariamente essere free – ha una forte chance politica. In fondo la cultura in sé è un atto rivoluzionario come tutto ciò che stimola l’immaginazione che puoi chiamare creatività. Fin dalla gioventù sono stato amico di Luciano Ferrari Bravo, un fine teorico della politica, che insegnò all’università di Padova. Avevamo delle idealità comuni, ma lui si impegnava politicamente, mentre io non capivo come si potesse trasformare l’esistente, avevo una visione più scettica e mi sembrava che solo attraverso la musica potessi dare un contributo, non come uso politico della musica, ma con la creatività, che si può vedere come il contrario di conservazione. Questo l’ho capito molto tempo dopo.