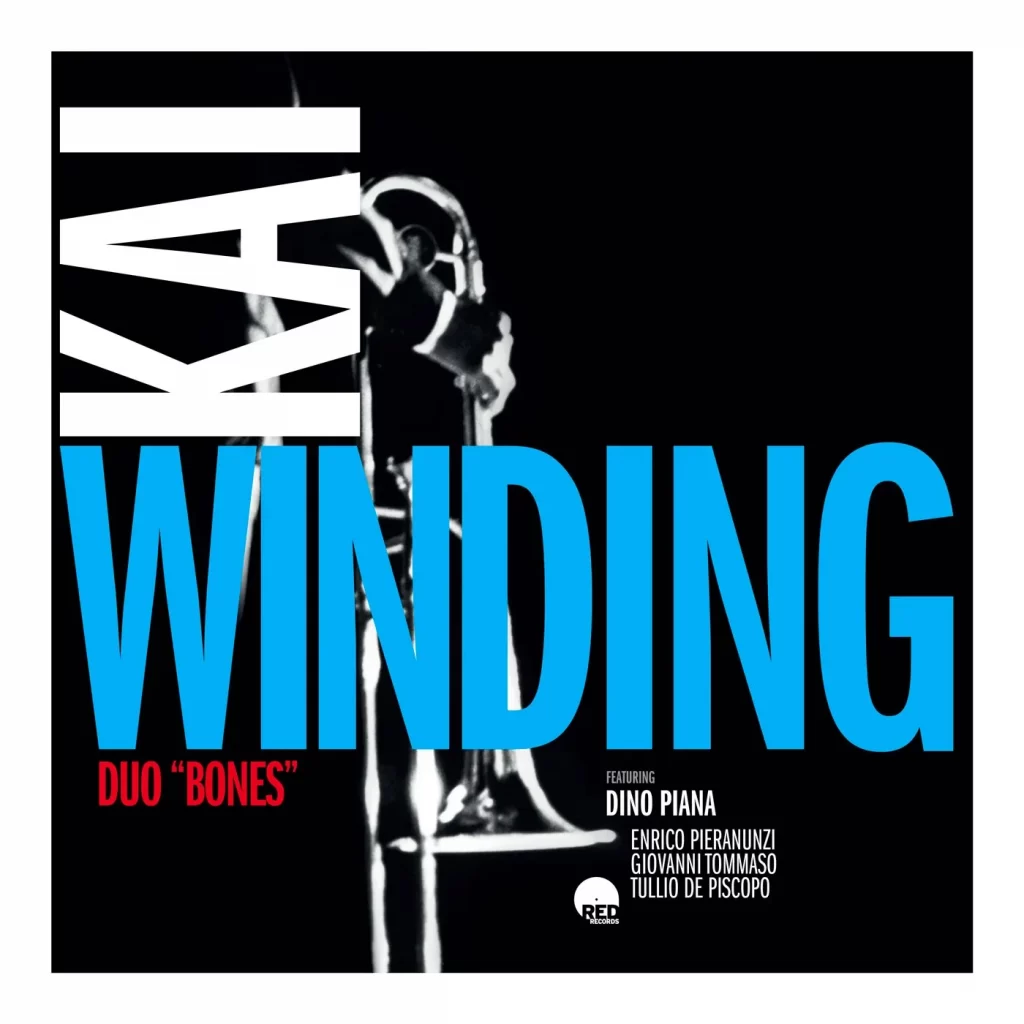Kai Winding Feat. Dino Piana con «Duo Bones»: la dialettica del trombone fra tradizione americana e invenzione europea (Red Records. Ristampa 2025)
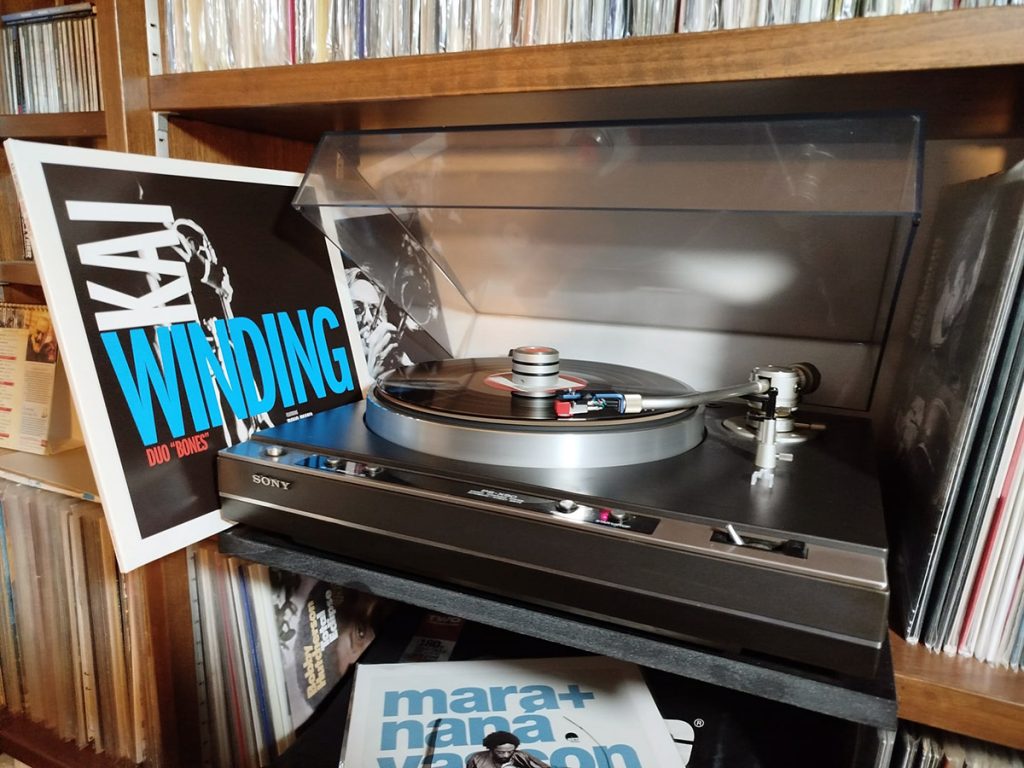
Winding dimostra la sua versatilità legata al jazz statunitense, ma al contempo il saper adattarsi al contesto italiano, dove la sensibilità inventiva di Piana e la scrittura polifonica di Pieranunzi prefigurano inedite prospettive.
// di Francesco Cataldo Verrina //
La coppia Winding–Johnson, nel disco Impulse! del 1961, aveva già dimostrato come il trombone potesse emanciparsi dal ruolo di strumento di sezione per assumere una funzione solistica di pari dignità. La loro dialettica si fondava su un linguaggio bop e hard bop, con progressioni armoniche serrate e un fraseggio che alternava linearità ed improvvisazione. La presenza di Bill Evans, Paul Chambers e Roy Haynes garantiva un contesto ritmico e armonico di altissimo livello, capace di amplificare la precisione tecnica di Johnson e la sensibilità inventiva di Winding. Quando Winding incontra Piana a Roma, quasi vent’anni dopo, la formula del doppio trombone non viene semplicemente riproposta, bensì traslata in un nuovo ambiente culturale.
La sessione di «Duo Bones», registrata a Roma nel novembre del 1978, rappresenta un documento sonoro di rara coerenza progettuale. L’incontro tra Kai Winding, trombonista di origine danese e figura centrale del jazz statunitense, e Dino Piana, trombonista a pistoni di solida formazione orchestrale, si colloca nel solco di una tradizione che – come detto – aveva già visto Winding affiancare J.J. Johnson in una delle più affiatate coppie strumentali della storia del jazz. La ripresa di quella formula, tradotta nel contesto europeo ed arricchita da una sezione ritmica di assoluto rilievo, assume il valore di un laboratorio musicale, in cui la dialettica tra due strumenti affini si dipana con rigore ed immaginazione. La scelta di Alberto Alberti di convocare Enrico Pieranunzi, Giovanni Tommaso e Tullio De Piscopo non rispondeva soltanto a criteri di opportunità, ma nasceva dalla volontà di costruire un tessuto armonico e ritmico capace di sostenere ed amplificare le linee dei tromboni. Pieranunzi, già allora pianista tecnicamente raffinato e interiormente articolato, offrì un contrappunto pianistico che si stagliava tra progressioni modali e aperture liriche; Tommaso, tornato al jazz dopo l’esperienza con il Perigeo, impresse al contrabbasso un profilo acustico elastico ed incisivo; De Piscopo, funambolico ed assertivo, innervò la trama con una pulsazione che oltrepassava il mero sostegno, diventando motore propulsivo dell’intero set.
Piana, con il valve trombone, introdusse una fisionomia del suono differente, più incisiva e metallica, che s’innestava con la voce lirica di Winding. Pieranunzi, Tommaso e De Piscopo non replicarono la sezione ritmica americana, ma la reinventarono secondo una logica italiana: il pianista lavorò su accordi quartali e progressioni modali, il contrabbasso apportò un profilo acustico elastico, mentre la batteria inserì alcuni contrafforti mediterranei pulsazioni mediterranee. Il repertorio, calibrato tra originali e tre standard rivelò una precisa intenzione: non affidarsi alla consuetudine del songbook americano, ma perlustrare inediti territori armonici, secondo una ratio più marcatamente polifonica. La registrazione, curata da Francesco Melloni e Giovanni Fornari, restituisce con chiarezza la disposizione spaziale degli strumenti: i tromboni emergono con un’aura fonica nitida, mai sovrapposta, mentre il piano, il contrabbasso e la batteria si collocano in un equilibrio che richiama la precisione di certe incisioni americane coeve. La rimasterizzazione di Rinaldo Donati, realizzata a Milano, ha ulteriormente valorizzato la fisionomia del suono, rendendo l’ascolto attuale e privo di patine nostalgiche.
In virtù di tali scelte, «Duo Bones», rieditato dalla Red Records di Marco Pennisi, non si limita a documentare un incontro fortuito, ma sancisce una pagina musicale di rilievo, in grado di coniugare tradizione ed innovazione. La dialettica tra Winding e Piana non procede per contrasti, ma per corrispondenze: due voci affini che si muovono nel tessuto di un quartetto ampliato, trovando nel respiro collettivo la propria forza espressiva. Il primo solco, «Duo Bones» (K. Winding), si fonda su un dialogo serrato fra i due tromboni, impostato su progressioni armoniche diatoniche che si dilatano in modulazioni cromatiche. La partitura di Winding privilegia la sovrapposizione di linee parallele, con un uso calibrato delle quinte e delle terze che evocano la logica contrappuntistica. La sezione ritmica, mediante il pianoforte di Pieranunzi, introduce cluster discreti e progressioni discendenti che amplificano la fisionomia del suono dei fiati. «Get Out Of Town», standard a firma di Porter, viene affrontato con un approccio che evita la mera riproposizione. I tromboni si muovono nell’ordito di una struttura accordale che alterna modulazioni minori e dominanti secondarie, mentre Pieranunzi inserisce voicings aperti che richiamano la tradizione bop. Tommaso e De Piscopo sostengono con un profilo acustico elastico, trasformando l’intreccio tematico in un gioco di interplay collettivo. In «Lady H», Winding adotta un modulo più lirico, con frasi che si distendono su progressioni di nona e undicesima. La trama espressiva dei tromboni si colora di sfumature eleganti, mentre il pianoforte lavora su arpeggi spezzati che suggeriscono un respiro cameristico. La batteria, con fantasiosi tocchi sui piatti, accentua la dimensione timbrica senza mai sovrastare. «Kai And Dino» di Dino Piana si distingue per la sua inventiva: il valve trombone introduce un tema incisivo, costruito su intervalli di quarta e quinta, che si avvita la linea di Winding. La sezione ritmica, in virtù di un andamento quasi ostinato, conferisce al costrutto un carattere rituale. Pieranunzi, con accordi quartali, amplifica la tensione armonica, mentre De Piscopo intarsia il substrato con accenti sincopati.
Il lato B si apre con «On Green Dolphin Street» (B. Kaper) – già reso celebre da Miles Davis e Bill Evans – che viene reinterpretato con un approccio che propende verso la fluidità. I tromboni si spostano nel respiro di variazioni modali, mentre Pieranunzi lavora su progressioni diatoniche arricchite da velature dai colori vivaci. Tommaso genera con il contrabbasso una walking dinamico, quasi cantabile, mentre De Piscopo marca il territorio con un movimento ritmico che richiama la tradizione afro-cubana. La partitura di Winding in «Stop Following Me» si fa più ironica e creativa: il tema procede per frasi spezzate, con intervalli dissonanti che generano un profilo acustico spigoloso. Pieranunzi interviene con accordi a grappoli e progressioni ascendenti, mentre la batteria lavora su metriche irregolari, conferendo al portato tematico un carattere quasi sperimentale. La classica ballata di G. Jenkins, «This Is All I Ask», viene affrontata con sensibilità ricettiva: i tromboni si diramano su un impianto armonico che privilegia le sovrapposizioni di terze e seste. Pieranunzi, con un tocco immaginativo, rilascia arpeggi delicati che amplificano l’aura fonica complessiva. Tommaso e De Piscopo sostengono con discrezione, lasciando emergere la dimensione lirica del dialogo tra i fiati. «Soul Dance» di Pieranunzi chiude l’album con un episodio sonoro di estrema coerenza. La struttura tematica si regge su progressioni modali che richiamano la logica del jazz europeo, con aperture verso la polifonia contemporanea. I tromboni si muovono nell’alveo di un tema che alterna frasi sincopate e linee liriche, mentre la sezione ritmica lavora su un groove elastico. Pieranunzi, autore e interprete, dimostra l’attitudine a coniugare scrittura e improvvisazione, facendo leva su un linguaggio armonico che si colloca nel riflesso delle avanguardie pianistiche del secondo Novecento.
Andando indietro nel tempo, si può affermare senza tema di smentita che «The Great Kai & J.J.» alternava evergreen e componimenti autorali, collocandosi nel solco della tradizione bop, mentre «Duo Bones» riduce gli standard, privilegiando composizioni originali. In questo modo, la sessione romana prestava il fianco ad una regola d’ingaggio più autonoma e moderna, dove la tempra di Winding si confrontava con quella di Piana e Pieranunzi. Il raffronto tra i due dischi non si riduce dunque ad una similitudine di formule, ma fa emergere una continuità trasformata: nel primo caso, il trombone si afferma come voce solistica in seno al vernacolo americana; nel secondo, la stesso strumento s’inserisce nel modulo idiomatico europeo, tentando nuove strade da battere. Winding dimostra così la sua versatilità legata al jazz statunitense, ma al contempo il saper adattarsi al contesto italiano, dove la sensibilità adattiva di Piana e la scrittura polifonica di Pieranunzi prefigurano inedite prospettive.