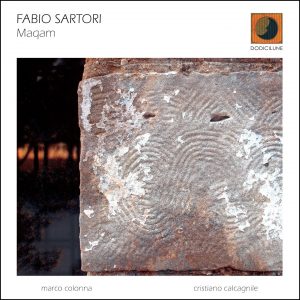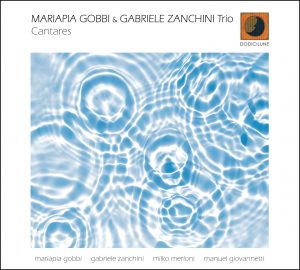Bobby Hutcherson con «Total Eclipse», nel solco di un’intesa: analisi di una sintassi collettiva (Blue Note, 1969)

Una delle formazioni più raffinate e sottovalutate del decennio, sebbene, già in questo album, ogni elemento figurava al suo posto: la consapevolezza formale, la sensibilità armonica e l’attitudine a far dialogare tradizione ed avanguardia senza opposizioni né compromessi.
// di Francesco Cataldo Verrina //
La genesi di «Total Eclipse» coincide con l’avvio di una delle collaborazioni più feconde e meno celebrate del jazz statunitense: quella tra Bobby Hutcherson e Harold Land. Il loro primo incontro discografico, «The Peace-Maker» (Cadet, 1968), non generò clamore, ma pose le basi per una dialettica musicale che, nel corso di sette album Blue Note, avrebbe definito un linguaggio condiviso, finalizzato a coniugare lirismo e ricerca formale. «Total Eclipse», registrato il 12 luglio 1968 presso lo studio Van Gelder, tratteggia il primo capitolo di questa intesa, evidenziandone immediatamente la portata.
La compagine, completata da un’eccellente sezione ritmica: Chick Corea al pianoforte, Reggie Johnson al contrabbasso e Joe Chambers alla batteria, si prodiga attivamente alla costruzione di un tessuto musicale che si espande ben oltre i confini dell’hard bop. Corea, reduce dal suo acclamato lavoro da band-leader, «Now He Sings, Now He Sobs», porta con sé una grammatica pianistica angolare, ma in grado di modulazioni liriche ed aperture armoniche che si integrano perfettamente con la trama espressiva di Hutcherson. La scelta di Corea, pur non abituale nella formazione del quintetto (che avrebbe poi adottato Stanley Cowell come pianista stabile), si rivela strategica: la sua presenza imprime una curvatura ritmica ed accordale che innerva l’intero album. La struttura del disco, articolata in cinque episodi sonori, evidenzia la centralità compositiva di Hutcherson, autore di quattro episodi su cinque. «Matrix», firmato da Corea, agisce come punto di fuga ritmico e formale, accelerando la dinamica dell’ensemble ed alimentando uno spazio improvvisativo più serrato. Il componimento di Corea si distingue per l’energia propulsiva, che non interrompe, comunque, la coerenza interna ed estetica del disco, ma piuttosto ne amplia il raggio espressivo. All’interno di «Total Eclipse», Bobby Hutcherson non si attarda a delineare una grammatica vibrafonistica, ma la dilata e la innerva di una sensibilità armonica che trascende il mero tecnicismo autoreferenziale. La sua presenza non risulta mai esibita, bensì dispensata secondo una logica di sottrazione, con un gioco reiterato di tensione e rilascio, dove ogni intervento si dirama come snodo timbrico e narrativo.
In «Herzog», solco d’apertura, l’interazione tra il band-leader, Harold Land al tenore e Chick Corea al pianoforte genera una tessitura acustica multistrato, nella quale ogni dettaglio si deposita con precisione quasi calligrafica. Il suono di Hutcherson fiorisce nel tracciato, dispensando idee progressive che vengono a galla gradualmente. La sua entrata, successiva a quella di Corea, non mira al centro della scena, ma lo costruisce per sottrazione. Il profilo fonico che ne deriva appare sommesso, interiormente variegato, intersecandosi in un’atmosfera avvolgente, al punto che il vibrafono sembra insinuarsi, come una vena d’acqua sotterranea che prolunga la sete armonico della composizione. Harold Land, nel suo assolo, introduce una curvatura più archetipica, ma di certo non prevedibile, in cui qualunque nota risulta sinuosa ed amplificata da un riverbero discreto e ponderato, che il mix diventa percepibile semplicemente tramite un ascolto accorto. L’arazzo sonoro che ne scaturisce non appare mai ornamentale, bensì strutturale, dove ciascun elemento contribuisce al sostegno di un ambientazione in cui la densità espressiva non viene mai ostentata, ma pressoché suggerita. La dialettica tra forma e libertà, tra partitura ed intuizione, perfora l’intero album, trovando nella title-track, «Total Eclipse», una sintesi particolarmente eloquente. L’apertura lenta, emotivamente trattenuta, si espande in una progressione che oltrepassa il concetto di climax virtuosistico, per contro la trasformazione della materia sonora attira l’interesse del line-up. Hutcherson evita di rimuginare, puntellando con precisione; Land apporta qualche deviazione, sebbene il sassofono tenore conservi la fisionomia del suono precedente, pur traslandola in una diversa ratio esecutiva, mentre Corea, dal canto suo, plasma un perfetta sagoma armonica, in cui ogni intento musicale risulta motivato e qualsiasi variazione diventa necessaria. L’affinità di gruppo non contempla un dato estetico, piuttosto mira ad una costruzione critica, evitando il tipico abecedario dell’hard-bop. La riflessione timbrica si fa più esplicita, ciascuno strumento si adatta alla nuova curvatura estetica, mentre la manovra risulta tanto istintiva quanto consapevole, promulgando il dominio di un idioma jazzistico scevro da qualunque citazionismo. Hutcherson, in tal senso, incarna un esempio paradigmatico di adattabilità musicale: la sua traiettoria negli anni ’60, da «Out to Lunch» di Eric Dolphy a «Idle Moments» di Grant Green, mostra una versatilità che evita sistematicamente la dispersione, divenendo coerenza mobile.
In «Matrix», la sezione iniziale risulta espletata secondo una tecnica di attesa e rilascio. Hutcherson si mantiene in disparte, lasciando che Corea e Land tessano un contrappunto di idee che si rincorrono e si accatastano con naturalezza. L’atmosfera che ne deriva è ricca di frizioni e di aperture. L’improvvisazione, oltre ad essere una prassi codificata, si attesta come cuore pulsante del costrutto. Al minuto 4:17, Hutcherson tenta una breve ascesa, perfettamente calibrata, la quale funge da punto di ancoraggio emotivo, traducendosi in una sorta di vibrazione incarnata e di linguaggio corporeo. L’assolo si srotola con una fluidità che sfugge alla prevedibilità, imponendosi come centro gravitazionale dell’intera composizione. «Same Shame», con un’alternanza tra malinconia ed animazione, sancisce la capacità dell’ensemble di modulare le frizioni interne senza mai ricorrere a formule precompilate, decretando un episodio sonoro di particolare rilievo. La progressione percussiva, che s’intensifica verso il culmine, tutt’altro che meccanica, è il frutto di una presa graduale e di un accumulo che si avverte nel tessuto ritmico e nella trama espressiva. L’intreccio motivico guarda oltre il jazz codificato, conformandosi nel solco di una ricerca che, nel 1969, individuava inedite vie di demarcazione nelle dinamiche progressive post-coltraniane. Il pianoforte, in particolare, usa un linguaggio sensuale – nondimeno sostentativo – garantendo il supporto armonico ad un Land intenzionato ad esaltare la melodia centrale con un’ascesi priva retorica. Il passaggio conclusivo, in cui tutto si riunisce, diventa una sintesi ed una dimostrazione di eccellenza che mette in luce un line-up consapevole e musicalmente eloquente.
«Pompeian», composizione conclusiva, rappresenta il vertice poetico dell’album. Il tema iniziale, giocoso e quasi infantile, non indulge nella leggerezza. Si tratta piuttosto di una strategia di apertura che prepara una modulazione verso una forma libera e spirituale, quasi celestiale. Harold Land, al flauto, abbandona la fisionomia del tenore per adottare una voce più rarefatta, mentre Hutcherson, mediante l’uso di marimbe e campane, pennella colori scuri che non appesantiscono, ma approfondiscono. La sezione centrale, sagomata alla stregua di una forma aperta, scandaglia e rilancia. Il ritorno al tema, sul finale, si adagia su equilibrio instabile, lasciando che la meraviglia non si risolva del tutto, ma che permanga come un’eco nella mente del fruitore. A conti fatti, «Total Eclipse» non sancisce soltanto il primo vagito del quintetto a nome Hutcherson, ma si profila, quale manifesto di una poetica condivisa, che negli anni ’70 avrebbe trovato ulteriori sviluppi, pur restando ai margini della canonizzazione. Il gruppo, con Stanley Cowell al pianoforte, avrebbe continuato ad operare come una delle formazioni più raffinate e sottovalutate del decennio, sebbene, già in questo album, ogni elemento figurava al suo posto: la consapevolezza formale, la sensibilità armonica e l’attitudine a far dialogare tradizione ed avanguardia senza opposizioni né compromessi.