«Convergence» di Max Trabucco feat. F. Michisanti, M. Caliumi, F. Pierantoni: trame sonore senza gerarchia armonica (Abeat For Jazz, 2025)
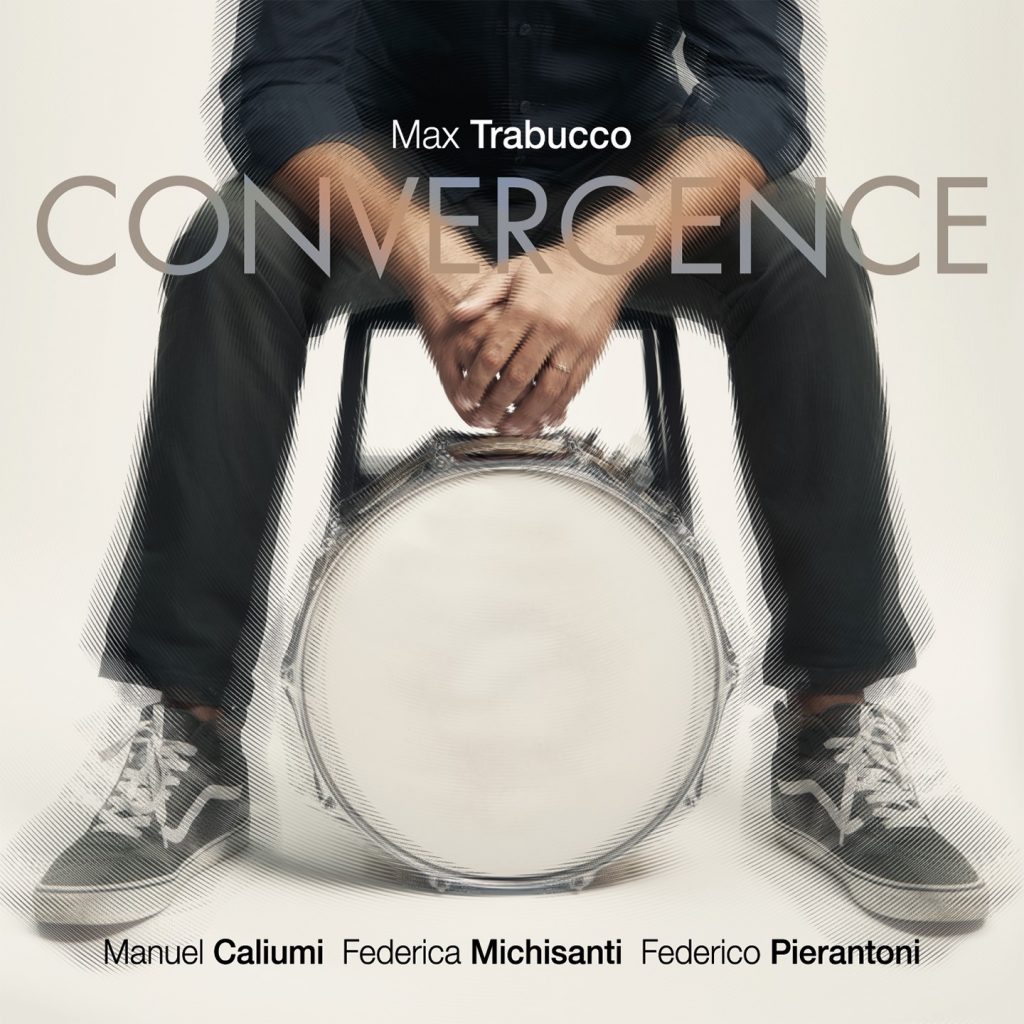
«Convergence» sancisce l’idea un progetto che si distribuisce progressivamente con misura, lavorando su equilibri instabili, propedeutici all’emersione di una grammatica del suono fondata sulla coesistenza. Nessuna enfasi, nessuna celebrazione, ma solo un modo diverso di pensare la forma, senza cornice armonica, ma con una logica evolutiva che si dipana in progressione.
// di Francesco Cataldo Verrina //
La scelta di un ensemble composto esclusivamente da strumenti monodici – batteria, contrabbasso, sax alto e trombone – non costituisce una semplice deminutio, ma innesca una sorta di apertura multidirezionale. In assenza di un riferimento accordale, la procedura armonica viene lasciata libera di emergere. Questo svincolo genera ambienti sonori che non si appoggiano su progressioni codificate, ma si costruiscono nel fluire delle voci, secondo logiche di convergenza e divergenza. Nella storia della musica occidentale, la tensione tra principio monodico e principio polifonico ha generato situazioni ibride, spesso sperimentali. La monodia, intesa come singola linea melodica, ha trovato nel Novecento nuovi spazi espressivi, soprattutto quando affrancata da un accompagnamento armonico tradizionale. Le esperienze della Camerata Fiorentina, le ricerche di Caccini e Monteverdi, fino alle dissolvenze timbriche di Scelsi o alle geometrie ritmiche di Feldman, mostrano come l’assenza di un centro armonico possa generare ambienti sospesi, mobili ed aperti alla percezione.
In «Convergence», tale metodo si manifesta come principio compositivo. Le voci strumentali non si subordinano, non si fondono, non si oppongono, ma coesistono. La risultante conduce ad una molteplicità di direzioni possibili, dove ogni traccia costituisce un campo di forze, non solo una linea narrativa, in cui l’ armonia non viene negata a priori, ma rimandata. E in questo rimando, il quartetto trova una propria fisionomia, una specifica grammatica ed una peculiare dimensione del pensiero. Su tali presupposti, nella compagine guidata da Max Trabucco, la scelta di rinunciare ad uno strumento armonico si schiude a possibilità molteplici. Il suono si dirama in virtù di una trama di apporti monodici non gerarchizzati che tendono alla convivenza. Il titolo «Convergence» infatti descrive un processo, nel quale le linee si avvicinano, si sovrappongono e si distanziano ciclicamente. La batteria di Trabucco indica le traiettorie evitando l’autoritarismo leaderistico; la Michisanti al contrabbasso lavora per sottrazione, lasciando affiorare profili acustici che rimandano ad certa scultura sonora novecentesca, dove il vuoto è parte integrante del disegno. Caliumi e Pierantoni, al sax alto ed al trombone, agiscono in uno spazio condiviso, intervenendo con misura senza tentare di surclassarsi a vicenda.
L’opener, «The Key» adduce una pulsazione che richiama le geometrie ritmiche di Morton Feldman, ma senza indulgere alla rarefazione. «Convergence» espone il principio del progetto, ossia punti d’incontro melodici che si dispiegano senza centro, in un habitat dove il suono è presenza. L’Apertura risulta sobria, quasi introduttiva, mentre la batteria di Trabucco decreta un substrato ritmico rarefatto, dal canto suo, il contrabbasso punta sul detrimento selettivo, mentre fiati si dispongono secondo una logica di stratificazione timbrica in cui la melodia emerge per affioramento. Nella title-track, «Convergence», per paradosso, gli strumenti si spostano in direzioni divergenti, poi si avvicinano, si annodano, quindi si diradano . Il quartetto opera senza un vincolo accordale, ma con una coerenza inquieta che rimanda alla logica delle installazioni di John Cage, dove il suono è presenza, quando non immaginazione. «Looking For Something» si sostanzia come un frammento breve, ma non interlocutorio. Il titolo suggerisce una ricerca, ma la musica non cerca: espone. La scrittura si muove in equilibrio instabile, con una pulsazione che potrebbe evocare certi passaggi di Luciano Berio, dove il gesto è già forma. «Serendipity» propone la casualità e l’improvvisazione come metodo, mentre i quattro sodali si dispongono secondo una ratio di sovrapposizione non gerarchica, dove ogni strumento interviene come presenza autonoma. Il risultato è una tessitura che ricorda le geometrie visive di Paul Klee, dove ogni pennellata risulta autonoma, ma parte di un disegno.
In «Quiet», la batteria lavora su dinamiche minime, il contrabbasso disegna profili acustici che si dissolvono, mentre i fiati tratteggiano una melodia che non si espone mai del tutto. In «Evidology», il neologismo suggerisce una logica di emersione, per contro la partitura si dipana in seno ad una polifonia implicita, dove le voci si attestano secondo una geometria mobile, dove il quartetto lavora come sistema, non come somma di parti. «Prayer For Peace», raffigura una preghiera, ma non un’invocazione, in cui il ritmo si fa più disteso, la melodia più esplicita, ma senza cedere alla linearità. L’intreccio motivico potrebbe evocare certe pagine di Arvo Pärt, dove la semplicità appare frutto di una logica compositiva rigorosa. «Humans Can’t» episodio breve, quasi aforistico, il cui presagisce una negazione, ma il costrutto non vi fa ricorso. Sunna scorata di una gestualità minima, il quartetto lavora su micro-intervalli, su accenni e su dissolvenze, quasi una camera di decompressione ed una pagina di studio. «Ascendant» di Elvin Jones è l’ unico componimento non firmato da Trabucco, ma non per questo estraneo al progetto. La rilettura oltrepassa il banale tributarismo, propendendo per uno scandaglio del modulo archetipale dell’epico batterista, del quale il line-up punta a far emergere un elaborato contemporaneo che si rifà , evidentemente, alla sua grammatica percussiva, rileggendola, però, sulla scorta di una sintassi più rarefatta e sospesa. A conti fatti, «Convergence» sancisce l’idea un progetto che si distribuisce progressivamente con misura, lavorando su equilibri instabili, propedeutici all’emersione di una grammatica del suono fondata sulla coesistenza. Nessuna enfasi, nessuna celebrazione, ma solo un modo diverso di pensare la forma, senza cornice armonica, ma con una logica evolutiva che si dipana in progressione.






