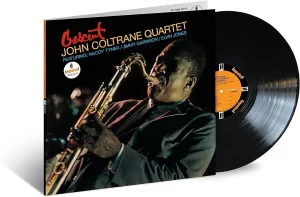Val Jeanty: Rituali elettronici, dove la possessione medianica incontra l’elaborazione algoritmica

Val Jeanty
Una delle prime figure ad articolare una forma di Afro-Electronica o Vodou-Electro, in cui l’eredità del tamburo cerimoniale haitiano si ibrida con il linguaggio delle macchine, generando uno spazio sonoro decoloniale, al tempo stesso arcaico e postumano. Il tamburo cerimoniale si fa controller, la pulsazione rituale si traduce in sintassi glitch, la possessione medianica incontra l’elaborazione algoritmica.
// di Francesco Cataldo Verrina //
La parabola artistica di Val Jeanty – nota anche con lo pseudonimo di Val-Inc – si dipana con peculiare autorevolezza nel contesto delle avanguardie sonore diasporiche, incarnando un’inedita intersezione tra il retaggio spirituale haitiano, le estetiche afrofuturiste e le possibilità illimitate della sperimentazione elettronica. Il suo operato, lungi dall’essere mero sincretismo, si delinea come un dispositivo epistemologico in cui il pensiero vodou si trasmuta in linguaggio acustico, rendendo udibile ciò che altrimenti resterebbe celato nelle pieghe dell’invisibile. «La cultura vodou è sempre stata la mia fonte d’ispirazione», afferma l’artista, «poiché introduce composizioni astratte che racchiudono nuove modalità di pensare e creare. Ogni ritmo produce una risonanza singolare, e tutte queste sonorità si sono influenzate reciprocamente, fondendosi in un oceano vibrazionale di eredità ancestrale haitiana».
Val Jeanty nasce a Port-au-Prince, capitale di Haiti, in una famiglia strettamente legata alle pratiche religiose e musicali del vodou, universo simbolico e rituale che segnerà in modo indelebile la sua formazione artistica e spirituale. Cresce in un ambiente dove il suono non è intrattenimento, ma linguaggio sacro, medium fra mondi visibili ed invisibili, strumento di trasmissione ancestrale. Negli anni Novanta si trasferisce negli Stati Uniti, stabilendosi a New York, dove intraprende un percorso di studio e sperimentazione che la porterà a coniugare le proprie radici haitiane con le pratiche emergenti della musica elettronica, del turntablism e della performance multimediale. Nel corso del tempo sviluppa una pratica artistica autonoma, al di fuori delle logiche dell’industria musicale, incentrata su una poetica che fonde spiritualità creola, tecnologia digitale e improvvisazione radicale. Divenebdo una delle prime figure ad articolare una forma di Afro-Electronica o Vodou-Electro, in cui l’eredità del tamburo cerimoniale haitiano si ibrida con il linguaggio delle macchine, generando uno spazio sonoro decoloniale, al tempo stesso arcaico e postumano. Il tamburo cerimoniale si fa controller, la pulsazione rituale si traduce in sintassi glitch, la possessione medianica incontra l’elaborazione algoritmica. Attualmente docente al Berklee College of Music, Jeanty continua ad operare in una zona di confine tra arte sonora, installazione, performance e attivismo epistemologico, proponendo una visione del suono come veicolo di conoscenza e resistenza. La sua figura incarna, in maniera radicale e poetica, la possibilità di un’estetica nera contemporanea capace di connettere le rovine della storia coloniale con le promesse del futuro.
Le sue performance, che hanno attraversato luoghi consacrati alla riflessione estetica come il Whitney Museum, il MOMA, la Biennale di Venezia e la Haus Der Kulturen Der Welt di Berlino, non si presentano come semplici esibizioni, ma come invocazioni sonore capaci di disarticolare i dispositivi percettivi dell’ascoltatore. Non si tratta, dunque, di riproporre tradizioni folkloriche in chiave contemporanea, bensì di produrre una temporalità altra, un «kairos» acustico nel quale la dimensione ancestrale si riattualizza sotto forma di vibrazione futuribile. Numerosi sono stati i riconoscimenti che hanno attestato la singolarità del suo percorso creativo: dalla Van Lier Fellowship nel 2017, al NYSCA/Roulette Residency Fellowship del 2019, fino al Toulmin Fellowship conferitole nel 2022 dal Center For Ballet And The Arts della New York University. Tali premi non sanciscono soltanto un valore artistico, ma riconoscono il carattere profondamente politico del suo operato, che smonta pezzo per pezzo i paradigmi eurocentrici della musicologia e restituisce dignità auratica alle tradizioni nere e creole. L’universo sonoro di Val Jeanty non si lascia racchiudere in categorie consuete, esso eccede l’idea stessa di genere, sia in senso sonoro che identitario. Il suo gesto compositivo, simultaneamente arcaico e futurista, intuitivo e programmatico, interroga le soglie della materia sonora, facendo dell’onda un vettore di memoria, di lotta e di trascendenza. Nell’ascolto delle sue creazioni non si dà soltanto fruizione estetica, ma una vera e propria esperienza liminale, che chiama in causa l’ascoltatore come testimone partecipe di un rito sonoro che vibra al crocevia tra storia, tecnologia e spiritualità.
L’operato di Val Jeanty si inscrive in una costellazione estetica che trova corrispondenze decisive nelle avanguardie afro-americane del Novecento, da Sun Ra a Milford Graves, da Pauline Oliveros a George Lewis, proiettandosi come prosecuzione e rifrazione contemporanea di quelle genealogie radicali che hanno rifiutato la dicotomia tra arte e militanza, tra ricerca sonora e riscatto epistemologico. La sua arte si nutre della stessa urgenza metamorfica che animava il cosmic jazz di Sun Ra, per il quale la musica costituiva un veicolo di trasmigrazione identitaria, un mezzo per disancorarsi dalle prigioni ontologiche imposte dalla modernità bianca. Come il compositore di Birmingham, anche Jeanty fa del suono un vettore cosmologico, capace di modulare mondi e temporalità eterogenee, di evocare genealogie sommerse e di rendere udibile ciò che la storiografia ufficiale ha silenziato. L’influsso delle poetiche afrofuturiste si rivela non tanto in una citazione esplicita, quanto nell’adozione di un linguaggio simbolico che destruttura l’idea lineare di progresso e tecnologia. Jeanty, come il batterista-scienziato Milford Graves, considera il ritmo non soltanto nella sua funzione strutturale, ma come manifestazione di un’intelligenza organica, vibrazione del corpo e del cosmo, codice somatico e ancestrale che precede e trascende la notazione occidentale. Laddove Graves interrogava i battiti cardiaci come partiture biologiche, Jeanty decifra i pattern della percussione vodou come algoritmi spirituali, traducendoli in linguaggio elettronico senza mai privarli della loro carica rituale. Il suo avvicinamento all’improvvisazione radicale e alla composizione aleatoria presenta affinità elettive anche con la pratica di Pauline Oliveros, in particolare per quanto concerne la nozione di deep listening. In Jeanty, tuttavia, questa attenzione all’ascolto si espande in una modalità «transepistemica», dove la risonanza non si limita a coinvolgere la percezione uditiva, ma attraversa il corpo e la memoria collettiva, innescando un’esperienza sensoriale e politica che mette in crisi le coordinate della fruizione borghese occidentale. A sua volta, George Lewis – figura emblematica dell’AACM e teorico delle pratiche sonore afro-diasporiche – ha evidenziato come l’improvvisazione nera rappresenti un gesto di autodefinizione, un atto di resistenza linguistica contro l’omologazione sistemica. In quest’ottica, le manipolazioni turntablistiche di Jeanty, la sua ibridazione di drum-machine e field recordings, la sovrapposizione di frequenze ambientali e pattern rituali, vanno lette come modalità di scrittura afro-sonica, in cui il soggetto diasporico si riappropria del proprio tempo e della propria voce, non per rappresentarsi secondo categorie imposte, ma per affermare la propria opacità e la propria irriducibile eccedenza. Lontana dalle derive decorativistiche delle world music commerciali, la prassi di Jeanty si situa nel solco delle sperimentazioni più radicali del Novecento nero, recuperandone l’istanza utopica, l’energia visionaria e la tensione verso un’alterità percettiva. In questo senso, il suo lavoro si configura non soltanto come prosecuzione, ma come rilancio critico di quell’archivio sonoro e concettuale che ha reso possibile una musica capace di pensare il mondo altrimenti.
Il posizionamento estetico e politico di Val Jeanty rivela affinità sotterranee e risonanze manifeste con le nuove costellazioni sonore generate dalle diaspore afro-britanniche, in particolare con quelle configurazioni ibride che, dalla Londra postcoloniale a oggi, hanno saputo veicolare e rimodellare linguaggi sonori capaci di coniugare memoria diasporica, urgenza urbana e sperimentazione radicale. Sebbene geograficamente distanti, Jeanty e le scene afro-britanniche condividono un’identica tensione a frantumare i parametri imposti dalle tassonomie eurocentriche del gusto, dell’identità e del genere musicale. Non si tratta di una somiglianza superficiale o di un semplice allineamento estetico, bensì di un’intima convergenza epistemica: tanto la Vodou-Electro della compositrice haitiana quanto le trame poliritmiche di artisti come Moor Mother, Loraine James, Shabaka Hutchings, Theon Cross o Nkisi si nutrono di una visione del suono come forma di conoscenza incarnata, di contro-archiviazione, di resistenza simbolica e somatica. In particolare, il lavoro di Jeanty può essere messo in dialogo con quello di Nkisi, la cui indagine sulle cosmologie bantu attraverso la club culture e l’elettroacustica restituisce una concezione del ritmo come forza metafisica e dispositivo di temporalità espansa, simile a quanto avviene nella trasmutazione acustica del pensiero vodou operata da Jeanty. All’interno della scena londinese più attenzionata, che ha saputo saldare l’eredità della Black Britishness alla ricerca postmoderna attraverso il grime, la dub poetry, il broken beat e il jazz decoloniale, Jeanty si staglia come una figura parallela, ma profondamente affine. Anch’ella convoca nei suoi dispositivi performativi un’identità diasporica che non cerca riconciliazione con la narrazione dominante, ma insiste sull’assenza, sul non-allineamento, sull’oscuro splendore della dissonanza. In questo senso, si potrebbe dire che la sua prassi sia analogamente «anarchivica», per riprendere una categoria cara a Kodwo Eshun e agli Afrofuturist Studies, dove l’archivio non è più un deposito del passato, ma una macchina temporale che genera futuri alternativi.
Laddove artisti come Shabaka Hutchings agiscono all’interno di formazioni strumentali che rielaborano l’estetica jazzistica in chiave pan-africana e militante, Jeanty preferisce affidarsi a dispositivi solitari ed obliqui, al contempo analogici e digitali, spirituali e machinici. Tuttavia, il dialogo simbolico resta aperto e fecondo, poiché in entrambi i casi si assiste a una risemantizzazione della soggettività diasporica, che prende le distanze dalla nozione di autenticità essenzializzata per farsi flusso trans-culturale, corpo tecnologico, memoria diffratta. La convergenza si manifesta anche nella dimensione performativa. Come le esibizioni collettive dei Sons of Kemet o dei Comet Is Coming cercano di trasformare il palco in spazio rituale, in zona liminale tra festa e veglia, anche le installazioni e le live performance di Jeanty si propongono come soglie sensoriali, luoghi sonori in cui il sacro ed il politico si sovrappongono. Entrambe le genealogie sono, in fondo, animate da un’urgenza comune: restituire al suono la sua funzione magica, la sua capacità di convocare spiriti, comunità e possibilità. Non si tratta, dunque, di collocare Jeanty all’interno di una scena britannica con la quale non condivide i codici né le traiettorie geosociali, bensì di riconoscere una sorta di alleanza estetico-politica transatlantica, in cui l’immaginazione nera diasporica si serve del suono come strumento di rinegoziazione dell’essere, del tempo e dello spazio. In questa rete rizomatica di affinità non dichiarate, Jeanty occupa un nodo imprescindibile, ossia un punto di risonanza dove il pensiero afro-atlantico trova nuove vie di espressione, nuove liturgie soniche, nuovi spettri futuri.
Il rapporto di Val Jeanty con la Black American Music – intesa nella sua accezione più ampia e non riduttivamente categorizzante – s’inscrive all’interno di una riflessione estetica e politica che non si limita alla mera appartenenza storica o idiomatica, ma si sviluppa come una forma di adesione critica e al tempo stesso rigenerativa nei confronti di una delle più complesse e ramificate tradizioni sonore del Novecento ed oltre. Il termine BAM, proposto da Nicholas Payton come alternativa alla nomenclatura «jazz», carica di stratificazioni coloniali e semantiche, si offre come spazio semantico aperto, inclusivo di tutte le espressioni musicali nate dall’esperienza nera americana, comprese quelle che hanno saputo oltrepassare i confini idiomatici consolidati, senza recidere il legame con l’origine. In tal senso, Val Jeanty si pone in continuità con tale genealogia, pur muovendosi secondo direttrici asimmetriche e non convenzionali. Non si caratterizza come interprete né custode di un determinato stile, bensì catalizzatrice di una sensibilità sonora che attinge alla stessa matrice di resistenza, di spiritualità incarnata e di reinvenzione semantica che anima la BAM nella sua espressione più radicale. Il suo linguaggio elettronico non si colloca al di fuori della tradizione afroamericana, ma ne rappresenta un’estensione postmoderna, un ramo laterale che trae linfa dalle stesse fonti: il corpo diasporico, la trasmissione orale, il ritmo come forma di pensiero e la tecnologia come terreno di lotta. La vicinanza ideale con figure cardine della BAM sperimentale – da Anthony Braxton a Wadada Leo Smith, da Matana Roberts a Craig Taborn – è rintracciabile non tanto nella strumentazione, quanto nella concezione stessa della musica come atto performativo totale, come pratica di liberazione ontologica e come vettore di politicità non gridata, bensì inscritta nei materiali sonori e nelle scelte formali. In tal senso, Jeanty si mostra erede spirituale dell’AACM (Association for the Advancement Of Creative Musicians), che fin dagli anni Sessanta ha saputo espandere le possibilità del pensiero musicale nero ben oltre le formule canoniche, dando vita a un’estetica fondata sull’invenzione collettiva, sull’autodeterminazione stilistica e sulla legittimazione di mondi sonori alternativi. La Vodou-Electro di Jeanty può dunque essere compresa come una modalità diasporica e diastratica di fare BAM, nella misura in cui ne condivide lo slancio visionario e l’esigenza di articolare un linguaggio proprio, fondato su parametri differenti da quelli imposti dal mercato o dalla musicologia normativa. Il rifiuto di aderire a una tassonomia rigida, l’impiego consapevole di fonti spirituali haitiane, l’ibridazione tra corporeità e codice digitale, la collocano all’interno di un orizzonte comune a molte delle figure che oggi riformulano la BAM da posizioni eterodosse, ossia non come repertorio chiuso, ma come orizzonte mobile, attraversabile e riscrivibile. Proprio in virtù di questo posizionamento, Jeanty si attesta come un agente di risonanza nella trama della Black American Music contemporanea, pur provenendo da un background caribico e inscrivendo la propria poetica nella specificità del pensiero vodou. È in questo incrocio, tra locale e diasporico, tra antichità e futuribilità, che si gioca il suo contributo alla BAM. Un apporto non derivativo, ma dialogico, che restituisce alla nozione stessa di «musica afroamericana» una assorbenza ed una complessità spesso negate dalle semplificazioni categoriali. Così, nella sua prassi sonora, la BAM si declina in forma di spirito più che di stile, di gesto aurale più che di lessico, rinnovando la propria carica visionaria attraverso una voce capace di coniugare l’arcano con il digitale, la diaspora con la possibilità di un altrove uditivo.
Sebbene la traiettoria discografica di Val Jeanty sia disseminata più di frammenti performativi, collaborazioni multidisciplinari e interventi site-specific che di pubblicazioni formalmente canoniche, appare possibile individuare alcuni artefatti sonori emblematici che delineano il tracciato della sua poetica, concept che, pur sfuggendo alla logica dell’album monografico in senso tradizionale, si offrono come nuclei fittissimi di ricerca timbrica, pensiero post-coloniale e riscrittura aurale del sacro. Di seguito, cinque tappe significative che illuminano le molteplici dimensioni del suo operato. Opera prima nel senso più autentico, «Fascinating Her Resilience» (2010, autoproduzione) si presenta come un manifesto sonico nel quale Jeanty articola con disarmante lucidità la propria grammatica: loop medianici, frequenze basse come invocazioni telluriche, inserti vocali spezzati e riverberanti che agiscono come tracce mnestiche, interamente al servizio di un ascolto che è già in sé rito e decrittazione. L’album sfugge a ogni tentativo di catalogazione, oscillando tra sound art, spoken word ed orizzonti post-techno, con una radicalità che rinuncia a ogni concessione formale. Pur non assumendo i contorni di una pubblicazione discografica convenzionale, «Vodou Electro» (2016, installazione sonora / performance, The Bronx Museum Of The Arts) rappresenta uno dei vertici concettuali della sua poetica. Si tratta di una partitura rituale site-specific, concepita per attivare gli spazi museali come zone liminali, attraversate da presenze non visibili ma acusticamente invocate. Le sonorità di derivazione vodou , con tamburi rada e petro, vocalizzi cerimoniali, ritmi poliritmici, vengono qui filtrate attraverso l’apparato digitale, senza mai perdere la loro carica numinosa. Il risultato è un affresco sonoro in cui la dimensione ancestrale si ritrasmette come flusso informatico e incarnazione vibratoria. In «Negus» (2020, con Saul Williams, pubblicazione limitata su vinile), collaborazione con il poeta e artista multidisciplinare Saul Williams, Jeanty svolge il ruolo cruciale di architetta sonora; non semplice producer, bensì tessitrice di ambienti uditivi complessi, capaci di amplificare la densità semiotica del testo poetico. L’opera, distribuita inizialmente solo in installazione e successivamente in edizione vinilica, si attesta come una messa in scena sonoro-rituale, in cui la parola si fonde con il suono in una sinestesia afrofuturista dalle tinte liturgiche. Il suo apporto restituisce a «Negus» una corporeità aurale che trasforma l’ascolto in immersione.
«Val-Inc Live At Roulette» (2021, documento d’archivio / performance) è una registrazione dal vivo, legata alla sua residenza artistica presso Roulette Intermedium, la quale si presenta come un laboratorio performativo in tempo reale, in cui Jeanty convoca e smaterializza elementi eterogenei, ossia elettronica granulare, field recordings haitiani, feedback controllati, scratch ritualizzati, in un continuum sonoro di impressionante coerenza. Il concerto, al contempo visionario e rigoroso, mette in luce la sua capacità di agire come medium fra mondi acustici apparentemente incompatibili, generando una nuova forma di oralità elettronica. In «Saint Heron Compilation: A Cultural Catalogue» (2022, contributo con il brano «Lakou 1»), progetto corale curato da Solange Knowles per la piattaforma Saint Heron, inteso come archivio transdisciplinare di pratiche nere speculative, Jeanty contribuisce con una composizione breve ma corposa, nella quale la pulsazione vodou è trasfigurata in tessitura ambientale, attraverso un lamento di frequenze, un fremito materico che sembra provenire da un altrove temporale. Il pezzo, lungi dall’essere un semplice frammento, si configura come un concentrato di poetica diasporica, sintesi della sua intera visione in pochi minuti di materia acustica. Questi cinque artefatti, pur eterogenei nella forma e nella destinazione, testimoniano con forza come il lavoro di Val Jeanty si collochi ben al di là delle convenzioni discografiche, piuttosto ogni sua creazione si presenta come situazione aurale, come evento sonoro dotato di una propria ritualità, in cui convivono genealogia, sperimentazione e trasmutazione. Il suo catalogo – se così si può definire – non si lascia ridurre a una discografia ordinata, ma si manifesta come una cartografia rizomatica, fatta di apparizioni, eclissi e riemersioni.