Fred Hersch: Architettura del silenzio e grammatica dell’introspezione
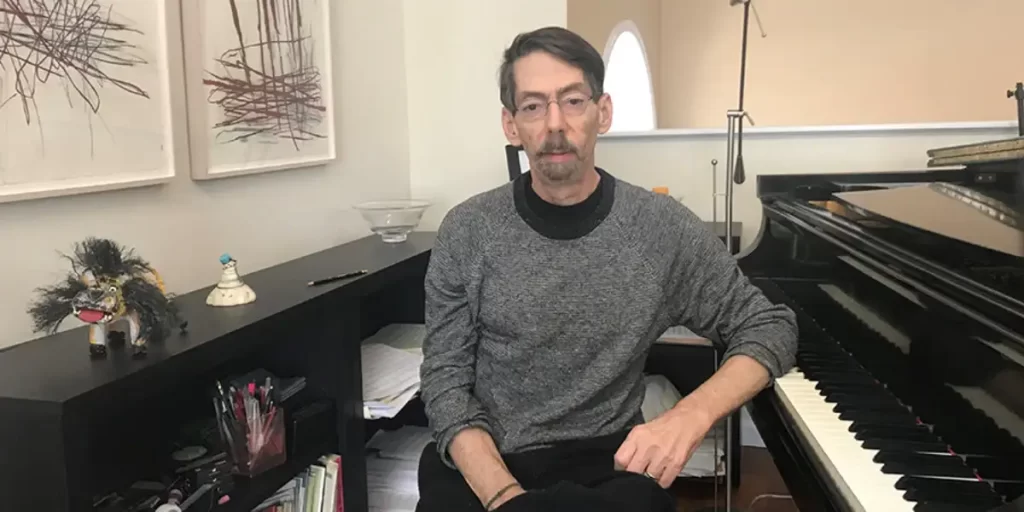
Fred Hersch / PH Scott Morgan
Figura eminente nell’odierna costellazione jazzistica, Hersch incarna una delle più autorevoli presenze del panorama contemporaneo, non soltanto per l’ampiezza e la profondità della sua produzione discografica, ma per l’influenza sotterranea ma pervasiva esercitata su più generazioni di musicisti.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Precocissimo nella pratica pianistica ed altrettanto incline alla scrittura musicale, Fred Hersch manifesta sin dall’infanzia un’attitudine spiccata per l’elaborazione sonora, esercitandosi dapprima sotto la guida di Jeanne Kirstein e componendo già all’età di otto anni. Vincitore di competizioni pianistico-accademiche in età preadolescenziale, approda all’universo jazz durante il periodo di formazione al Grinnell College in Iowa, dove avviene la prima, decisiva deviazione dal percorso accademico tradizionale. L’abbandono della carriera universitaria in favore di un’immersione pratica nella prassi jazzistica a Cincinnati costituisce una delle prime manifestazioni di quella tensione tra rigore formale e libertà espressiva che avrebbe contraddistinto la sua traiettoria artistica. Sotto la sapiente guida di Jaki Byard al New England Conservatory, Hersch affina un linguaggio pianistico intriso tanto di lirismo quanto di audacia armonica, riuscendo a catalizzare l’attenzione della critica già in sede accademica, documentato da un recital celebrato dalla stampa come «una bella vetrina per Fred Hersch», non tanto per virtuosismi fini a sé stessi, quanto per una sensibilità interpretativa fuori dall’ordinario, densa di sfumature e chiaroscuri. Conclusi gli studi, inizia a trasmettere tale visione nell’ambito della didattica, assumendo il ruolo di docente di pianoforte jazz, incarico che consoliderà nel tempo la sua vocazione pedagogica, mai disgiunta da quella performativa.
Figura eminente nell’odierna costellazione jazzistica, Hersch incarna una delle più autorevoli presenze del panorama contemporaneo, non soltanto per l’ampiezza e la profondità della sua produzione discografica, ma per l’influenza sotterranea ma pervasiva esercitata su più generazioni di musicisti. Il suo pianismo, spesso definito «elegante», «inventivo», «leggendario» – come recitano rispettivamente le lodi del Los Angeles Times, di Vanity Fair e del New Yorker – non si presta a facili incasellamenti, ma rifugge tanto la spettacolarizzazione del gesto quanto la glaciale astrazione cerebrale, muovendosi in un territorio interstiziale dove la disciplina del contrappunto incontra l’urgenza del gesto improvvisativo, fondendosi in un’eloquenza musicale che sa farsi confessione, racconto, meditazione. Numerose e prestigiose le onorificenze che costellano la sua carriera: quindici nomination ai Grammy Awards, riconoscimenti reiterati da parte della Jazz Journalists Association come «Pianista dell’anno», l’ambito titolo di Doris Duke Artist nel 2016, nonché il Prix Honorem de Jazz assegnatogli dall’Académie Charles Cros per l’intera produzione artistica. Riconoscimenti che, pur attestando l’alto profilo istituzionale della sua figura, non esauriscono la portata reale di un lascito, che risiede nella capacità di trasfigurare la grammatica jazzistica in un codice espressivo personalissimo, cesellato con pazienza monastica, spesso sospeso fra la trasparenza del fraseggio e l’intensità emotiva del silenzio. Continuando a incidere, insegnare, collaborare e riflettere sul senso stesso del fare musica, Hersch prosegue un cammino artistico che si nutre tanto del dialogo con la tradizione quanto dell’apertura verso forme nuove di ascolto e di relazione, rinnovando di continuo la propria voce senza mai tradirne l’essenza, dando forma a un pensiero musicale che si sviluppa come un unico gesto continuo, disegnando spazi di ascolto sempre più rari e necessari.
Nel delineare la collocazione di Fred Hersch entro l’articolato e plurivoco panorama pianistico postbellico – dominato in larga misura dall’eredità afroamericana e al tempo stesso attraversato da una crescente pluralità espressiva – occorre evitare tanto l’appiattimento comparativo quanto la retorica del confronto sterile. Hersch si situa in una linea evolutiva che, pur attingendo in profondità al lessico afroamericano del jazz moderno, se ne discosta per approdi estetici e tensioni formali che tradiscono una diversa genealogia culturale, più prossima alla sensibilità cameristica europea e ad una concezione del pianoforte come spazio interiore di ricerca, piuttosto che come arena per la dimostrazione di forza ritmica o di superiorità idiomatica. In lui appare chiaramente rintracciabile l’eredità di Thelonious Monk, non tanto sul piano imitativo quanto per l’assunzione di un’idea pianistica fondata sull’irregolarità espressiva, sulla valorizzazione dell’interstizio e sulla poetica dell’asimmetria. Tuttavia, laddove in Monk il gesto risulta affilato, quasi scultoreo, in Hersch si fa liquido, traslucido, più prossimo alla trasparenza impressionistica di un Bill Evans, con cui condivide una visione dell’improvvisazione come flusso mentale, come continua modulazione interiore. A differenza di molti suoi predecessori afroamericani, il cui pianismo è stato spesso veicolo di una forza tellurica e comunitaria (pensiamo a McCoy Tyner, Cecil Taylor, Andrew Hill), Hersch sviluppa un linguaggio riflessivo, intimista, tendenzialmente introverso, più incline all’introspezione notturna che all’estroversione collettiva, privilegiando la sottigliezza timbrica alla densità percussiva, la linea melodica rarefatta all’affermazione dichiarativa.
Rispetto a figure come Herbie Hancock, che pur ha attraversato territori simili, oscillando tra rigore formale e libertà postmoderna, Hersch rifiuta tanto l’euforia dell’eclettismo quanto l’estetica della performance assoluta. Il suo pianismo si sottrae al gigantismo virtuosistico, prediligendo invece una narrazione più raccolta, cesellata nel dettaglio, dove la nota sembra affiorare da un silenzio precedentemente ascoltato, e mai semplicemente interrotto. Tale attitudine lo avvicina a una linea pianistica «bianca» post-Evans, rappresentata da pianisti come Richie Beirach ma anche qui si impone una distinzione. In Hersch non vi è traccia né di manierismo lirico né d’inquietudine speculativa. Piuttosto, la sua cifra si traduce in una forma di classicismo moderno, permeato da un senso dell’equilibrio che non rinuncia al rischio, ma lo misura, lo controlla, lo trasforma in struttura. Una scrittura, la sua, che ha molto a che fare con la verticalità armonica e con una concezione quasi architettonica della forma, ma che non smarrisce mai la tensione narrativa, procedendo con passo fermo ma mai rigido, sospinto da una cantabilità fragile, umana, mai assertiva. Il contributo di Fred Hersch si distingue per l’eleganza riservata di una voce che rifugge tanto la tradizione del «pianismo palestrato» afroamericano, quanto la deriva iperintellettuale di certa avanguardia bianca, inscrivendosi in uno spazio terzo, di confine, dove la ricchezza dell’emozione non è mai separata dalla chiarezza formale, e dove l’improvvisazione diviene forma di meditazione e di ascolto prima ancora che di esibizione.
Il confronto tra Fred Hersch e tre figure cardinali della moderna arte pianistica jazz, quali Bill Evans, Chick Corea e Keith Jarrett, impone un’indagine che si muova non tanto per somiglianze epidermiche o per ascendenze dichiarate, quanto per consonanze sotterranee e divergenze poetiche, leggibili attraverso una lente che tenga conto tanto dell’estetica quanto della visione del mondo che ciascun artista consegna alla propria opera. Con Bill Evans il legame appare forse il più immediato, e non soltanto per una prossimità stilistica riconosciuta dallo stesso Hersch, che non ha mai celato l’influsso esercitato dal pianista del Village Vanguard. Tuttavia, occorre distinguere tra imitazione e filiazione profonda. Se Evans aveva fatto della sottrazione e del lirismo introverso il proprio tratto distintivo, dando voce a una vulnerabilità nuova nel jazz moderno, Hersch ne raccoglie l’eredità radicalizzandone il portato intimo, ma svincolandosi da quell’idealismo armonico che in Evans tendeva spesso all’astrazione. In Hersch la trasparenza non è mai un esercizio formale, bensì un luogo abitato da tensioni interne, un campo di forze fragile ed inquieto. La sua articolazione melodica conserva la consistenza verticale evansiana, ma la trasfigura in un lessico ancor più rarefatto, talvolta quasi afasico, come se ogni nota venisse scelta a posteriori, dopo un tempo di riflessione o di rinuncia. Diverso e meno diretto è il rapporto con Chick Corea, la cui cifra espressiva si è spesso risolta in una teatralità energetica, in un’estetica della sorpresa e del gioco formale. Corea, che incarna la declinazione più brillante e ludica dell’intellettualismo jazzistico post-bop, si muove con agio tra idiomi eterogenei (dal flamenco all’avanguardia, dal jazz-rock al repertorio classico), mentre Hersch rifugge sistematicamente ogni eclettismo dichiarato, preferendo una direzionalità espressiva coerente, una continuità meditativa che nulla ha del funambolismo. Dove Corea dilata, Hersch concentra; dove il primo sovrappone registri linguistici, il secondo scava pazientemente all’interno di un’identità musicale unitaria, che non cerca maschere né digressioni. Laddove Corea è centrifugo, Hersch si mostra inesorabilmente centripeto.
Con Keith Jarrett il discorso si fa più complesso e, per certi versi, dialettico. Entrambi condividono una radicale fedeltà al momento improvvisativo come luogo di rivelazione, nonché una profonda immersione nella dimensione solistica, che diventa quasi diario sonoro. Tuttavia, mentre in Jarrett l’improvvisazione assume tratti di trance estatica, di flusso verboso e spesso visionario, come se ogni concerto fosse un rito sciamanico, una traversata emotiva senza rete, in Hersch permane una vigilanza formale, una lucidità strutturale che non ammette l’abbandono. Anche quando il suo fraseggio si fa febbrile, rimane legato ad una geometria interiore e ad una forma nascosta che ne guida lo sviluppo. In Jarrett si assiste spesso a una sorta di débordement del materiale, ad una poetica dell’eccesso che rischia talvolta la ridondanza; Hersch, al contrario, persegue una misura ed una compostezza che sa farsi struggente proprio in virtù della sua reticenza. Sotto questa luce, Fred Hersch appare come un autore di piena maturità, non tanto perché giunge «dopo» questi maestri, quanto perché ha saputo metabolizzarne le eredità senza mai rimanerne prigioniero. Il suo è un pianismo della coscienza, della responsabilità verso il suono, dove nulla è concesso all’effetto ma tutto è sorretto da un’intenzione poetica lucida e intransigente. In ciò, più che un epigono, Hersch è forse un raro esempio di continuità trasformativa, agendo come trait d’union tra le tensioni liriche di Evans, le invenzioni gioiose di Corea e le vertigini mistiche di Jarrett, pur distillandole in una voce che non imita, ma riflette, ascoltando se stessa mentre accade.
Il confronto tra Fred Hersch e Brad Mehldau, più che un semplice gioco di specchi generazionale o una contesa stilistica, si delinea come un terreno fertile per mettere in rilievo due differenti posture esistenziali nei confronti dello strumento, dell’improvvisazione, e più radicalmente della musica stessa intesa come forma di pensiero incarnato. Sebbene Mehldau abbia spesso riconosciuto apertamente l’influenza esercitata da Hersch nei suoi anni formativi, riconoscendogli una funzione quasi «maieutica», tra i due s’instaura una dialettica che trascende la relazione maestro-allievo, configurandosi piuttosto come una biforcazione etica e poetica all’interno di un medesimo orizzonte espressivo. Entrambi pongono il pianoforte al centro di una riflessione profonda sul linguaggio jazzistico post-evansiano, condividendo un interesse per l’ibridazione fra struttura e lirismo, fra architettura armonica ed abbandono introspettivo. Eppure, se Hersch si distingue per una scrittura cristallina, quasi da miniaturista, costruita su una sintassi tersa e rarefatta, in cui la pausa ha spesso la stessa dignità semantica del suono, Mehldau tende invece ad un’estetica dell’accumulo e del parossismo analitico. Il primo scava con cautela, lasciando che l’intuizione trovi il suo tempo per affiorare; il secondo stratifica, disseziona, espande, in una sorta di flusso coscienziale a tratti ipertrofico, che cerca nell’eccesso formale la cifra della verità. Hersch si muove in una dimensione prevalentemente analogica. L’atto musicale diviene per lui memoria, ascolto e tessitura narrativa. Mehldau, viceversa, predilige l’impalcatura teorica, la tensione dialettica fra ordine e disgregazione, quasi che la musica non possa prescindere da un confronto continuo con l’intelligenza che la genera. Le sue celebri suite improvvisate, fitte di contrappunti, modulazioni imprevedibili ed ostinati poliritmici, testimoniano una volontà di controllo che talvolta sfiora il labirinto, con una verticalità armonica che si fa sovente speculazione più che confessione. Hersch appare dunque più prossimo ad una poetica della discrezione. La sua arte – come accennato – si nutre di silenzi, esitazioni, risonanze interne, dando vita ad un pianismo che non impone, ma si offre. In lui si avverte l’urgenza dell’espressione senza mai il compiacimento dell’ostentazione, e persino nei momenti di maggiore opulenza armonica permane un senso di economia, di misura e di pudore. Mehldau, al contrario, costruisce un discorso musicale che tende all’apertura ed alla moltiplicazione dei livelli semantici, con un’estetica che spesso assume tratti quasi «barocchi», nel senso non ornamentale ma strutturale del termine, con continue torsioni formali, deviazioni contrappuntistiche e scomposizioni ritmiche. Non va trascurato, infine, il diverso rapporto con la cultura extra-jazzistica. Entrambi hanno praticato con rigore e finezza la rilettura del repertorio non jazz (da Schubert a Radiohead), ma se Hersch si avvicina al materiale con un rispetto quasi sacrale, tentando un innesto coerente con la propria voce poetica, Mehldau lo sottopone ad un processo di riscrittura radicale, spesso centrifugando la fonte fino a renderla irriconoscibile, in un gesto che è al tempo stesso omaggio e sovversione. Si potrebbe dire che Hersch suoni per chiarire a sé stesso e all’ascoltatore ciò che una determinata forma musicale può ancora contenere di umano, mentre Mehldau suona per interrogare, per disturbare e per mettere in crisi i limiti stessi della forma. Da un lato, una disciplina poetica della rivelazione; dall’altro, un’intelligenza febbrile che non conosce tregua, cercando nella complessità una nuova, provvisoria unità. Due mondi, due sensibilità, due etiche della forma. affini nell’eccellenza, opposti nella natura del loro silenzio.
Il rapporto tra Fred Hersch e l’Italia, sebbene episodico nella sua articolazione temporale, si configura come un incontro fitto di risonanze, una sorta di congiunzione elettiva tra due sensibilità affini, accomunate da una concezione della musica come luogo di ascolto, di misura e di poetica eleganza. In tale contesto si colloca la sua significativa collaborazione con Enrico Rava, figura centrale del jazz europeo, nonché interlocutore privilegiato per ogni musicista capace di pensare la forma come apertura, l’improvvisazione come gesto lirico e la sonorità come atto di grazia sospesa. La sintonia tra i due si fonda su un terreno comune che travalica le coordinate stilistiche per investire la sfera più sottile della visione musicale. Entrambi rifuggono la retorica dell’energia gratuita, prediligendo invece un’interazione fatta di sguardi laterali, di discrezioni eloquenti, di pause che dicono quanto, e talvolta più, delle note. L’intesa che li unisce è di natura quasi chamber jazz, nel senso più nobile e alto del termine, dove nulla è dimostrativo, nulla risulta urlato, tutto si costruisce in una dimensione di ascolto reciproco, in cui il suono si affina come linguaggio condiviso e, al tempo stesso, come esercizio di sottrazione. Con Rava, Hersch entra in una relazione simmetrica in cui le geometrie del pianoforte si offrono come paesaggio ideale per la tromba cantabile, lunare ed assorta del musicista triestino. In tale contesto, l’incontro non assume mai i tratti di una contaminazione esotica o di un semplice scambio idiomatico, ma si struttura piuttosto come un dialogo tra due estetiche convergenti: da un lato, il pianismo scolpito e pensoso di Hersch, dall’altro, la verticalità poetica e mai ridondante della voce raviana. È nel non-detto, nel «fra le righe» sonoro, che si cristallizza la forza dell’incontro, dove ogni nota pesa, ogni intervallo respira ed ogni silenzio agisce come forma. La tappa discografica italiana più rappresentativa di tale collaborazione è senz’altro l’album «The Plot» edito dalla Red Records, storica etichetta italiana che, sotto la guida visionaria di Sergio Veschi, ha saputo dare voce, sin dagli anni ’80, ad una geografia del jazz svincolata dai canoni anglofoni, favorendo incontri che avrebbero altrimenti rischiato di rimanere nel novero delle possibilità mancate. La Red Records, che può essere letta, a tutti gli effetti, come una vera e propria officina del dialogo, ha dato spazio ad un Hersch giovane ma già in possesso di una fisionomia musicale nitida, ponendolo accanto a figure europee di spicco senza mai piegarne la voce, bensì esaltandone la dimensione più cameristica, più meditativa, e più essenziale. Il ruolo dell’Italia nella carriera di Hersch, pur non centrale in termini di quantità, ha dunque rappresentato un momento di rilevanza artistica, offrendo al pianista statunitense un contesto meno competitivo e più contemplativo, in cui far emergere quell’aspetto del proprio linguaggio meno incline all’esibizione e più prossimo alla meditazione collettiva. Esperienza che, lungi dall’essere marginale, ha contribuito a rafforzare la vocazione del suo stile verso una musica che non urla, non persuade, ma si insinua, alla medesima stregua di taluni sguardi obliqui di Rava, o certe ombre notturne delle città italiane , restando a lungo nell’orecchio interiore, agendo silenziosamente e trasformando.
Tra le numerose pubblicazioni che costellano l’itinerario discografico di Fred Hersch, cinque album emergono per rilevanza sia sul piano strumentale che per profondità estetica e la coerenza esecutiva, delineando una traiettoria musicale che si sviluppa secondo un pensiero armonico rigoroso, una concezione architettonica della forma e una scrittura che non abdica mai alla superficialità idiomatica. «Songs Without Words» (1998) appare come un’opera bifronte e speculare, strutturata in tre dischi che alternano composizioni originali a riletture di standard, quale una summa poetica della scrittura herschiana. Il piano trio si muove entro spazi strutturalmente rigorosi, in cui la voce armonica predilige la stratificazione di triadi sovrapposte e la torsione delle dominanti secondarie in funzione modulante. L’uso delle rootless voicings, già appartenente alla tradizione evansiana, viene interiorizzato e declinato con una sintassi più secca e meno oleografica, mentre il fraseggio melodico, spesso retto da cellule anapestiche e sospensioni ritmiche, si distende con una tensione narrativa che sembra derivare più da Brahms che dal bebop. Il contrabbasso di Drew Gress e la batteria di Tom Rainey agiscono come contrappesi mobili e mai ornamentali, rendendo la scrittura polifonica in senso pieno, non solo timbrico ma funzionale. In «Let Yourself Go: Live at Jordan Hall» (1999), concerto in piano solo, Hersch offre una mappa intima della propria topografia pianistica, dove ogni componimento diviene un campo di rifrazione, nel quale la melodia si articola per interferenze interne e contrappunti latenti. Il trattamento armonico degli standard (I Got Rhythm, Bemsha Swing) si distingue per la vaporizzazione delle cadenze, spesso dislocate per intervalli di terza maggiore (secondo logiche alla Coltrane), mentre l’accompagnamento risulta costruito su ostinati contrappuntistici in tempo dispari che destabilizzano la quadratura formale ed aprono ad una sintassi metrica imprevedibile. Il tocco, perennemente controllato, si carica di una densità dinamica che scarta tanto il romanticismo manierato quanto l’aggressione percussiva, scegliendo invece un punto di equilibrio sonoro tra articolazione impressionistica e chiarezza timbrica alla Debussy. Con «Leaves Of Grass» (2005) la scrittura si fa coralità. Ispirato a Walt Whitman, l’album trascende i confini del jazz per farsi cantata cameristica, con l’inclusione di due voci recitanti (Kurt Elling e Kate McGarry), un settetto strumentale e un impianto armonico che guarda tanto alla verticalità schumanniana quanto alla modulazione continua della seconda scuola di Vienna. La disposizione delle voci è spesso condotta secondo logiche contrappuntistiche. Si noti, ad esempio, come il sax soprano ed il violoncello vengano trattati non come strumenti melismatici, ma come linee armoniche indipendenti che partecipano attivamente allo sviluppo tematico. L’armonia si allontana dalla funzione tonale tradizionale per assumere un ruolo evocativo. Successioni di triadi aumentate, cluster quartali e slittamenti plananti di quinte vuote costruiscono un paesaggio sonoro che fa della dissonanza non un gesto espressionista, ma una condizione esistenziale. «Alone At The Vanguard (2011), registrazione solistica dal vivo, rappresenta, forse più di ogni altra, il compimento di una ricerca interiore attraverso il linguaggio pianistico. Il trattamento delle ballad (In The Wee Small Hours Of The Morning e Pastorale) rivela una predilezione per il cromatismo interno, per le relazioni tra voci non esplicitate ma implicite nel tessuto armonico, tanto che si assiste frequentemente ad un gioco di voice leading interno in cui le tensioni si risolvono non per cadenza, ma per assorbimento, in uno spazio sonoro costruito sul respiro e sull’attesa. Sul piano ritmico, l’uso di irregolarità metriche e di fluttuazioni agogiche, con continui rallentandi, pause sospese ed appoggiature sincopate, interrompe ogni prevedibilità, lasciando che la forma emerga come necessità, non come schema. La scrittura appare pentagrammatica anche quando improvvisata, mentre ogni linea sembra presupporre la trascrizione, tanto è curata e ricca la sua tessitura armonica. «Breath By Breath» (2022) si sostanzia come un’opera cameristica concepita per trio jazz e quartetto d’archi (il Mivos Quartet), incarnando la piena maturazione della poetica herschiana. Il materiale tematico viene lavorato secondo principi motivici minimi, sviluppati con un senso quasi mozartiano della proporzione e della variazione. Gli archi non fungono da semplice sfondo timbrico, ma si innestano nella scrittura pianistica con intelligenza contrappuntistica, contribuendo alla costruzione di una polifonia allargata che, pur nella sua complessità, mantiene una trasparenza strutturale rara. Il sistema armonico oscilla tra tonalità allusive e campi modali fluidi, spesso costruiti su scale miste e dominanti secondarie (lidia alterata e misolidia b9/#9) che generano ambiguità sospese, mai risolte. La scrittura per pianoforte alterna momenti di verticale concentrazione accordale a passaggi in ottave spezzate, di derivazione lisztiana, ma senza mai eccedere in retorica gestuale, dove ogni elemento appare calibrato secondo una precisa etica della forma, procedendo per rarefazione e sintesi, senza dispersioni né eccessi. In questi cinque album, diversi per organico, contesto e finalità, Fred Hersch si afferma come un autore che coniuga rigore compositivo e libertà espressiva, scavando con ostinazione nell’interiorità del suono, trasfigurando il gesto jazzistico in una calligrafia poetica in cui nulla è occasionale, tutto è forma, respiro e necessità.






