«La Materia del Suono» di Diego Petrini progressioni multistrato che oltrepassano la sintassi jazzistica (AMS Records, 2025)
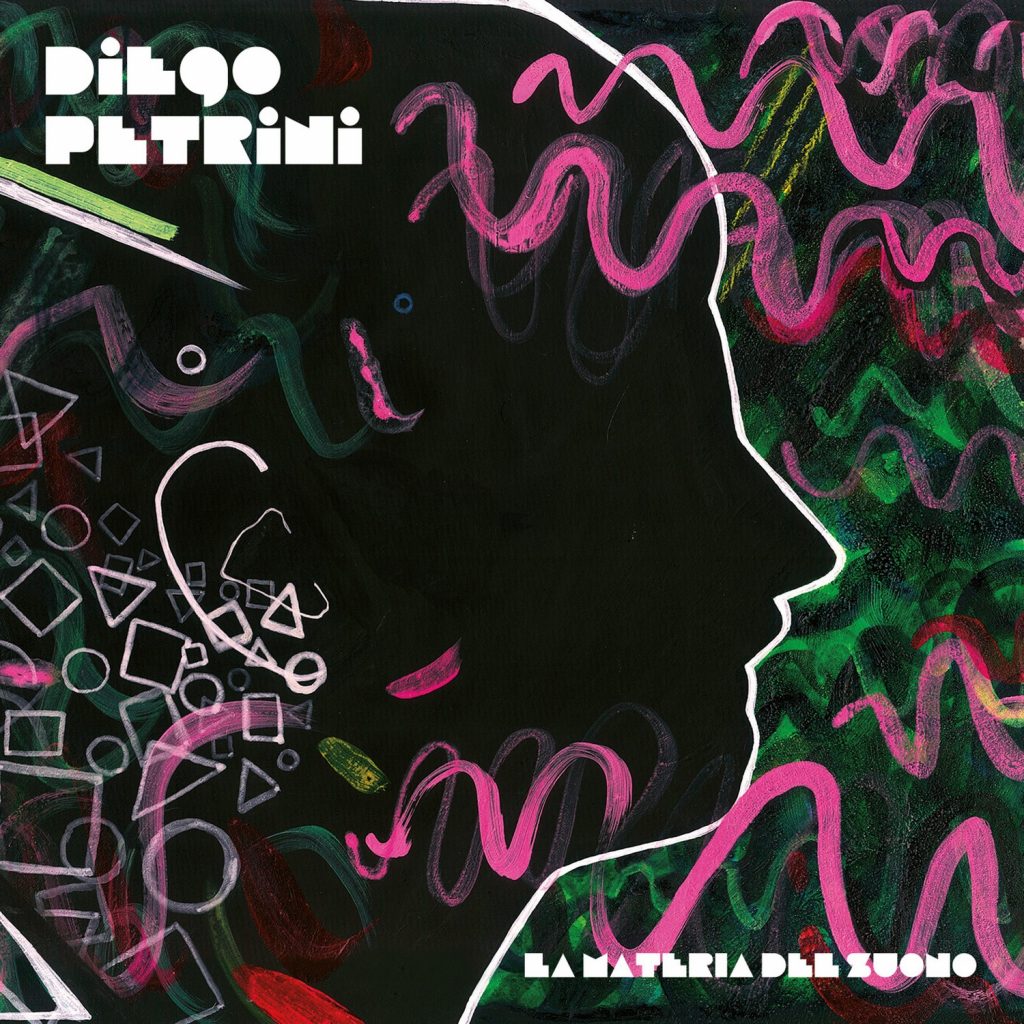
L’album si propone come una struttura tematica e come un ordine interno che si dipana mediante logiche musicali e visioni poetiche. Il musicista umbro costruisce, modella e disegna. Ogni episodio sonoro risponde ad una grammatica che non si lascia ridurre a stile, ma che si articola secondo un codice espressivo personale, rigoroso e musicalmente eloquente.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Diego Petrini, musicista umbro e figura di riferimento nel panorama del progressive italiano contemporaneo, inaugura il proprio percorso da solista con «La Materia del Suono», pubblicato da AMS Records. L’album, concepito come un unico arco narrativo suddiviso in due sezioni tematiche, si regge su un impianto compositivo che trae origine da un gesto pianistico sedimentato nel tempo, capace di generare strutture sonore complesse e di modulare ambienti acustici con precisione timbrica e coerenza armonica. La scrittura si estrinseca secondo un principio di multistratificazione, dove ogni elemento – ritmico, melodico e timbrico – concorre alla definizione di un ordine interno che non si lascia ridurre alla mera somma di generi: jazz-rock, fusion, psichedelia, lirica, folk ed elettronica. Per intenderci, non si tratta di contaminazioni, ma di un tessuto espressivo che si vivifica mediante sovrapposizioni, contrappunti e variazioni tematiche. Il pianoforte, strumento generativo e dominante, non si limita a condurre, ma costruisce, plasma ed orienta. La sua presenza non risulta mai decorativa, né funzionale, bensì strutturale.
«Come in mare le onde» apre il ciclo con un gesto pianistico che stabilisce un asse armonico mobile, imperniato su progressioni modali che si srotolano secondo una prassi di espansione e contrazione. Il tema iniziale, implementato su una scala Lidia trasposta, si articola mediante sovrapposizioni di quarte e seste che generano una sensazione di apertura, di moto ondulatorio, senza mai ricorrere a cliché tonali. Il basso fretless di Giorgio Panico dialoga amabilmente con tutto il line-up. Le sue linee ascendenti e discendenti, spesso costruite su intervalli di nona e undicesima, creano una tensione sottile rilanciate dal pianoforte. Il flauto traverso, affidato a Eva Morelli, interviene con una voce che s’innesta, mentre le sue frasi, spesso costruite su cellule pentatoniche, evocano climi orientali, rimandano a paesaggi interiori, suggeriscono una dimensione contemplativa che richiama il Tarkovskij di «Solaris», dove l’acqua non è elemento naturale, ma metafora del tempo. «Alla Deriva» prosegue il discorso armonico con una struttura più frammentata, dove il pianoforte abbandona la linearità tematica per sondare territori più dissonanti. Le progressioni si reggono su accordi di settima diminuita e cluster che si dissolvono in arpeggi sospesi e privi di risoluzione. La chitarra elettrica di Andrea Morelli interviene con un fraseggio che tende alla texture, tra distorsioni controllate, riverberi lunghi ed armonici artificiali che ravvivano un ambiente sonoro che rimanda al cinema di Lynch, dove qualsiasi suono è traccia ed ogni nota rappresenta indizio. La batteria di Petrini, più rarefatta, impiega pattern irregolari, con accenti spostati e metriche composite che destabilizzano la percezione del tempo. Il risultato è una pagina musicale inafferrabile, che si conficca fra le meningi come un pensiero deformato. «Macchia Verde» introduce un clima più tonale, ma non per questo meno articolato. La struttura accordale poggia su una progressione discendente di scale minori con aggiunta di nona e undicesima, che generano una sensazione di languida malinconia. La fisarmonica di Claudio Ridolfi, impiegata con parsimonia, interviene con una voce che rimanda alla musica popolare dell’Appennino, ma filtrata attraverso una lente jazzistica. Il flauto, ora più lirico, disegna linee che si sovrappongono al pianoforte in un contrappunto che richiama la scrittura di Ravel, in particolare la «Rapsodie Espagnole». La suggestione letteraria affiora nella costruzione del brano, dove la ripetizione tematica, la variazione ritmica, e la dissolvenza finale rimandano all’impianto narrativo di Pavese, in cui qualsiasi ritorno è una variazione, ogni ripetizione costituisce una perdita.
«Immagini al Tramonto» si presenta come una meditazione armonica, costruita su una scala Misolidia con alterazioni cromatiche che generano un senso di sospensione. Il pianoforte impiega voicing aperti, con intervalli di nona e tredicesima che si dissolvono in cluster timbrici. Il sax soprano, ora protagonista, articola frasi che si sviluppano secondo una logica di accumulo, dove ogni frase una conseguenza. Il basso, più presente, impiega tecniche di tapping e glissato che alimentano una tessitura ritmica fluida, quasi liquida. La suggestione cinematografica è evidente, al punto il motivo potrebbe accompagnare una sequenza di Antonioni, dove il paesaggio non è sfondo, ma personaggio ed il silenzio appare come parte integrante della narrazione. «Etere» rappresenta una svolta: la struttura armonica si fa più verticale ed incisiva. Il pianoforte impiega accordi quartali e sovrapposizioni bitonali che generano una tensione non risolta. Il Moog, introdotto con discrezione, articola linee che si muovono su scale esatonali, creando una sensazione di straniamento. La batteria, più presente, fa uso di pattern sincopati con accenti spostati che destabilizzano la pulsazione. Il flauto, filtrato elettronicamente, interviene con frasi che sembrano provenire da un’altra dimensione. La suggestione letteraria rimanda a Calvino, in cui la leggerezza è precisione ed ogni suono è una città invisibile che si costruisce e si dissolve. «Sangue Freddo» chiude la prima sezione con una pagina musicale più drammatica, costruita su una progressione cromatica discendente che genera una tensione costante. Il pianoforte fa ricorso ad accordi di settima diminuita e cluster che si sovrappongono a linee melodiche spezzate. Il sax, ora più aggressivo, articola frasi che si muovono su scale alterate, con intervalli di tritono e nona aumentata. La chitarra, distorta, interviene con un fraseggio che porta alla mente il Fripp di «Red», ma filtrato attraverso una sensibilità più lirica. La batteria, incalzante, impiega metriche irregolari e accenti spostati che implementano un senso di urgenza. La suggestione cinematografica rimanda a Herzog, in cui l’habitat sonoro è ostile, ma necessario ed ogni nota diventa una sfida. «Fragole di Cinabro» apre la seconda sezione con una pagina musicale più rarefatta, costruita su una scala Frigia con alterazioni cromatiche. Il pianoforte impiega voicing aperti, con intervalli di nona e undicesima che si dissolvono in cluster. Il Moog, ora protagonista, articola linee che si muovono su scale simmetriche, generando una tessitura sonora che rimanda al Ligeti di «Atmosphères». Il flauto, filtrato elettronicamente, interviene con frasi che sembrano provenire da un’altra dimensione. La suggestione letteraria rimanda a Ballard, dove il paesaggio sonoro post-apocalittico, ma è mai non privo di bellezza.
«Antropomorfa» rappresenta un vertice compositivo, in cui la struttura accordale si fonda su sovrapposizioni bitonali e modulazioni non risolutive. Il pianoforte preferisce accordi quartali e cluster che si dissipano in arpeggi spezzati. Il sax, sempre più lirico, ricorre a frasi che si spostano su scale alterate, con intervalli di tritono e nona aumentata. La chitarra, distorta, interviene con un fraseggio che richiama il Fripp di «Starless», mentre la batteria, incalzante, adotta metriche irregolari e accenti spostati che producono un senso di urgenza. La suggestione cinematografica rimanda a Tarkovskij, sulla scorta di uno scenario sonoro è ostile, in cui ogni nota rappresenta una sfida. «Sublimazione» affiora come una meditazione armonica, costruita su una scala Misolidia con alterazioni cromatiche che apportano un senso di sospensione. Il pianoforte opta per voicing aperti, con intervalli di nona e tredicesima che si sfaldano all’interno di cluster timbrici. Il sax soprano emette frasi che si dipanano secondo una metodologia di accumulo. Il basso ammannisce tecniche di tapping e glissato che danno vita ad una substrato ritmico fluida, quasi liquida. La suggestione cinematografica è evidente, tanto che l’asset motivico potrebbe accompagnare una sequenza di Antonioni, dove la musica ha voce in capitolo come certi personaggi. «Mimesi» rappresenta una svolta: la struttura armonica si fa più verticale, più incisiva. Il pianoforte distilla accordi quartali e sovrapposizioni bitonali che generano una tensione non risolta. Il Moog, introdotto con discrezione, innesca linee che si muovono su scale esatonali, dando una sensazione di straniamento. La batteria, calibrata su metriche irregolari e accenti spostati sembra frammentare il groove. Ogni colpo di rullante, ogni sospensione sul charleston, ogni apertura sul ride contribuisce a costruire un ambiente ritmico che emerge secondo una logica di dislocazione temporale. Il basso fretless, impiegato con parsimonia, interviene come voce intermedia, tessendo legami tra le pulsazioni percussive e le espansioni armoniche del pianoforte. La scrittura si fonda su una dialettica tra stasi e moto, tra permanenza e deviazione. Il tema, se così si può chiamare, non si presenta come melodia, ma come figura ricorrente che si trasforma, si dissolve, si ricompone. Il flauto traverso, filtrato elettronicamente, interviene con frasi spezzate, talvolta appena accennate, che sembrano provenire da una memoria sonora lontana, come se il flusso sonoro stesso fosse il riflesso di un ascolto interiore. La chitarra elettrica, impiegata in modo non convenzionale, lavora sul timbro, sulla saturazione e sulla distorsione controllata, creando velature acustiche che si sovrappongono al tessuto armonico senza mai imporsi. Si potrebbe pensare a certi passaggi di Maurice Blanchot, dove il pensiero si prolunga, si sospende e si rifrange. Oppure a certe pagine di Claude Ollier, dove la narrazione si dissolve in una tessitura verbale che cerca i la vibrazione. «La Materia del Suono» non si presenta come un semplice album, ma si propone come una struttura tematica, come un ordine interno che si dipana mediante logiche musicali e visioni poetiche. Petrini costruisce, modella e disegna. Ogni episodio sonoro risponde ad una grammatica che non si lascia ridurre a stile, ma che si articola secondo un codice espressivo personale, rigoroso e musicalmente eloquente.






