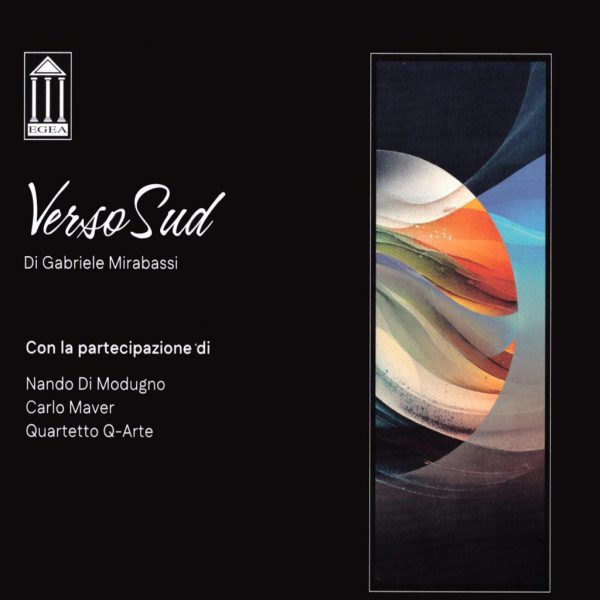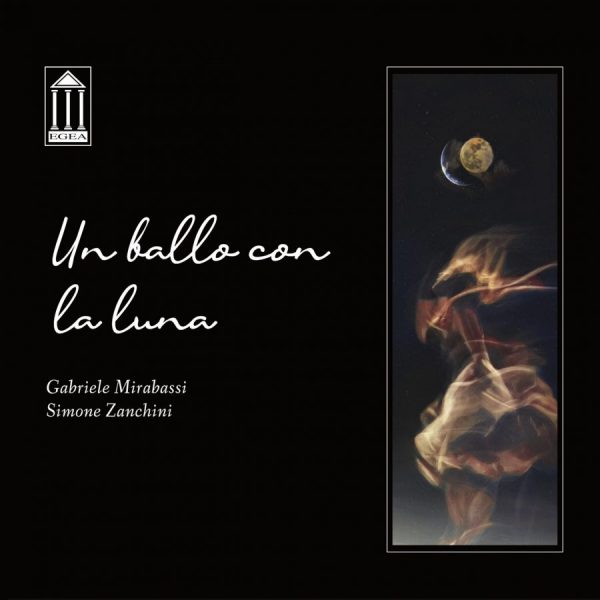Gabriele Mirabassi, l’arte del chiaroscuro sonoro: poetiche timbriche e geografie interiori

Gabriele Mirabassi
Mirabassi non si limita a suonare il clarinetto, piuttosto lo interroga e lo piega alle esigenze espressive di un discorso musicale che si nutre di contaminazioni, ma che rifugge ogni sincretismo superficiale. La ricerca sulla musica strumentale brasiliana e sudamericana, condotta con rigore quasi etno-musicologico, si traduce in progetti che restituiscono la complessità ritmica e melodica di quei repertori con una grazia che è frutto di studio, empatia ed immersione culturale autentica.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Gabriele Mirabassi, nato a Perugia nel 1967, incarna una figura di rara ecletticità artistica ed intellettuale Diplomatosi in clarinetto presso il Conservatorio Francesco Morlacchi della sua città natale, ha intrapreso un percorso che trascende le convenzioni stilistiche, abbracciando con pari rigore e sensibilità tanto la musica colta quanto le espressioni più vitali del jazz e della tradizione popolare brasiliana e latino-americana.
La sua cifra interpretativa si distingue per una padronanza tecnica che non si piega mai all’esibizionismo, ma si mette al servizio di un pensiero musicale coerente, stratificato e raffinatamente lirico. Mirabassi non si limita a suonare il clarinetto, ma lo interroga e lo piega alle esigenze espressive di un discorso musicale che si nutre di contaminazioni, ma che rifugge ogni sincretismo superficiale. La ricerca sulla musica strumentale brasiliana e sudamericana, condotta con rigore quasi etno-musicologico, si traduce in progetti che restituiscono la complessità ritmica e melodica di quei repertori con una grazia che è frutto di studio, empatia ed immersione culturale autentica. Nel corso della sua carriera, ha intavolato relazioni ed interscambi sonori con figure eminenti della musica internazionale, tra cui Richard Galliano, Enrico Pieranunzi, John Taylor, Steve Swallow, Stefano Bollani, Rabih Abou-Khalil e Edmar Castañeda, solo per citarne alcuni. Queste collaborazioni non sono mai esercizi di stile, ma veri e propri laboratori di pensiero musicale, in cui Mirabassi si pone come interlocutore paritario, capace di arricchire il contesto, lasciandosi permeare. La sua attività non si esaurisce nell’ambito concertistico. Il musicista umbro ha partecipato a progetti teatrali, coreutici e di canzone d’autore, collaborando con personalità, quali Gianmaria Testa, Erri De Luca, Ivano Fossati, Mina e Marco Paolini. In tali contesti, il suo clarinetto diventa voce narrante, strumento drammaturgico, presenza poetica che discorre con la parola e il gesto. Mirabassi di distingue anche in qualità di autore e leader di progetti discografici di notevole rilevanza, tra cui il trio «Canto di ebano», premiato con il prestigioso riconoscimento della critica Arrigo Polillo come miglior disco dell’anno nel 2008. La sua discografia, ampia ed articolata, testimonia una visione musicale che non conosce confini, ma si fonda su un’effettiva coerenza estetica e su un’etica dell’ascolto e della relazione, sino a giungere alle pubblicazioni più recenti – «Un ballo con la luna», realizzato insieme a Simone Zanchini, e «Verso Sud», con la partecipazione di Nando di Modugno – entrambe presenti nel prestigioso catalogo della Egea Records.
Gabriele Mirabassi, pur radicato in una formazione classica europea e foriero di una sensibilità melodica profondamente italiana, ha saputo dialogare con modelli americani e afroamericani in modo non imitativo, ma riflessivo e trasfigurato. Il suo approccio al jazz non si fonda su una mera adesione ai canoni bebop o post-bop, bensì su una rielaborazione personale delle strutture armoniche e ritmiche che caratterizzano la tradizione afrologica, filtrate attraverso una lente lirica e cameristica. Tra i riferimenti impliciti nel suo linguaggio si possono riconoscere le influenze di clarinettisti come Benny Goodman e Jimmy Giuffre, ma soprattutto di espressioni più moderne come Don Byron, la cui versatilità ed apertura stilistica sembrano risuonare nell’eclettismo di Mirabassi. Tuttavia, laddove Byron sonda con spirito decostruttivo le radici afroamericane del clarinetto, Mirabassi tende ad una sintesi più narrativa, in cui la cantabilità mediterranea si fonde con la libertà improvvisativa del jazz. Sul piano armonico, Mirabassi si distanzia dalla verticalità tipica del jazz statunitense, prediligendo una scrittura più orizzontale, spesso modale, che richiama la prassi compositiva della musica colta del Novecento europeo. Le progressioni armoniche non sono mai esibite come strutture rigide, ma si sviluppano alla stregua di paesaggi sonori, in cui la tensione e la risoluzione convivono con una fluidità quasi debussyana. In termini ritmici, l’influenza afro-americana si manifesta soprattutto nella sua attenzione per la pulsazione interna del fraseggio, per il senso del groove e per l’interazione con la sezione ritmica. Tuttavia, il clarinettista perugino evita la reiterazione dei cliché swing o funk, preferendo una ritmica più sfumata, spesso ispirata alle metriche complesse delle musiche brasiliane e andine, che egli ha studiato con rigore e passione. Il rapporto di Mirabassi con i modelli americani e afro-americani non è di derivazione, ma di confronto. Egli non si pone come epigono, ma quale interlocutore assorbe, trasforma e restituisce un linguaggio che risulta al tempo stesso rispettoso delle origini e radicalmente personale. La sua musica appare come un luogo di incontro tra mondi, dove le differenze stilistiche si dissolvono in una visione armonica e poetica che trascende le appartenenze.
Come già accennato, esistono diversi musicisti europei con cui Gabriele Mirabassi ha instaurato un interscambio artistico profondo, fondato su una consonanza estetica e una visione musicale affine. Tra questi, spiccano figure come Louis Sclavis, Michel Portal e Gianluigi Trovesi, con i quali condivide non tanto un linguaggio comune, quanto una tensione verso una musica che sappia coniugare rigore formale e libertà espressiva. Con Louis Sclavis, ad esempio, Mirabassi condivide l’interesse per una scrittura che si nutre di elementi extramusicali, quasi letterari e che esplora le potenzialità timbriche del clarinetto in contesti che vanno oltre il jazz convenzionale. Tuttavia, mentre Sclavis tende ad una sperimentazione più astratta e talvolta ruvida, Mirabassi predilige una linea melodica più fluida, una cantabilità che si avvicina alla tradizione lirica italiana. Michel Portal, maestro francese del clarinetto e del sax, rappresenta un altro punto di riferimento implicito. Portal ha saputo attraversare con disinvoltura la musica classica, il jazz e la contemporanea ed, in tal senso, anticipa quella versatilità che Mirabassi ha fatto propria. Entrambi condividono una visione del clarinetto come strumento «trasversale», capace di adattarsi a contesti diversi senza perdere identità. Gianluigi Trovesi, infine, è forse il più vicino a Mirabassi per sensibilità mediterranea e per l’attenzione alle radici popolari. Trovesi ha sempre manifestato l’attitudine a fondere la musica colta con le tradizioni orali dell’Italia settentrionale, mentre il suo approccio narrativo ed ironico trova un’eco nel fraseggio poetico e malinconico di Mirabassi. Entrambi sembrano cercare nella musica non solo una forma, ma una voce che racconti, che evochi, che emozioni. In tutti questi casi, la «compliance» non appare mai imitazione, ma convergenza, ossia una comunanza di intenti, una tensione condivisa verso una musica che sia al tempo stesso sofisticata ed accessibile, radicata ed aperta, intima ed universale. Mirabassi agisce in questo spazio con grazia ed intelligenza, costruendo ponti sonori che uniscono le rive dell’Europa musicale con quelle del mondo.

La relazione di Gabriele Mirabassi con la cultura brasiliana e latino-americana non costituisce un semplice esercizio di stile né una fascinazione esotica, ma un autentico processo di immersione, comprensione e trasfigurazione musicale. Il clarinettista umbro ha scelto di instaurare con queste tradizioni una dinamica dialogica fondata su rispetto, studio ed una sensibilità che travalica i confini geografici e stilistici. Mirabassi si è avvicinato alla musica brasiliana con un atteggiamento quasi filologico, esplorando generi come lo choro, il samba, la bossa nova e la milonga non come repertori da citare, ma quali lingue da abitare. Il suo clarinetto si fa voce transculturale, in grado di passare da un quartetto d’archi europeo ad una roda carioca senza perdere identità, ma piuttosto arricchendosi di nuove sfumature timbriche e ritmiche. Questa relazione ha trovato forma e sostanza in talune collaborazioni significative, come quella con Clarice Assad, pianista e cantante brasiliana, figlia del celebre chitarrista Sergio Assad, con cui Mirabassi ha inciso e condiviso il palco in progetti che celebrano una forma di sonorità senza confini. La loro intesa musicale si fonda su una visione comune, ossia lo scibile musicale come spazio di incontro, contaminazione e narrazione. La cultura latino-americana, ed in particolare quella colombiana, ha ispirato lavori come «Verso Sud», dove Mirabassi incontra la cantabilità operistica italiana con il sincretismo ritmico e melodico del Sud America. In tale contesto, il clarinetto diventa strumento poetico, capace di raccontare storie che attraversano oceani e secoli, fondendo la memoria lirica europea con la vitalità pulsante delle Americhe. Non si tratta di una semplice appropriazione stilistica, ma di una riconciliazione estetica: Mirabassi non «suona latino-americano», ma traduce in musica un’esperienza di ascolto, di viaggio e di relazione. Il suo fraseggio conserva l’eco di un’aria pucciniana, ma si piega con naturalezza alle metriche complesse del joropo, del bolero, del fado, in un continuo gioco di specchi tra scrittura e oralità, tra rigore ed improvvisazione. In sintesi, la relazione di musicista perugino con la cultura brasiliana e latinoamericana è quella di un artista che ha scelto di ascoltare prima di parlare, di comprendere prima di interpretare. Il risultato si concretizza sulla scorta di un sound che non cerca l’effetto, ma la verità: una verità fatta di suoni, di silenzi e di gesti condivisi. Una musica che non si impone, ma si offre.
Un itinerario sonoro attraverso cinque opere emblematiche di Gabriele Mirabassi, collegate da un filo sottile che annoda ambientazioni armoniche raffinate e stati emotivi profondamente evocativi. Ogni disco rappresenta la tappa di un viaggio interiore, dove il clarinetto diventa voce narrante, strumento di introspezione e di dialogo. «Fiabe» (1995, con Stefano Battaglia) si dipana tra il sogno e la contemplazione, optando per strutture armoniche sospese e modali, che evocano paesaggi interiori più che progressioni funzionali. Il pianoforte di Battaglia ed il clarinetto di Mirabassi si rincorrono in un gioco di chiaroscuri, dove l’emozione non è mai esibita, ma suggerita. Il disco costituisce un esempio di lirismo rarefatto, dove ogni nota sembra cercare il silenzio da cui proviene. «Come una volta» (1996, con Coscia, Lena, Pietropaoli) propone una scrittura più discorsiva, con armonie che richiamano la tradizione italica, ma filtrate da una sensibilità jazzistica. «Come una volta» si attesta come un album che respira nostalgia ed ironia, con un uso sapiente delle cadenze tonali e delle modulazioni che sostengono un racconto musicale intimo e collettivo. L’emotività è quella della memoria, dell’oralità tramandata, della piazza e del teatro. In «Graffiando vento» (2004), nato dall’incontro con il chitarrista brasiliano Guinga, il clarinettista indaga le armonie complesse e sensuali della musica brasiliana. Le progressioni sono ricche di sovratoni e cromatismi, ma sempre al servizio di una melodia che vibra di malinconia e desiderio. «Graffiando vento» si caratterizza come un disco che canta l’amore e la perdita, con una delicatezza che sfiora la saudade senza mai indulgere nel sentimentalismo. «Canto di ebano» (2008, con Alfonsi, Maiore, Kramer) rappresenta l’opera della maturità, sulla scorta di un manifesto poetico e tecnico. Le strutture accordali sono stratificate, con un uso raffinato della polifonia e delle tensioni modali. Il clarinetto si districa con eleganza tra episodi lirici e momenti di virtuosismo controllato. L’emozione è quella della bellezza pura, della forma che si fa sostanza, del suono che diventa pensiero. «Amori sospesi» (2015, con Di Modugno e Balducci) si sostanzia come un disco che esplora l’ambivalenza affettiva, tra attesa e compimento. Le armonie si fanno più intime, quasi cameristiche, con un uso del contrappunto che sottolinea la fragilità e la tensione emotiva. «Amori sospesi» mette in scena un’opera che parla di relazioni, di distanze e di prossimità, con una scrittura musicale che riflette la complessità dei legami umani. Questi cinque dischi che non sono semplici tappe discografiche, ma capitoli di un racconto coerente, dove la ricerca armonica s’imbatte in una poetica dell’emozione. Mirabassi non costruisce solo musica, ma scolpisce stati d’animo, disegna scenari interiori, e ci invita ad ascoltare non solo con l’orecchio, ma anche con la memoria ed il cuore. In definitiva, Gabriele Mirabassi non è soltanto un clarinettista di straordinario talento, ma un pensatore musicale, un artigiano del suono ed un intellettuale del timbro. Il suo modus operandi si colloca in una dimensione che sfugge alle categorizzazioni, nutrendosi di una tensione costante verso l’autenticità, la bellezza e la verità espressiva.