Umbria Jazz Forever. Carlo Pagnotta: artigiano del jazz, custode di una passione
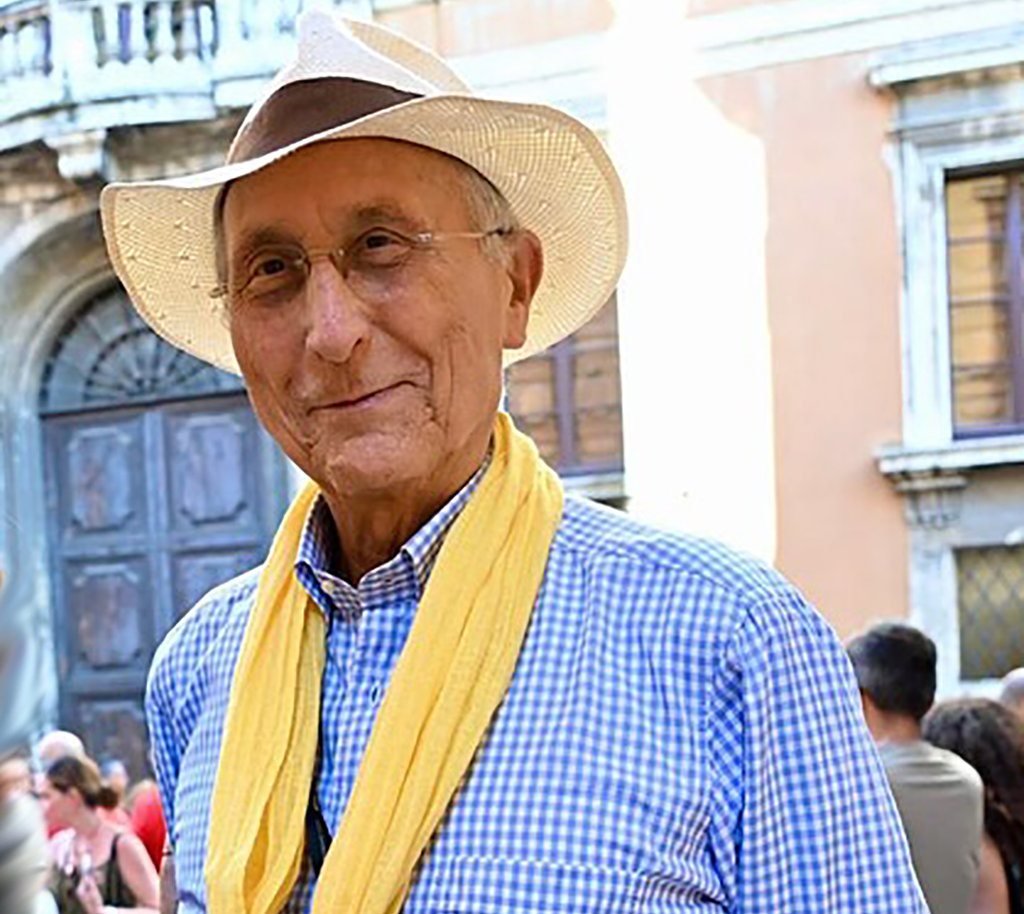
Carlo Pagnotta
Umbria Jazz resta legata ad una dimensione urbanistica e paesaggistica unica, quella di Perugia e delle città umbre. Tale ambientazione ha trasformato il festival in una forma di turismo culturale integrato, dove musica e contesto si fondono in un’esperienza estetica totale che ha fatto scuola. Non tutti i festival europei sono riusciti e riescono in questo.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Nel panorama europeo del jazz, dominato da grandi eventi sponsorizzati, fondazioni internazionali e manager dalle competenze globali, la figura di Carlo Pagnotta rappresenta una singolarità affascinante: un autodidatta, un commerciante di provincia, che è riuscito, con ostinazione e intuito, a costruire uno dei più importanti festival jazz del mondo.
Nato a Perugia nel 1935, Pagnotta si avvicina al jazz negli anni Cinquanta, da semplice appassionato. Non suona uno strumento, non ha studi musicali formali, non parla fluentemente l’inglese, ma possiede un orecchio infallibile, un gusto raffinato, e soprattutto una passione totale. Inizia a organizzare concerti per puro entusiasmo, portando a Perugia, ben prima dell’esplosione dei festival, musicisti del calibro di Chet Baker, Sonny Rollins, Ornette Coleman, Dexter Gordon. Queste iniziative precorrono lo spirito che, nel 1973, darà vita a Umbria Jazz: un festival nato dal basso, gratuito, diffuso nelle piazze e nelle strade dell’Umbria, con l’idea radicale di portare il jazz «alla gente». Carlo Pagnotta ha costruito Umbria Jazz (a partire dal 1973) su un equilibrio piuttosto raro: da un lato la valorizzazione del grande jazz afroamericano (pensiamo alla centralità di personaggi come Dexter Gordon, Art Blakey, Miles Davis, Herbie Hancock, e più avanti Wynton Marsalis), dall’altro una progressiva apertura al linguaggio pop-jazz, world e crossover, che lo ha reso un festival «trasversale» rispetto al purismo jazzistico.
Un capitolo fondamentale del percorso di Carlo Pagnotta è il suo rapporto con Alberto Alberti, bolognese, altro gigante della promozione jazzistica in Italia. Meno noto al grande pubblico, Alberti fu negli anni Sessanta e Settanta il principale mediatore italiano tra i jazzisti americani e i circuiti concertistici italiani ed europei. Alberti aveva uno stile complementare a quello di Pagnotta: meno «pubblico», ma incredibilmente efficace nel costruire relazioni personali con artisti come Duke Ellington, Mingus, Bill Evans. I due collaborarono a lungo, con fiducia e stima reciproca. Alberti metteva a disposizione la sua rete di contatti internazionali e la sua esperienza logistica; Pagnotta curava la direzione artistica, con la sua visione musicale. Entrambi condividevano un’idea chiara: il jazz doveva essere riconosciuto come musica alta e come arte. Alberti fu determinante anche nel sostenere le prime edizioni di Umbria Jazz, aiutando Pagnotta ad ottenere i contatti giusti ed i primi grandi nomi in cartellone. La loro collaborazione rappresenta una stagione irripetibile del jazz italiano, fondata su passione autentica, impegno personale, ed un rispetto assoluto per gli artisti afroamericani. I due sodali erano promotori, ma anche ascoltatori instancabili, presenti a ogni concerto, sempre sul campo.
A confronto con Claude Nobs, fondatore del Montreux Jazz Festival nel 1967, la figura di Pagnotta si staglia per la sua artigianalità. Nobs era un promoter convisione industriale e con contatti multinazionali, capace di fare del Montreux un crocevia tra jazz, rock, pop e soul, portando sullo stage artisti del calibro di Miles Davis, Ella Fitzgerald, ma anche Prince, David Bowie, Deep Purple. Il suo modello era quello del grande evento internazionale, con forti sponsorizzazioni, prestigio mediatico ed una vocazione ibrida e spettacolare. Pagnotta ha invece mantenuto una coerenza musicale ferrea. Per molti anni ha rifiutato le contaminazioni con il pop più commerciale, difendendo la centralità del jazz afroamericano: hard bop, swing, cool, free, in tutte le sue declinazioni. Dove Nobs era impresario, Pagnotta è stato custode; dove Montreux guardava al glamour, Umbria Jazz mirava alla qualità ed alla profondità artistica. Eppure, pur nella diversità dei metodi, entrambi hanno avuto un merito comune, ossia rendere il jazz un fatto culturale nazionale, portarlo fuori dai circoli chiusi degli intenditori e farne un’esperienza di massa. Se oggi in Europa il jazz possiede uno spazio riconosciuto nelle politiche culturali e nel turismo musicale, lo si deve anche a figure come queste.
La relazione tra Umbria Jazz (e la visione di Carlo Pagnotta) ed il Newport Jazz Festival, fondato nel 1954 da George Wein negli Stati Uniti, appare storicamente rilevante, non tanto per un legame formale o istituzionale, quanto per un’affinità culturale e simbolica. Pagnotta ha più volte citato George Wein come una figura di riferimento. Wein non era solo un impresario, ma un mediatore culturale capace di portare il jazz fuori dai club e dai circuiti elitari, rendendolo un evento pubblico, sociale e persino politico. Il Newport Jazz Festival nacque proprio con questa intenzione: fare del jazz un grande rito collettivo, all’aperto, accessibile, senza rinunciare al rigore artistico. Pagnotta ha seguito un percorso simile, adattandolo al contesto italiano: ha portato il jazz nelle piazze e nei teatri storici di Perugia, lo ha legato all’identità di un territorio e lo ha presentato a un pubblico ampio, trasversale, rendendolo esperienza culturale condivisa. Si può dire, quindi, che Umbria Jazz sia in un certo senso «figlio europeo» di Newport, o quanto meno un suo omologo mediterraneo. Sia Wein che Pagnotta hanno costruito i loro festival secondo una logica curatoriale non settaria. Ambedue sono stati capaci di valorizzare il grande jazz afroamericano (pensiamo alle leggendarie esibizioni di Ellington, Miles Davis, Monk a Newport; oppure a quelle di Mingus, Marsalis, Hancock a Perugia), aprendosi anche alle contaminazioni blues, soul, gospel, world music, funk e persino pop colto. In tal senso i due festival hanno costruito un mainstream di qualità, evitando da un lato il purismo accademico, dall’altro lo svuotamento commerciale. Molte delle loro scelte hanno generato critiche ma anche entusiasmo, mantenendo sempre la centralità del jazz come codice linguistico e identità culturale.
Il Newport Jazz Festival fu uno dei primi a proporre il jazz come evento pubblico all’aperto, con un forte carattere sociale e democratico, ossia il jazz non solo nei club, ma nei parchi, nei teatri, per il popolo. Umbria Jazz ha raccolto questa intuizione, inserendola in uno spazio urbano storico come quello di Perugia. In entrambi i casi, il festival ha funzionato come una forma di cittadinanza attiva, creando legami tra musica, memoria e comunità. Newport ha contribuito a cambiare la percezione del jazz negli USA; Umbria Jazz ha fatto lo stesso in Italia, portando generazioni intere a scoprire una musica troppo spesso marginalizzata. Newport nasce nel cuore degli Stati Uniti, in un paese che ha prodotto il jazz come forma espressiva della sua storia sociale e razziale. Umbria Jazz vede la luce invece in Italia, dove il jazz rappresenta una musica importata e, se prodotta in loco, derivativa, da capire, assimilare ed interpretare. Questo rende l’operato di Pagnotta ancora più significativo. Egli è stato in grado tradurre un linguaggio «straniero» in una grammatica locale. Il pubblico di Newport, almeno all’inizio, era diviso tra élite bianca progressista ed appassionati afroamericani; Umbria Jazz, per sua natura, ha avuto sin da subito un pubblico più misto e politicamente meno polarizzato. Tuttavia, entrambi i festival hanno funzionato come luoghi di mediazione culturale e confronto. Dopo la scomparsa di George Wein (2021), molti hanno visto in Umbria Jazz una delle realtà europee più recettiva a raccoglierne lo spirito, ossia un tipo di festival che unisce arte e accessibilità, qualità e coinvolgimento, passato e futuro. Pagnotta, come Wein, non è semplicemente un organizzatore, ma un testimone, un costruttore di senso, un ponte tra mondi diversi. E proprio come Wein a Newport, Pagnotta a Perugia ha fatto sì che il jazz non fosse solo musica, ma memoria, territorio ed educazione civile.
North Sea Jazz Festival (Olanda) o Vienne Jazz (Francia) hanno mantenuto un’impronta più specialistica, con programmazioni ampie ma più internalmente coerenti, rivolte ad un pubblico conoscitore. Pagnotta, pur appassionato cultore del jazz storico (la sua collezione di dischi e il rapporto personale con figure come Chet Baker o Mingus ne sono testimonianza), ha saputo interpretare le esigenze dello spettacolo dal vivo nel contesto italiano, privilegiando un’idea di evento attrattivo, popolare nel senso alto del termine, senza però ridursi a semplice vetrina commerciale. A differenza di molti festival del Nord Europa, spesso nati in contesti urbani ad alta densità culturale e sostenuti da solide reti istituzionali, Umbria Jazz resta legata ad una dimensione urbanistica e paesaggistica unica, quella di Perugia e delle città umbre. Tale ambientazione ha trasformato il festival in una forma di turismo culturale integrato, dove musica e contesto si fondono in un’esperienza estetica totale che ha fatto scuola. Non tutti i festival europei sono riusciti in questo. In Francia, ad esempio, Vienne Jazz o Jazz à Juan godono di un forte radicamento territoriale, ma raramente sono in grado di offrire la medesima immersività architettonica e paesaggistica. Montreux, certo, ha il lago e l’effetto «cartolina», ma Umbria Jazz ha l’intreccio medievale, ed un fitta stratificazione fra storia, arte e musica.
Nei festival di area nordica, come Molde (Norvegia), Pori (Finlandia), Copenhagen Jazz Festival, si percepisce una diversa concezione curatoriale: molta attenzione ai nuovi linguaggi, all’improvvisazione radicale, alle istanze politiche e sociali, ai progetti site-specific. Sono festival spesso «militanti» nel senso culturale del termine. Pagnotta ha invece fatto di Umbria Jazz un luogo dell’incontro intergenerazionale e interstilistico, meno incline alla sperimentazione estrema, ma più attento alla dimensione spettacolare del jazz. Ciò non implica mancanza di profondità, significa piuttosto concepire la manifestazione come spazio, dove la musica «nera» dialoga con il presente, anche attraverso il filtro del grande palco e della narrazione mediatica. Umbria Jazz non si è mai proposta come festival «accademico», né ha rincorso le mode del Nord Europa o l’eclettismo totale del modello Montreux. Per contro, ha costruito un’identità autonoma, radicata nella tradizione afro-americana, ma capace di accogliere le contaminazioni (da Gilberto Gil a Caetano Veloso, da Pat Metheny ai progetti gospel o soul) senza perdere riconoscibilità. La sua forza sta nel riuscire a coniugare cultura alta e partecipazione popolare, rigore artistico e grande evento, mantenendo sempre un legame forte con la dimensione territoriale e civile. Ecco perché Umbria Jazz, al pari dei suoi «fratelli» europei, non è solo un festival, ma rappresenta una forma di diplomazia culturale, un laboratorio di cittadinanza musicale.
Pagnotta oggi è una leggenda vivente. A più di 90 anni, continua a scegliere i nomi per Umbria Jazz, con una lucidità impressionante e una coerenza non comune. Nel tempo ha anche saputo adattarsi, tanto che il festival ha integrato generi limitrofi, aprendosi al latin jazz, alla world music, talvolta al pop-rock, senza mai snaturare la sua vocazione originaria. La lunga militanza, del novantenne direttore artistico, nel nome del jazz, è diventata progressivamente oggetto di studi, biografie, e documentari. Umbria Jazz ha finito così col divenire un’istituzione culturale, un laboratorio permanente di incontro fra tradizione ed innovazione, tra il jazz americano e la scena europea, tra le voci del passato e le nuove generazioni. Senza tralasciare che tutto ciò nasce dalla visione di un uomo che, da Perugia, ha saputo guardare al mondo con estrema lungimiranza.






