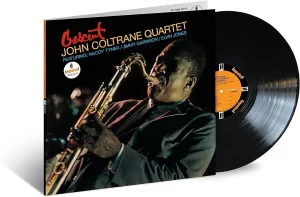Darius Milhaud: «Création du monde», jazz ed esotismo

Darius Milhaud
// di Guido Michelone//
In questo capitolo si parla di Darius Milhaud – nato a Marsiglia il 4 settembre 1892 e morto a Ginevra il 22 giugno 1974 – il quale oltre essere un grandissimo compositore (membro del celebre Gruppo dei Sei a Parigi) risulta forse il musicista con il maggior numero di allievi che nel corso dei decenni diverranno altrettanti noti compositori, autentici maestri della classica contemporanea quali Pierre Max Dubois, Philip Glass, György Kurtág, Eugene Kurtz, Steve Reich, Karlheinz Stockhausen, Morton Subotnick, Iannis Xenakis, due jazzmen come Dave Brubeck e Pete Rugolo, nonché il genio dei songwriter del secondo Novecento Burt Bacharach. Partendo da uno dei capolavori di Milhaud, La Création du monde (1922-1923) si arriva a discutere di jazz e di esotismo, due tratti caratterizzanti molto la classica contemporanea dei primi decenni del XX secolo, benché il gusto dell’esotico risalga ad almeno due secoli prima nel mondo delle sette note occidentali. La Creazione del mondo èun balletto, su soggetto del poeta Blaise Cendrars, il quale dipinge appunto la propria genesi secondo un mito africano in cui a sua volta viene descritto il caos prima dell’universo, della Terra, degli animali, della vegetazione, della nascita di uomo e donna e infine del primo bacio fra questi ultimi due. La partitura è consapevolmente stimolata dai ritmi jazz e caraibici che Darius ama tanto dopo un iniziale ascolto a Londra e quindi ad Harlem: egli quindi inserisci una fuga hot jazz (nel secondo movimento), un cakewalk e diverse modulazioni d’ispirazione blues. Persino l’organico strumentale riflette la musica del Nuovo Mondo, perché, oltre optare per soli diciassette strumentisti classici, aggiunge pure un sax contralto, un pianoforte e una batteria, gesto davvero insolito per una formazione dotta.
Milhaud, insomma, manifesta anche la poetica del Gruppo dei Sei, in riferimento alla musica popolare urbana delle sale da ballo prontissime, in Europa, ad accogliere tanto il modernismo del dixieland quanto la passione per l’esotico, con la scoperta ad esempio, tra i pittori, cubisti in particolare dell’antica scultura africana; alla fine l’esito de La Création du monde è un pezzo fresco, originale, accessibile a tutti nonostante le strutture molto rigorose sotto gli aspetti della forma, dell’armonia, del ritmo; e l’esotico afroamericano resta ancor oggi evidente ad esempio in taluni effetti strumentali da orchestrina jazz accanto ai glissandi del trombone, al flutter-tonguing del flauto, al pizzicato del contrabbasso. Anni dopo Darius arrangerà il brano anche per pianoforte e per quartetto d’archi. Prima di Milhaud, l’esotismo (con l’orientalismo) è constatabile in molte partiture di insegni compositori – da metà/fine Ottocento con George Bizet, Léo Delibes, Jules Massenet, Jacques Offenbach, Camille Saint-Saëns e nel primo Novecento Claude Debussy e Maurice Ravel – per assolvere pure un ulteriore compito di spettacolo e comunicazione: accontentare il grosso pubblico che nell’opera parigina cerca evasione, passione, emozione, attenzione. E i compositori intuiscono che il primo o principale espediente per assicurare il ‘divertimento’ consiste nella location esotica in cui si dipanano vicende altrettanto lontane da ciò che viene ritenuto il comune sentire.
L’esotismo in musica serve altresì a trasporre nello spazio e nel tempo soggetti ritenuti dalla classe borghese sin troppo erotici, morbosi o piccanti se inscenati con i panni dell’attualità: ed ecco che la passione sfrenata tra la gitana e Don José nella Carmen (1875) è accettata dagli spettatori francesi solo perché ambientata dalla rude Spagna di mezzo secolo prima. Tuttavia lo stesso Bizet nel 1860 compone un Vasco de Gama dove la glorificazione del grande esploratore arriva nel periodo del consolidamento del dominio coloniale francese. Forse però fanno maggior furore i racconti di avventure in giro per il mondo come il classico romanzo Robison Crusoe che diventa melodramma esattamente dopo un secolo e mezzo (1867) grazie a Offenbach, mentre il più moderno e recente Rarahu (1880) di Pierre Loti offre lo spunto a Delibes, due anni dopo, per il capolavoro lirico Lakmé, dove si osa persino immaginare passioni amorose tra persone con pelle di diverso colore, essendo una storia trasferita in terre lontane, così come un soggetto analogo – La Créole del citato Offenbach – è risolta nel passato onde evitare le ingiurie da parte dei razzisti. Pochi infine i compositori in grado di viaggiare per il mondo a causa dei troppi impegni o dei costi elevati: chi lo fa, come Saint-Saëns o Félicien David – autori rispettivamente di El Desdichado e di Lalla-Roukh – annoterà sui propri taccuini o su carta pentagrammata melodie o ritmi che arricchiranno le partiture di un esotico brillante o brillantissimo nei ‘mondi riflessi’.

Passando quindi alla prima metà del Novecento, l’emergere di un ulteriore esotismo viene oggi indicato da alcuni storici mediante l’ingresso del jazz in Francia e l’impiego di formule jazzistiche nella musica colta: e in tal senso jazzistes e compositeurs vengono spesso accostati in un ampio rapporto e in un’estesa fascinazione verso l’Altro e l’altrove. Impiegata in questo modo, la categoria dell’esotico tende a mascherare le concrete divergenze nel recepire il vero jazz nella musica francese del primo Novecento (più o meno sino all’arrivo del Quintette du Hot Club de France con Django Reinhardt e Stéphane Grappelli). Per evidenziare questa diversità, Martin Guerpin nel saggio L’exotisme en question. Le cas de la réception du jazz dans la musique savante française de l’entre-deux-guerres («Revue musicale OICRM», marzo 2016) analizzale partiture di Darius Milhaud e Jean Wiéner ‘jazz influenced’ in base alle proposte e ai concetti di esotico in vigore negli anni Venti e Trenta, tenendo conto delle fonti musicali utilizzate dai compositori nonché le connotazioni indirette e gli elementi extra-musicali che comunicano al pubblico. Una volta riconsiderata la valenza eterogenea dello stesso ‘esotico in musica’, Guerpin riesce a proporre, in ambito accademico una distinzione, nei lavori colti influenzati dal jazz, tra quelli facenti parte di un cosiddetto ‘exotisme nègre’ e gli altri che impiegano questa musica solo nel quadro di un’esplorazione di nuovi processi musicali.
Di recente, nel dicembre 2022 un altro saggio Theorizing the Orient: Orientalism and Its Synthesis with Opera, Jazz and Improvisation(IOSR Journal Of Humanities And Social Science) di Praveen Toppo (professore all’Università di Chhattisgarh in India) analizzando sempre la ricezione del jazz nella Francia del primo Novecento, quasi in un passaggio di consegne tra il melodramma esotico e nuove forme comunicative a livello sonoro, lancia una tesi provocatoria, sostenendo che non tutti i musicisti e gli intellettuali parigini che accolgono l’hot jazz a braccia aperte, gli rendono un buon servizio dal punto di vista dell’emancipazione artistica. La Francia, come si sa, da sempre ritenuta la Nazione che più d’ogni altra (molto meglio degli stessi Stati Uniti per esempio), contribuisce alla valorizzazione del sound di Louis Armstrong o Duke Ellington in chiave artistico-culturale, ma stando alle ricerche di Guerpin e Toppo, tende ancora a offrire una visione esotica dei ritmi sincopati provenienti dal Nord America.
La disamina di Toppo dimostra come le recenti discussioni musicologiche sui temi dell’esotico o dell’orientalismo mutino significativamente il profilo disciplinare della stessa musicologia verso qualcosa di interdisciplinare; e in tal senso lo studioso indiano fornisce anche un’efficace panoramica della storia del concetto di orientalismo nel campo della recente musicologia, che, a sua volta, riconosce il terreno degli studi postcoloniali quale potenziale punto di partenza per lo sviluppo di nuove teorie sulle connessioni tra musica, razza, alterità etnica e colonialismo europeo. Rifacendosi altresì a un precedente studio dell’allora giovane ricercatore Andy Fry – oggi docente al londinese King’s College – Beyond Le Boeuf: Interdisciplinary Rereadings of Jazz in France (Journal Royal Musical Association, 128, 2003), Toppo riporta l’idea del jazz dei francesi come ‘un vestigio di barbarie’ propenso a ‘spodestare la ragione e liberare la passione’; assolo, improvvisazioni, gesti e soprattutto danze apertamente sensuali, nelle performance di jazzisti sia bianchi sia bianchi, affascinano in quanto percepiscono la ‘mancanza di controllo e di pensiero razionale che minava le premesse fondamentali della civiltà occidentale’. La popolarità del jazz tra il pubblico europeo aumenta anche come risposta alle condanne della stampa che lo definiscono musica brutale in quanto segno evidente di collasso sociale.
“Suonando i tamburi, suonando le campane e gridando con tutte le loro forze contro la prima guerra mondiale e la mentalità ‘civilizzata’ che ne ritenevano responsabile”: il movimento Dada usa il jazz con effetti controculturali, mentre con il nascente Surrealismo è il carattere selvaggio a incuriosire pittori e letterati, i quali pensano che i jazzmen accedano al subconscio o persino allo spirituale, condividendo nozioni centrali a entrambe le arti; parimenti sedotti dalla scrittura automatica all’entrata in trance, i Surrealisti ancorano ai musicisti afroamericani i miti primitivisti come lo sciamanesimo, ovviamente esagerando per godersi gli elementi antiautoritari eselvaggi della musica come forma di fuga o di liberazione. E per Toppo e Fry gli esiti in chiave jazz più felici e al contempo deformati arrivano dalla collaborazione tra il poeta Jean Cocteau e il musicista Darius Milhaud, in particolare nel balletto La Création du monde (1923) citato all’inizio.