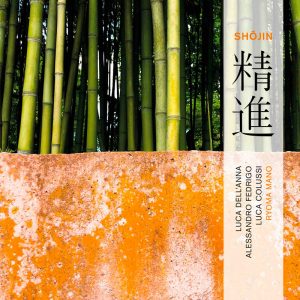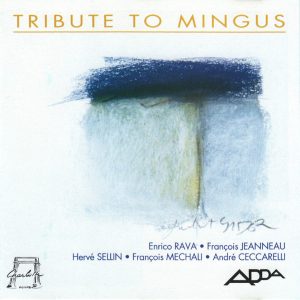Yvetta Kajanová musicologa: l’innovazione risiede nel combinare la tradizionale analisi dell’armonia e della melodia

Yvetta Kajanová
// di Guido Michelone //
Della slovacca Yvetta Kajanová si comincia a parlare in Italia dal giugno 2022, da quando esce per l’editore Mimesis il suo poderoso volume Musica rock dall’eloquente sottotitolo Suono, ritmo, affetto e l’invenzione della chitarra elettrica: un libro è quasi passato sotto silenzio, forse per la complessità delle analisi e dei discorsi contenuti che la critica pop tricolore, perlopiù legata a un giornalismo superficiale, forse non è nemmeno in grado di comprendere o decifrare. Stato di fatto però cha da Luca Cerchiari a Fernando Fera l’apprezzamento dl lavoro di Yvetta è costante, così come anche quest’intervistare dovrebbe aiutare a farla maggiormente conoscere tra i comuni ascoltatori di rock e di jazz, visto che le sue teorie risultano facilmente applicabili da chi vuole trarre ulteriori vantaggi estetico-culturali dalla fruizione delle musiche-chiave della contemporaneità.
Del resto sarebbe strano il contrario, dato che la Kajanová (classe 1964) vanta un curriculum di tutto rispetto: è professoressa di musicologia all’Università Comenius di Bratislava (Slovacchia), dove tiene lezioni di storia del jazz e del rock, di critica musicale, di sociologia e gestione della musica. Come studiosa partecipa a conferenze internazionali a Vienna, Praga, Ratisbona, Berlino, Budapest, Varsavia, Cracovia, Londra, Porto, Graz, Marburgo, Amsterdam e Milano, ed è autrice di numerose monografie sull’estetica e sulla sociologia della musica, sul jazz, sul rock, sul pop e sul gospel: tra il 2014 e il 2024 infatti pubblica On the History of Rock Music, Jazz fromSocialist Realism to Postmodernism, Popular Music in Communist and Post-Communist Europe, Ubuntu Fusion Music; in passato è membro del gruppo di ricerca internazionale Jazz nel blocco orientale della Freie Universität di Berlino.
Il suo libro Sulla storia della musica rock (2014) è stato pubblicato dall’editore accademico Peter Lang. Alcuni dei suoi lavori recenti includono i contributi a Jazz from Socialist Realism to Postmodernism 5 (Francoforte sul Meno, Peter Lang 2016) di Kajanová/Pickhan/Ritter, a Popular Music in Comunist and Post-Communist Europe 6 (Berlino, Peter Lang 2019) di Blüml/Kajanová/Ritter e a Ubuntu Fusion Music 11 (Berlino, Peter Lang 2024) di Kajanová. Tra il 2008 e il 2010, la Prof.ssa Kajanová è stata membro del gruppo di ricerca internazionale Jazz in the Eastern Blockdella Freie Universität di Berlino. Ha tenuto conferenze a Praga, Olomouc, Brno, Plzeň, Cracovia e Milano.
Prima dell’intervista vorrei iniziare con una memoria personale. Ho ancora un ricordo molto forte del rock e del jazz in Cecoslovacchia: prima di visitare Praga nel 1976 (un anno prima di Charta 77), lessi che la Cecoslovacchia era nel 1967 la capitale della musica beat nell’Est Europa come lo l’Inghilterra nel mondo. Poi arrivarono i carri armati sovietici e il sogno di Dubcek e dei giovani cecoslovacchi furono annientati nel sangue. Anche quando ho visitato Praga la scena rock e jazz era molto vivace: c’erano negozietti nel Vicolo d’Oro che, sotto il bancone, vendevano album di artisti rock e jazz. Poi anche questa utopia fu repressa dall’URSS. E sfortunatamente per noi europei occidentali, anche la Cecoslovacchia, dopo il crollo del comunismo si divise: per fortuna in modo pacifico e non come la Jugoslavia. Ma credo che la separazione odierna avvantaggi sia i cechi sia gli slovacchi per svariati motivi in una comune prospettiva europeista.
D In tre parole chi è Yvetta Kajanová?
R Sono musicologa, critico e manager.
D Yvetta, raccontami il primo ricordo che hai della musica?
R Quando mio padre suonava il rock and roll al sassofono. Avevo circa quattro anni.
D Quali sono le ragioni che ti hanno motivato a diventare uno storico del rock, del pop, del jazz?
R La ribellione e l’opposizione hanno sempre fatto parte di questo genere, cosa che mi ha attratto molto, forse a causa della situazione politica nell’ex Cecoslovacchia. Ho incontrato per la prima volta il rhythm and blues quando avevo diciassette anni, suonando il piano in una band locale, anche se avevo studiato musica classica dall’età di nove anni. Ho scoperto il jazz e il rock grazie ad amici più vecchi che suonavano con me. Quando dico “più vecchii” intendo molto più vecchii: Tibor Platzner (1939-2000), artista, pittore e flautista, aveva venticinque anni più di me. Aveva vissuto in prima persona la libertà degli anni Sessanta in Cecoslovacchia. Mentre esploravo il jazz, ho iniziato a provare un senso di libertà, non solo artisticamente ma anche politicamente e spiritualmente. Quando avevo quindici anni ho avuto un’esperienza particolarmente spiacevole con i comunisti. Minacciarono di espellermi dal liceo perché suonavo l’organo in chiesa. I comunisti impegnati credevano che la religione fosse dannosa per i giovani, che dovevano essere orgogliosi delle loro convinzioni atee.
D Qual è il tuo metodo di lavoro e di analisi quando scrivi il libro “Musica Rock” per l’editore italiano Mimesis?
R Ho utilizzato un metodo storico, ovviamente, ma ho anche analizzato schemi ritmici ascoltando la musica e trascrivendo ciò che ho sentito in una partitura musicale. Ho combinato questo approccio con l’analisi statistica, trascrivendo più di 800 esempi su pentagramma e valutandone poi le caratteristiche. Questa analisi mi ha permesso di individuare gli elementi ritmici tipici del jazz e del rock all’interno dei vari stili. Ho applicato lo stesso metodo di ascolto e lettura durante l’analisi delle tecniche vocali nella musica rock, come cantare a squarciagola, cantare a livello forte, urlare e ringhiare. In entrambe le analisi, ho lavorato in ordine cronologico, dal rock and roll fino agli stili contemporanei come metalcore, nu metal e djent. L’analisi degli effetti sonori su chitarra e batteria, come booster, overdrive, distorsione, fuzz, tapping, hammer-on o l’uso di drum pad e pedali per contrabbasso, si è rivelata più impegnativa. Tuttavia, su YouTube sono disponibili esempi video che consentono di confrontare ciò che si sente con il processo visivo e di identificare meglio le tecniche.
D Di quali idee tratte dal tuo libro sei più orgoglioso? E per quali ragioni?
R Ho voluto essere la più esaustiva possibile e spero di essere riuscita a fornire una visione olistica della musica rock da una prospettiva storica. Lo sviluppo del rock non è solo cronologico e lineare, ma anche retrospettivo e stratificato, soprattutto negli ultimi tre decenni. Considero la teoria dei modelli ritmici – in particolare l’idea che questi modelli possano funzionare come archetipi, rappresentando la struttura fondamentale del jazz e del rock – cruciale per l’evoluzione complessiva di questi generi. Sono anche orgogliosa del mio antenato slovacco, John Dopyera, che ha dato un contributo significativo all’innovazione della chitarra. Ha inventato la chitarra resofonica interamente in metallo, la National Tri-Plate Style 1, nel 1926; la chitarra Dobro a cono singolo del 1929; e la chitarra semiacustica Dobro All Electric con pickup nel 1931. La chitarra Dobro All Electric di Dopyera, completa di amplificatore e due altoparlanti, fu esposta nel 1934 negli Stati Uniti. Volevo evidenziare questi fatti storici, poiché a volte vengono trascurati o erroneamente attribuiti ad altri, come Gibson, che introdusse la sua chitarra elettrica nel 1936, o George Beauchamp, che sviluppò la sua chitarra “padella” con un pickup nel 1932.
D Luca Cerchiari ha detto giustamente che il suo libro è molto innovativo sul piano metodologico. Vuoi illustrarci brevemente le novità che avete introdotto?
R Credo che l’innovazione risieda nel combinare la tradizionale analisi dell’armonia e della melodia, tipica della musica classica, con altri approcci. Ho utilizzato anche quell’analisi, ma ho iniziato concentrandomi sul ritmo e sul suono, fondamentali nella musica jazz, rock e pop. Solo dopo ho analizzato gli elementi tipici della musica classica europea: armonia e forma. I punti di forza del rock, del pop e del jazz risiedono nel ritmo, nel suono e nell’evoluzione di varie forme di improvvisazione.
D Quali sono le idee, i concetti o i sentimenti che associ alla musica rock?
R Il rock, per me, rappresenta la ribellione: un approccio diretto e schietto. Non richiede deviazioni né evita problemi; invece, li affronta frontalmente, spesso con un collegamento chiaro e intransigente con le questioni sociali e politiche. Queste erano le mie prime sensazioni nei confronti del rock, ma la vita ti insegna che non è sempre facile mantenere quella posizione. In certe situazioni bisogna essere più diplomatici. Ecco perché amo anche il jazz, poiché offre maggiore flessibilità e, a volte, maggiore raffinatezza. Tuttavia, il rock può anche essere sofisticato. Ad esempio, gruppi come i Tool, con le loro tendenze progressive metal, o gruppi metal alternativi come System of a Down, hanno dimostrato che il rock può essere sia complesso che potente.
D Come definiresti la musica jazz odierna nel contesto globale?
R Non sono sicuro che sia possibile definirlo con precisione, ma posso descrivere una tendenza: una miscela di patrimonio acustico e fusione jazz-rock che ha la capacità di assorbire elementi da un’ampia gamma di fonti. Questi includono la musica etnica tradizionale proveniente da varie parti del mondo, il minimalismo, la musica di Los Angeles, la musica africana, la musica classica, il klezmer, la world music, la musica dance elettronica, il rap e l’hip hop…
D Quali libri sulla storia del rock, del pop, del jazz (scritti da autori inglesi, americani, francesi o italiani) stimi di più?
R Utilizzo ancora Early Jazz: Its Roots and Musical Development (1968) di Gunther Schuller durante le mie lezioni sulla storia del jazz. Jazz Styles (1978) di Mark Gridley offre un approccio innovativo alla comprensione degli stili jazz moderni. Der Jazz. Seine Ursprünge und seine Entwicklung (1956) di Alfons Dauer è stato particolarmente stimolante quando ho ampliato la sua teoria dei ritmi incrociati, “Überrhythmen” (sovraritmi) e “Binnenrhythmen” (ritmi interni), e ho sviluppato le mie idee sulla ritmica archetipa. Anche Das Jazzbuch di Joachim Ernst Berendt (pubblicato per la prima volta nel 1953 e ristampato più volte in seguito) mi ha interessato, soprattutto per la sua discussione su tre aspetti chiave del jazz: improvvisazione, suono e ritmo. Ho continuato da dove si erano interrotte le sue idee. Ho anche fatto molto affidamento sul libro fondamentale Rock of Ages: The Rolling Stone History of Rock and Roll (1986) di Ed Ward, Geoffrey Stokes e Ken Tucker. Studiando Rock of Ages, mi sono resa conto di quanto possa essere difficile distinguere il rock dalla musica pop, soprattutto quando gli autori hanno spiegato lo sviluppo di stili new wave, come quelli dei Talking Heads, di Elvis Costello e dei Police, e la loro fusione con il movimento new romanticc degli Scritti Politti o degli Spandau Ballet.
D Dal tuo libro possiamo dedurre che anche nell’Europa dell’Est, durante e dopo il comunismo, il jazz e il rock hanno avuto un ruolo molto importante. Vuoi spiegarne i motivi?
R Sia il jazz che il rock sono strettamente legati allo stile di vita occidentale e hanno contribuito a plasmare molte sottoculture nell’ex Cecoslovacchia, compresi i movimenti dissidenti. Il jazz ti insegna che la libertà è qualcosa che meriti, perché tutti la meritano. Quando suoni jazz impari a vivere la vita liberamente e con gioia. Il rock, invece, ti dimostra che la libertà è un valore per il quale vale la pena lottare e proteggere, non qualcosa da accettare passivamente.
D Chi sono per te i migliori rocker nella musica slovacca?
R Vorrei anzitutto citare alcuni dei miei musicisti preferiti: la leggenda afroamericana del bebop jazz Thelonious Monk, il chitarrista rock americano Jimi Hendrix e Danny Carey, il batterista dei Tool. Per quanto riguarda i rocker slovacchi, Dežo Ursiny, cantante, chitarrista e compositore; Marián Varga, compositore e organista Hammond noto per il suo rock progressivo; e mi vengono in mente gli eccezionali chitarristi Andrej Šeban e Peter “Peci” Uherčík. Spicca anche Mário “Kully” Kollár, il cantante rock con voce basso-baritono del gruppo Desmod. I gruppi punk e new wave slovacchi come Horkýže Slíže e Chiki Liki Tu-a sono pieni di musicisti di talento, sebbene la loro forza risieda nel loro contributo collettivo alle canzoni. Molto buona anche la band Gladiator, che ha ottenuto un successo internazionale, e da citare tra gli altri gli Hex, noti per le loro canzoni originali.
D Come vedi, in generale, il presente della musica rock, sia a livello degli studi universitari che dell’ascolto giovanile?
R I giovani sono molto interessati alla musica rock, ma gli studi universitari in genere non sono focalizzati su di essa. Le università (o gli studiosi) sono riusciti a incorporare un po’ di storia del jazz, ma ci sono solo poche eccezioni quando si tratta di insegnare il rock. Per quanto ne so, solo un piccolo numero di studiosi può offrire corsi completi sulla musica rock, come un corso di un intero semestre o più, e scavare davvero più in profondità sotto la superficie. Naturalmente, per insegnare la storia del rock in modo efficace, è essenziale avere una profonda conoscenza della storia del jazz e della musica popolare moderna in generale, il che non è un compito facile. Lo studio del jazz e del rock può facilmente diventare travolgente a causa della grande quantità di informazioni disponibili per coloro che desiderano esplorarli seriamente.
D In America c’è ancora la percezione che noi europei diamo troppo valore al jazz e al rock come forme culturali e artistiche e non come puro intrattenimento o spettacolo. Non credi che questo atteggiamento porti la musica americana a decadere e a non esprimere più nulla di nuovo dopo il grunge e l’hip-hop (trent’anni fa)? •
R Non sono sicuro che questo problema derivi esclusivamente dalla percezione del jazz e del rock come puro intrattenimento o forme artistiche, ma ci sono questioni più profonde in gioco. Queste includono l’esaurimento del materiale musicale afroamericano, la ricerca di nuove fonti dalla musica popolare nei diversi continenti e l’espansione multiculturale del jazz e del rock come generi. In definitiva, c’è la richiesta che l’industria musicale si apra ai mercati internazionali in modo che questi generi possano penetrare in altre scene rock “nazionali” su scala globale. Un perfetto esempio di ciò è la band italiana Måneskin. Se ascolti System of a Down, noterai elementi di musica popolare armena; allo stesso modo, la band americana Tool trae ispirazione dalla cultura indiana, e l’uso innovativo del drum pad da parte di Danny Carey è davvero notevole. La band svedese Meshuggah combina la sperimentazione con un forte approccio tecnico al thrash metal, creando un nuovo suono distintivo a volte erroneamente definito djent, o metal tecnico, caratterizzato dall’uso di chitarre a otto corde. I Meshuggah accordano le loro corde più in basso rispetto alla maggior parte dei musicisti, consentendo loro di produrre un suono più pieno con un attacco potente che risuona fin dentro gli ascoltatori. Queste ispirazioni provengono da altri angoli del mondo oltre gli Stati Uniti.
D Nel tuo libro c’è la storia dell’inventore della chitarra elettrica: vuoi parlarcene dal punto di vista musicale?
R Come ho detto prima, il suono della chitarra elettrica a corpo cavo Dobro All Electric, scoperta da John Dopyera, era unico e apriva una nuova dimensione. Quando si confronta il suono della sua chitarra National Tri-Plate interamente in metallo del 1926 con la Dobro All Electric (1931-1934), lanciata sul mercato da Dopyera, è chiaro che sono abbastanza diversi. Questa chitarra elettrica a corpo cavo ha trasformato il mondo del jazz, del blues, del country e, infine, della musica rock. Senza il contributo di John Dopyera, sono sicuro che la musica si sarebbe sviluppata in modo diverso. La chitarra elettrica a corpo cavo del 1931 presentava un pickup costruito da Victor Smith nel laboratorio artigianale di John Dopyera. Un pickup migliorato di Art Stimson portò alla configurazione completa della chitarra elettrica a corpo cavo con amplificatore e altoparlanti, che furono esposte, promosse e distribuite commercialmente da John Dopyera nel 1934. Se ascolti il jazz della prima metà del XX secolo, noterai una mancanza di suono della chitarra. Pionieri della chitarra jazz, come Charlie Christian e Les Paul, hanno contribuito allo sviluppo della chitarra elettrica non solo attraverso il loro modo di suonare, ma anche come inventori dei pickup (Charlie Christian) e del nuovo tipo di chitarra “log” (Les Paul). I musicisti hard rock iniziarono a utilizzare le chitarre elettriche in tre diversi modelli: la Les Paul prodotta dalla Gibson e la Telecaster e la Stratocaster realizzate dalla Fender. Proprio quando sembrava che non ci fossero più innovazioni nei modelli di chitarra, i musicisti rock iniziarono a preferire i modelli firmati, in particolare Telecaster e Stratocaster.
D Qualcosa nella chitarra elettrica è ancora cambiato in questo XXI secolo?
R La nuova era dopo il 2000 ha rivelato come i musicisti rock guardassero indietro ai tipi storici di chitarre, amplificatori e altoparlanti per produrre nuovamente suoni diversi. Ad esempio, nella canzone Seven Nation Army (2003) dei White Stripes, Jack White ha utilizzato una chitarra elettrica Kay Hollow Body vintage degli anni Cinquanta con un ponte a trapezio, e in seguito ha suonato una Red Airline Res-O-Glass del 1964, che può essere vista nel video musicale proprio di Seven Nation Army. Matt Bellamy dei Muse suona una Telecaster prodotta da Manson Guitar Works (prima del 2009), costruita come il suo modello distintivo. Alcune di queste chitarre dispongono anche di uno speciale display MIDI pad (Manson MBM-2) situato direttamente sullo strumento.
D Forse non è un caso che sia la Slovacchia e non l’America a dedicare a John Dopyera mostre e musei, proprio per il discorso precedente sulla leggerezza con cui l’America tratta il proprio passato.
R Ci sono alcune mostre sulle chitarre Dobro al Museo di Trnava e a Bratislava (Slovacchia), che espongono una collezione di strumenti progettati dai fratelli Dopyera. Puoi trovare anche la chitarra Dobro, lo strumento National Tri-Plate e vari tipi di chitarre resofoniche e a corpo cavo con pickup al Museo Nazionale di Storia Americana nello Smithsonian Museum di Washington, D.C., a cui i fratelli Dopyera dedicarono alcune testimonianze con storiche chitarre. Hai ragione nel sostenere che le chitarre elettriche e i loro predecessori non hanno un luogo centralizzato con una collezione completa. Molte chitarre, con un’eccellente selezione sia in quantità che in qualità, si trovano in collezioni private negli Stati Uniti e in Slovacchia, come Ján Ferko, che possiede ben 130 chitarre a Sobrance, in Slovacchia.