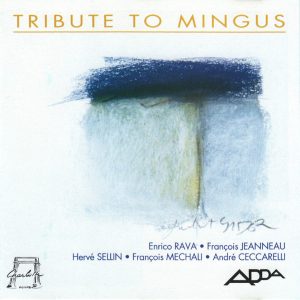Paolo Fresu & Ojdm Paolo Silvestri Con «Norma», un esercizio di discontinuità stilistica caricato di coscienza storica (Tǔk Music)

Paolo Fresu
Il valore di tale operazione risiede nella sua forza divulgativa, in cui la trasversalità stilistica, lungi dall’essere banalizzazione, diventa pontifex tra mondi spesso considerati antitetici: quello dell’opera ottocentesca e quello del jazz postmoderno..
// di Francesco Cataldo Verrina //
La rilettura orchestrale di Norma di Vincenzo Bellini in chiave jazzistica ad opera del sodalizio artistico tra Paolo Fresu e Paolo Silvestri costituisce una significativa operazione di travalicamento stilistico e culturale, nella quale il paradigma dell’ibridazione musicale assume connotati di straordinaria pregnanza espressiva. Lontano da mere contaminazioni epidermiche, il progetto si configura come una pratica ermeneutica profonda, che non si limita ad accostare moduli jazzistici a materiali melodrammatici, ma li fa interagire in un dialogo stratificato, dove ogni elemento conserva la propria dignità semiotica pur aprendosi a risonanze inedite.
Nel solco della cosiddetta third stream, di cui Gunther Schuller fu teorico e fautore sin dagli anni Cinquanta, questa proposta si distingue per organicità e coerenza progettuale. Mentre i precedenti tentativi di coniugare linguaggi distanti hanno spesso generato ibridi irrisolti o compromessi stilistici, Fresu e Silvestri offrono una vera e propria reinvenzione strutturale. Lungi dall’essere semplice trasposizione strumentale delle celebri arie belliniane, l’operazione sottende una riflessione sull’ontologia della voce e sul ruolo della tromba quale surrogato poetico del canto umano. L’approccio di Fresu – da sempre orientato a esplorare l’interstizio fra oralità e scrittura, fra improvvisazione e partitura – trova nel pentagramma belliniano una materia fertile, da cui estrarre con sensibilità filologica, ma anche con intuito creativo, un nuovo vocabolario. Il suo fraseggio – sorvegliato, intenso ed evocativo – si pone in dialogo con l’orchestrazione, splendidamente calibrata da Silvestri, che evita ogni sovradimensionamento timbrico a favore di una tessitura equilibrata e agogicamente fluida. Il risultato è un continuum sonoro che restituisce al pubblico la forza archetipica del melodramma romantico, riproposto però attraverso una lente contemporanea, capace di illuminarne gli echi atemporali. Particolarmente emblematica in tal senso risulta la rilettura di Casta Diva, in cui la voce della sacerdotessa si trasforma, per tramite dell’ottone, in un’invocazione dal timbro ora intimo ora solenne, sospesa tra pathos ed astrazione. L’uso della sordina, nelle sezioni più rarefatte, conferisce alla linea melodica un carattere quasi ascetico, mentre l’Orchestra Jazz del Mediterraneo plasma il tessuto armonico con impasti timbrici di raffinata levigatezza.
Degna di nota è altresì la dichiarata volontà di non seguire la successione narrativa originale dell’opera, bensì di offrirne una rilettura discontinua, disancorata dalla linearità drammaturgica ma per ciò stesso più universale, in cui ciascun brano diviene luogo simbolico, evocazione di uno stato emotivo piuttosto che tassello narrativo. La tromba di Fresu, in tal senso, si erge a strumento metamorfico, capace di «cantare» senza mimare, di accogliere in sé l’essenza della vocalità umana senza mai simulare alcuna voce determinata. Il valore di tale operazione risiede nella sua forza divulgativa: la trasversalità stilistica, lungi dall’essere banalizzazione, diventa pontifex tra mondi spesso considerati antitetici, ossia quello dell’opera ottocentesca e quello del jazz postmoderno. In tempi di crescente compartimentazione del sapere e delle arti, la proposta di Fresu e Silvestri si pone quale esempio di coraggioso attraversamento dei confini linguistici, riaffermando la centralità della musica quale lingua franca della sensibilità umana. Il primo raffronto potrebbe essre fatto con «Porgy And Bess» di Miles Davis e Gil Evans, versione orchestrale dell’opera di Gershwin, realizzata nel 1958, dove l’approccio era più dichiaratamente sinfonico-jazzistico, con arrangiamenti sontuosi ed una tromba che si faceva voce narrante. Tuttavia, «Porgy And Bess» nasceva già come un progetto «ibrido», con radici afro-americane ed una struttura aperta all’improvvisazione. «Norma», al contrario, essendo un capolavoro del belcanto ottocentesco, la sua trasposizione in chiave jazz richiede un’operazione di trasfigurazione ben più ardita. Fresu non si limita a «colorare» le arie, ma le reinventa, mantenendone l’essenza melodica, trasportandole in un universo timbrico ed armonico radicalmente altro. «La création du monde», l’opera di Darius Milhaud, composta nel 1923, rappresenta uno dei primi esempi di contaminazione tra jazz e musica colta, offre un’ulteriore suggestione comparativa. Tuttavia, si tratta di una composizione originale, non di una rilettura di repertorio. In quel contesto il jazz viene evocato come linguaggio esotico, quasi decorativo. In «Norma», invece, il jazz diventa strumento ermeneutico, chiave interpretativa che consente di accedere a nuove profondità espressive del testo belliniano, dove le arie non sono tappe, ma topoi, ossia universi espressivi che rinunciano alla consequenzialità per aderire ad una logica associativa, quasi proustiana, secondo un principio epistemico profondo, il quale nasce il rifiuto del tempo narrativo a favore di un tempo affettivo, dove ogni frammento vive come condensato emotivo autonomo, non come episodio funzionale.
Il jazz contemporaneo ha abbandonato da tempo la grammatica bebop, la verticalità armonica del modernismo anni ’50, per esplorare territori contaminati, polistilistici, spesso prossimi all’astrazione. Parliamo di una nuova estetica jazzistica, la quale rifugge ogni codificazione e che attinge al minimalismo quanto all’elettronica, al folclore quanto all’improvvisazione radicale. In questo contesto, «Norma» si distingue non tanto per la fusione, quanto per la riattivazione rituale della forma melodrammatica, ricollocata all’interno di un orizzonte jazzistico non affine per nascita, ma che la accoglie come memoria aurorale. La tromba di Fresu, con il suo timbro sorgivo e la pronuncia levigata, si pone come mediatrice fra due mondi solo apparentemente inconciliabili. Come già sottolineato, lungi dal mimare o «jazzificare» le arie belliniane, egli le incorpora in una narrazione emotiva nuova, affine a certo jazz europeo contemporaneo. Si pensi alla poetica rarefatta di Enrico Rava, all’intimismo nordico di Arve Henriksen, o all’eloquenza lirica di Tomasz Stańko. A differenza di questi illustri colleghi, Fresu lavora su una materia preesistente e fortemente codificata, che egli decanta senza deformare, con un rispetto filologico innervato di visionarietà. Dal punto di vista orchestrale, Silvestri declina una prassi compositiva che evita tanto l’omaggio quanto il pastiche. La scrittura sinfonica – mai ridondante, mai assertiva – crea ambienti mobili e porosi, nei quali il solista può muoversi liberamente. Questo modus operandi appare affine ad alcune esperienze del jazz orchestrale odierno (si pensi a Maria Schneider o Darcy James Argue), ma ne differisce per la volontà di rifondare l’orchestra come corpo narrativo, e non come contenitore di solismi.
Norma non si confronta semplicemente con il jazz contemporaneo, ma lo interroga, lo sfida, lo costringe a farsi altro, incarnando l’idea di un’opera che si colloca ai margini del jazz inteso come genere, nonché al centro del jazz inteso come metodo, un approccio al suono, al tempo ed alla forma che rifiuta le recinzioni disciplinari per restituire alla musica la sua funzione primaria di veicolo del pensiero emotivo. L’universo sonoro della ECM (Editions of Contemporary Music), fondato da Manfred Eicher nel 1969, rappresenta un paradigma estetico che ben si presta ad un confronto con l’operazione Norma di Fresu e Silvestri. Entrambi i mondi condividono una tensione verso l’essenzialità, la rarefazione timbrica ed una concezione del suono come spazio meditativo, più che come semplice veicolo espressivo. L’estetica del silenzio e della sospensione, ossia la cifra stilistica della ECM si fonda su una poetica del vuoto, del non-detto e dell’intervallo. In lavori come Officium di Jan Garbarek con l’Hilliard Ensemble o Le pas du chat noir di Anouar Brahem, il silenzio diventa elemento strutturale, non semplice pausa. Analogamente, in «Norma», la tromba di Fresu si muove in uno spazio sonoro rarefatto, dove ogni nota risulta ponderata ed ogni respiro diventa parte della narrazione. La sospensione lirica di «Casta Diva», ad esempio, trova un’eco concettuale nella lentezza contemplativa di Keith Jarrett in The Köln Concert. Molti lavori ECM si distinguono per una vocalità implicita degli strumenti: il sax di Garbarek, il pianoforte di Tord Gustavsen e l’oud di Brahem cantano più che suonare. Fresu si inserisce perfettamente in questa linea, tanto che la sua tromba non è mai assertiva, ma evocativa, quasi cantabile nel senso più lirico del termine. La sua «Norma» non è un’imitazione della voce, ma una sua trasfigurazione timbrica, come accade in Tabula Rasa di Arvo Pärt, dove il violino si fa voce interiore. L’ibridazione colta di casa ECM ha sempre promosso un jazz spesso contaminato da elementi classici, medievali ed orientali. La New Series dell’etichetta, dedicata alla musica contemporanea, ha ospitato compositori come Pärt, Silvestrov, Goebbels. In questo contesto, «Norma» si pone come un lavoro affine. Piuttosto che un semplice crossover, si sostanzia quale atto di traslazione culturale, in cui la classicità melodrammatica viene riletta attraverso un filtro jazzistico che ne preserva la verticalità espressiva. La ECM ha sempre curato con maniacale attenzione l’aspetto visivo delle sue produzioni attraverso copertine minimali, paesaggi astratti, assenza di protagonismo iconografico. Anche Norma s’inserisce in questa linea, dove la cover art di Alessandro Gottardo, con la sua sobrietà evocativa, dialoga perfettamente con l’estetica sonora del progetto, creando un unicum sinestetico. A conti fatti, «Norma» potrebbe benissimo essere un disco ECM, poiché ne condivide la filosofia, la cura formale e la tensione poetica. Parliamo di un concept che non si limita a «suonare bene», ma che pensa il suono, lo interroga, lo plasma come materia viva. In tal senso, Fresu e Silvestri si pongono come eredi spirituali di quella linea estetica che da Eicher in poi ha ridefinito il concetto stesso di jazz-no-jazz europeo.
In «Casta Diva», iconica invocazione lunare della protagonista, l’aria viene trasfigurata in una meditazione sonora di rara intensità. Il timbro ovattato della tromba con sordina si fa oracolo estatizzato, sospeso tra terreno e trascendente. Fresu non imita il canto ma lo sublima, mentre la melodia scivola in un continuum dolente, cesellato da un’orchestra dal passo trattenuto, che predilige atmosfere rarefatte e cangianti. Il risultato è un lirismo di cristallina nobiltà, scolpito nel respiro stesso del silenzio. In «Va, crudele, al Dio spietato» l’eloquenza jazzistica si coniuga con il pathos drammaturgico belliniano attraverso un dialogo sonoro serrato. L’impalcatura armonica si addensa in climi quasi modali, mentre la tromba tesse frasi spezzate e imploranti, come richiami interiori che trascendono la parola. Sembrerebbe una pagina perturbante, in cui l’elemento melodico si contorce fra tensioni e rilascio, sino ad assurgere a confessione sonora. «Dormono entrambi» coglie un momento di ineffabile intimità. La muta poesia dell’infanzia e del sonno si rapprende in un fraseggio sospeso, quasi esitante, dove la sordina conferisce all’ottone un velo di pudore quasi sacro. L’orchestra qui si ritrae in un contrappunto discreto, evitando ogni compiacimento illustrativo. L’effetto è quello di un notturno sofferente, fitto di chiaroscuri affettivi. «Oh! Rimembranza!» rappresenta una delle vette espressive dell’intero progetto. Fresu si muove con libertà caleidoscopica entro gli interstizi della memoria sonora, destrutturando e ricomponendo frammenti melodici in un gioco continuo di evocazioni e sparizioni. La reminiscenza si fa gesto sonoro, in una poetica della dissolvenza che vibra di nostalgia ed inquietudine. «Deh! Proteggimi, o Dio!» diventa una pagina d’alta drammaticità, in cui il fervore dell’invocazione religiosa si annoda al senso di vulnerabilità umana. La tromba assume una postura profetica, quasi battente, mentre l’orchestra tesse un tappeto armonico che alterna impennate dissonanti a momenti di contemplazione assorta. L’elemento spirituale viene restituito con sobrietà e senza enfasi retoriche. «Guerra! Guerra! / Qual cor tradisti / Deh, non volerli vittime» si sostanzia come finale di travolgente potenza emotiva e teatrale. Si passa dalla marzialità bellicosa alla disperazione supplice, in un crescendo che trova nell’orchestrazione di Silvestri una tessitura polifonica avvolgente. Fresu impone al suo strumento una gamma timbrica prodigiosa, sofferta, vibrante e rabbiosa. L’elemento narrativo si dissolve in una gestualità astratta che non smarrisce, tuttavia, la pregnanza semantica originaria. A differenza di molte riletture jazzistiche del repertorio operistico (spesso fondate su trasposizioni melodiche e reimpasti armonici), qui siamo di fronte a una morfogenesi timbrica, in cui la tromba – intesa non come strumento ma come «tessuto fonico incarnato» – assume il compito di riformulare l’identità vocale dell’opera. Trattasi di una metamorfosi più che una interpretazione
Tutte le tracce concorrono alla costruzione di una macro-narrazione emotiva, in cui la materia operistica viene metabolizzata e restituita attraverso un filtro jazzistico colto, profondo, non imitativo ma dialettico. La tromba non sostituisce la voce, piuttosto ne diventa alter ego poetico, veicolo di un canto silente che grida. Una proposta di alto valore estetico, la cui tenuta formale e l’intensità comunicativa meritano di essere indagate ulteriormente anche in ambito musicologico. Il progetto di Paolo Fresu e Paolo Silvestri si colloca in una tradizione di riletture jazzistiche del repertorio melodrammatico che, pur non vastissima, ha prodotto esiti di notevole interesse. Tuttavia, rispetto ad altri tentativi analoghi, la trasduzione fresiana si differenzia per coerenza estetica, profondità concettuale e rigore esecutivo. In sintesi, «Norma» si distingue per la capacità di coniugare fedeltà e libertà, rigore ed invenzione. Non è un’operazione di maquillage sonoro, ma un atto di ri-creazione musicale. In un panorama in cui molte «jazzificazioni» operistiche si limitano a trasposizioni superficiali, Fresu e Silvestri offrono un esempio di come il jazz possa diventare strumento di indagine filologica e poetica, capace di restituire nuova vita ad un capolavoro del passato senza tradirne lo spirito