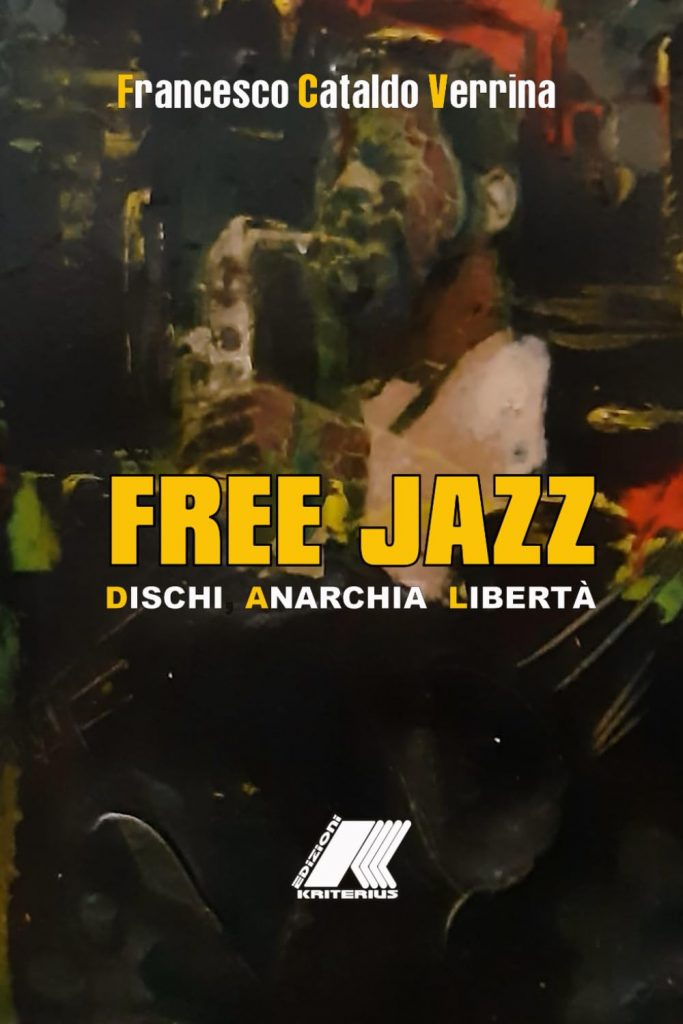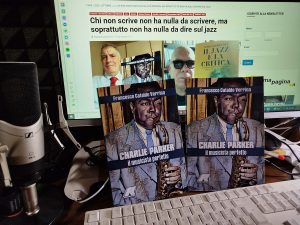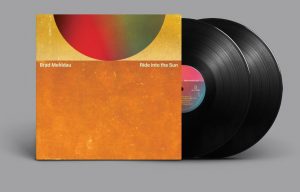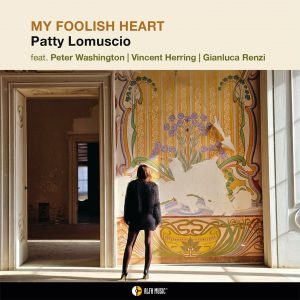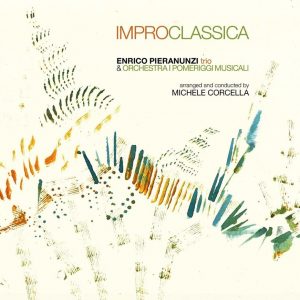Oggi Archie Shepp Compie 87 anni

// di Francesco Cataldo Verrina //
Archie Shepp riuscì a catalizzare tutti i fermenti insurrezionalisti e le istanze di protesta degli Afro-Americani che andarono a costituire i cardini ispirativi della sua musica. Il sassofonista, oggi ultraottantenne ed ancora attivo, è forse l’icona vivente del jazz per antonomasia, non che altri eminenti ottuagenari ancora in vita siano da meno, ma Shepp rappresenta un compendio della storia della musica afro-americana degli ultimi sessant’anni, un modello di transizione permanente con un piede nella libertà espressiva ed un piede nella tradizione. Nella musica di Shepp, ora come allora, esiste una costante non sempre riscontrabile in altri coevi, ossia la teatralità della narrazione sonora, a volte drammatizzata fino all’inverosimile. Da una parte esiste una predisposizione naturale, dall’altra, però, ci sono gli studi ed una laurea in letteratura e drammaturgia conseguita nel 1959 al Goddard College, nonché il fatto di aver bazzicato inizialmente gli ambienti teatrali di New York alla ricerca di un lavoro. La sue prime esperienze di contraltista in alcune orchestre da ballo gli hanno lasciato, per sempre addosso quell’odore di tradizione, che gli ha consentito, perfino nei momenti musicalmente più riottosi ed estremi, di non perdere mai il controllo sulla melodia, in particolare dopo il passaggio al sax tenore e l’adesione totale alla causa del free jazz.
Il sassofonista non ha mai ricevuto unanimi consensi, soprattutto perché in molti, spesso, si sono limitati ad un’analisi superficiale: per motivazioni differenti è accaduto anche con Cecil Taylor. In tanti si sono fermati al vulcanico Shepp della contestazione, tralasciando la sua progressiva metamorfosi: negli anni ’70, ad esempio, impiegò un approccio R&B basato sul fatback/swing, mentre negli anni ’80 mescolò bebop, ballate e pezzi blues mostrando poco della furia dei suoi primi giorni, senza mai però accettare compromessi. A partire dalla fine degli anni ’60 la retorica fu attenuata e la rabbia cominciò a diradarsi, sostituita da un atteggiamento più celebrativo ed a volte riflessivo. Alla fine del decennio fece il suo ingresso perfino nel mondo accademico, insegnando al Suny di Buffalo, quindi all’Università del Massachusetts sino a diventare professore associato nel 1978. «Four For Trane» di Archie Shepp ebbe una genesi che profuma un po’ di libro Cuore. Il più anziano collega, nello specifico John Coltrane, prende quasi per mano il giovane apprendista stregone e lo conduce al cospetto di sua maestà Bob Thiele, all’epoca deus ex-machina della Impulse! Records. Trane intercede perché Archie possa avere l’opportunità di incidere il suo primo disco. L’arcigno produttore si mostra inizialmente titubante e pretende che Shepp debba impegnarsi ad eseguire solo brani del repertorio coltraniano, ma dopo aver sentito il giovane sassofonista suonare, gli concede l’opportunità d’inserire nel progetto anche un suo componimento.
Il racconto di Shepp su come era arrivato alla Impulse! fornisce uno sguardo rivelatore sulla considerazione che Coltrane metteva in ogni sua raccomandazione. «La mia famiglia ed io eravamo in assistenza all’epoca; personalmente prendevo un dollaro dal mio assegno e spendevo dieci centesimi al giorno per chiamare Bob Thiele». Raccontò Shepp. «Ogni volta che chiamavo, la sua segretaria Lydia mi diceva: Bob non è qui, è appena andato a pranzo, oppure non tornerà per il resto della giornata. Queste furono le tre risposte che ho ricevuto per mesi. Alla fine, su suggerimento di Bill Dixon che mi disse: beh, sai, è piuttosto sciocco. Se Coltrane è così amico tuo, perché non gli chiedi di procurarti una sessione di registrazione? Ero molto umile al riguardo; mi sembrava piuttosto strano sfruttare un’amicizia. Ma, in un momento di disperazione, quando i soldi erano pochi ed avevo avuto un trattamento molto brutto da Miles Davis che mi suggeriva di lasciar perdere. Anche se lui mi aveva detto di no senza mezzi termini, avevamo avuto un vero confronto. Così sono andato all’Half Note in Spring Street dove John si stava esibendo, e ho detto, va bene, forse glielo chiederò. Quando scese dal palco gli dissi: John, voglio chiederti un favore. Lui mi guardò molto intensamente, era la prima volta che mi guardava intensamente, quindi disse, sì, che cosa c’è, Shepp? A questo punto gli domandai: potresti aiutarmi a ottenere una data di registrazione? Quindi mi guardò ancora più intensamente, dicendo: sai, un sacco di gente si approfitta di me, perché pensano che sia facile. Non avevo una risposta per questo, perché sapevo di aver sempre avuto un profondo rispetto per quell’uomo, e ciò che gli stavo chiedendo, umilmente, me lo sarei meritato. Quindi aggiunse: bene, vedrò cosa posso fare. Quello fu l’inizio della collaborazione con la Impulse! Records».
Va detto che molti, fra coloro che nutrono dei dubbi nei confronti dell’intero corpus delle operesheppiane, si lasciano sedurre da «Four For Trane», lavoro peraltro immaturo in cui il debuttante sassofonista non aveva ancora tracciato e definito le sue vere coordinate, ma sarà quel «Trane», che diventa una sorta di bollino di garanzia, ad irretire buona parte dei cultori del jazz moderno. Certamente, avere avuto John Coltrane come sponsor, fu un lasciapassare importante per Shepp, ma il suono di «Four For Trane», sebbene l’ensemble sia più piccolo, ricorda più le registrazioni di Mingus per la Impulse!: «The Black Saint And The Sinner Lady» e «Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus», tentando di sviluppare un’atmosfera ornettiana nell’accezione più larga del termine.
Un’operazione interessante sul repertorio di Coltrane: tre classici prelevati da «Giant Steps» ed uno da «Coltrane Plays The Blues», arrangiati in maniera non convenzionale, ma pensando più a Mingus che a Coltrane, attraverso un costrutto sospeso tra post-bop ed avanguardia, dove il pianoforte è sostituito da tre fiati aggiuntivi. La ciliegina sulla torta è il brano firmato da Shepp, «Rufus» il più spinto verso le avanguardie e foriero di un suono grezzo e dematerializzato, contenente, però, residui di bop, un assetto swing ed una certa ballabilità per via delle percussioni molto groovy. Si intuisce come il sassofonista si trovasse ancora in una fase transitoria e che il cordone ombelicale che lo lega alla tradizione non fosse stato ancora del tutto reciso. Shepp al tenore è accompagnato da John Tchicai al contralto, Alan Shorter alla tromba, Roswell Rudd al trombone, Reggie Workman al basso e Charles Moffett alla batteria. Nonostante l’inesperienza Shepp riesce a caratterizzare molto bene il suono del suo strumento, attraverso un timbro ruvido e tagliente, a volte quasi scostante ed inaccessibile, altre carico di melodismo e liricità. All’epoca dei fatti «Four For Trane» ricevette recensioni e pareri contrastanti, poiché sembrava che Shepp avesse vanificato parte del dinamismo propulsivo delle registrazioni originali di Coltrane. Dopo un’attenta analisi, però, ci si accorge che venne esaltata l’abilità del Coltrane compositore, dimostrando quanto certe creazioni possedessero la profondità e la complessità atta a sopportare un trattamento diverso e più articolato. Shepp trasformò le parti solistiche, originariamente eseguite solo dal sax, in un veicolo per quattro strumenti a fiato, soprattutto non cercò di produrre lunghe linee di note ampie ed apparentemente senza fine come faceva il suo mentore, ma suonò come se stesse inciampando su e giù per una sgangherata rampa di scale, saltando e contorcendosi, con asimmetrie sonore, angoli acuti e disgiunzioni.
L’album si apre con « Syeeda’s Song Flute» proposta in un’ingegnosa versione bluesy, dove Shepp permette a Rudd di arrangiare i suoi assoli e quelli di Tchicai, mentre lo stesso trombonista guida la fase più blues e gospel nel corpo centrale del brano, prima di dare spazio alla progressione ritmica di Workman e Moffett. «Mr. Syms», originariamente un blues caldo e avvolgente, forse troppo calmo per l’occasione, ma Archie alza il tiro rendendolo scricchiolante e dissonante, senza snaturarlo eccessivamente e preservandone l’atmosfera. «Cousin Mary» è più imbrigliata nella tradizione bop. La continuità melodica è sostenuta da un tema ripetuto costantemente, quasi come un loop, piuttosto che solo all’inizio e alla fine, rendendo più regolare il suono ruvido ed accidentato del tenorista. Dal canto suo Tchicai sembra mantenere una calma apparente, facendo da cuscinetto all’entrata di Alan Shorter (fratello di Wayne) che suona a metà strada fra Ornette Coleman e Don Cherry. «Naima», la tenera e romantica ballata di Coltrane, non riceve alcun trattamento di favore nell’interpretazione di Shepp, divenendo una cosa altra dall’originale. Sebbene tutto il line-up risulti molto più trattenuto che altrove, il suono è comunque inasprito dal nuovo arrangiamento di Roswell Rudd che riarmonizza il pezzo adattandolo al registro medio del band-leader, il quale disloca la melodia al limite della consonanza. Si avvertono, inoltre molte influenze mingusiane, specie nelle battute iniziali, fortemente swinganti. «Rufus (Swung, His Face At Last To The Wind, Then His Neck Snapped)», l’unico pezzo originale a firma Shepp, pur essendo tutt’altro che sofisticato e complesso funziona perfettamente e si amalgama al contesto coltraniano grazie alla bravura dei singoli membri del line-up, in particolare Tchicai. La melodia è quasi inesistente, i cambi di chiave sono commisurati ai cambi di tempo, mentre gli accordi, alquanto irregolari, sembrano nascere da una fantomatica scala mobile. Il tono di Shepp appare simile ad un urlo multifonico, ma tende ad approdare costantemente ad una dimensione lirica con l’intento di bilanciare costantemente i due elementi, dissonanza e melodia, attraverso un gioco di divergenza e convergenza verso un ideale punto di pareggio.
«Four For Trane», registrato il 10 agosto del 1964 al Van Gelder Studio, mostra soprattutto un’idea di estetica condivisa tra sodali con evidenti affinità elettive; non c’è nulla di arbitrario o accidentale in questa collaborazione, tutti giocano sulle variazioni di idee confluenti. Nell’intero costrutto sonoro i musicisti manifestano un debito di riconoscenza verso il Trane-autore, includendo i suoi temi, la sua sensibilità ed il suo pathos anche nelle loro preoccupazioni, non solo negli assoli; l’album non rappresenta una forma di adulazione, ma un dialogo costante con il miglior Coltrane. (Archie Shepp – «Four For Trane», 1964) – Da Free Jazz: Dischi, Anarchia & Libertà.