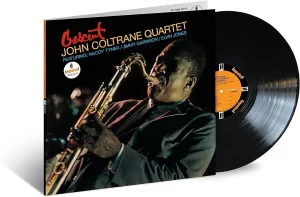Don Pullen e George Adams, un dionisiaco invasamento

Don Pullen & George Adams
// di Gianni Morelenbaum Gualberto //
«Je suis de ceux qui vouent les hommes à d’autres choses que la production sans cesse accrue, qui les provoque à l’horreur sacrée», scriveva Bataille. A cosa, a chi, a che parole ricorrere per definire, nell’esibizione del quartetto guidato da Don Pullen e George Adams, tale dionisiaco invasamento che, pure, nell’enfasi orgiastica mantiene un fervore intellettuale che negozia incessantemente un confine sempre più ampio entro il quale espandersi? Secondo Christopher Small, tutte le esecuzioni musicali possono essere lette come un rituale, e come tali rispecchiano le strutture e le relazioni sociali della comunità che vi partecipa. Trattare l’arte performativa musicale come una pratica rituale porta certamente a privilegiare il contesto rispetto al contenuto, che serve perciò soprattutto come punto di origine per le forze sociali generate dalla forma rituale.
La questione, dunque, non è cosa afferma il contenuto, ma come lo afferma, quale tipo di strutture e relazioni sociali rispecchia e sostiene nella sua stessa forma di comunicazione. La forma abituale di esecuzione musicale occidentale opera per rafforzare un duraturo dualismo cartesiano, la separazione tra la nostra mente e il nostro corpo, tra il nostro io e chi ci circonda. Essa delinea e avalla un’esperienza che rimane nell’ambito dei nostri concetti quotidiani di sé e del mondo; un soggetto che contempla un oggetto nel mondo e risponde ad esso, la mente che contempla la materia. Rimanendo chiusi nella nostra poltrona al buio, o di fronte allo schermo di un computer, e apprezzando il concerto solo attraverso gli occhi e le orecchie, siamo tagliati fuori da esperienze sensoriali più viscerali e dalla partecipazione attiva a una comunità. L’enfasi sembra essere posta su un’esperienza estetica individuale che mira a una sorta di trascendenza; la mente che trascende il corpo, l’individuo che trascende la comunità. Non c’è solo una scissione, c’è anche una contraddizione nel modo in cui l’anonimato omogeneo del pubblico nasconde le risposte altamente individuali al concerto, che possono essere comunicate solo entro un raggio d’azione assai ristretto. Un rituale, come il mito, implica una tradizione, una convenzione, legata a gesti e parole specifiche che suscitano l’effetto desiderato nel mondo.
Tuttavia, la tradizione rituale può cambiare se una massa critica di partecipanti s’impegna a modificare il corso del procedimento. Questa flessibilità -di cui talvolta ci dimentichiamo- mostra, come scriveva Frederick George Bailey, il «paradosso della performance culturale: è reale nei suoi effetti ma, poiché immaginata, dà ai suoi creatori e al loro pubblico una libertà di invenzione e interpretazione che non esiste rispetto alla realtà strutturata o positiva». In quanto performance, dramma sociale, il rituale non è mai completamente articolato, ma è sempre indeterminato e in continua evoluzione, con una tensione dinamica tra il testo codificato e la situazione della performance, fra struttura e improvvisazione. Non è nemmeno solo un’espressione astratta di valori e credenze collettive, ma un vero e proprio veicolo di cambiamento delle percezioni e delle interpretazioni delle persone sul proprio posto nella società e nel mondo. Ritornare a questa interpretazione del Quartetto di Pullen e Adams è ritornare esemplarmente ad un esempio di rituale collettivo che si espande dai quattro officianti per coinvolgere un’intera comunità in diverse fasi di invasamento in cui permane, apparentemente in sottofondo ma costante, un alto livello di apollineo controllo. D’altronde, i rituali sono anche momenti di trasgressione e trasvalutazione delle norme di comportamento quotidiane, come dimostra il sacrificio rituale.
La separazione tutta occidentale fra aspirazioni della mente e desideri del corpo è qui al centro della reiterazione di un sacrificio che segna un momento di trasgressione, la rottura e la conseguente invocazione di un tabù che diventa oggetto di freudiana Besetzung, una catessi (κάθεξις) libidica, intensificata dalla paura, e così la rottura rituale del tabù, il sacrificio, è un momento di liberazione, di intimità estatica e di immediatezza con l’oggetto sacrificato. L’esuberanza fisica, la danza, l’espansività del linguaggio corporale, il «give and take» fra gli officianti e fra gli officianti e la comunità, il magistero strumentale che dà pur rigorosa voce all’invasamento dionisiaco: tutti elementi irrazionali che permettono la costruzione della società razionale. I rituali di norma codificano e controllano questi casi di trasgressione violenta, consentendo un’unione momentanea con il sacro per fornire istanze di liberazione catartica dell’irrazionale dionisiaco prima che la comunità ritorni alla funzione normativa e proscrittiva del tabù come comportamento limitante. La rottura dei tabù nei sacrifici rituali violenti può quindi essere vista come un modo per sconvolgere, anche se solo momentaneamente, la visione quotidiana del mondo e le strutture e relazioni sociali concomitanti.
Il jazz, la tradizione musicale africano-americana e l’improvvisazione che la rappresenta sono parte di un unico, prolungato rituale che all’interno della cultura americana ha infranto definitivamente il tabù della forma-concerto eurocentrica, conferendo nuovo significato al termine «avanguardia» e cancellando lo stesso termine così come concepito nel contesto eurologico. Dalla sua prima articolazione nel fermento afro-caraibico coagulatosi fino a New Orleans, non vi è stato più ritorno alla «normalità» normativa imposta dalla colonizzazione europea e dai suoi effetti: il jazz, sin dalla sue forme più informi, ha infranto in modo definitivo il tabù delle concezioni sociali espresse dalla tradizione musicale eurocentrica., con una rivoluzione priva di terrore che contraddiceva un altro pensiero di Bataille: «La terreur des révolutions n’a fait que subordonner de mieux en mieux l’énergie humaine à l’industrie». Quello che possiamo osservare sul palco in questo filmato non è che il replicarsi vitale dell’infrazione originaria, una manifestazione di eros e thanatos che pur ritualizzata mantiene intatta la sua carica eversiva, il suo appellarsi alla diversità, all’eterogeneo piuttosto che all’omogeneo. Perché, in fondo, e forse neanche tanto, il jazz (termine che uso per semplificare una realtà infinitamente ramificata) ha officiato, nel Novecento, la fine del dominio culturale europeo, ben prima che ci pensassero due guerre mondiali e la Shoah.