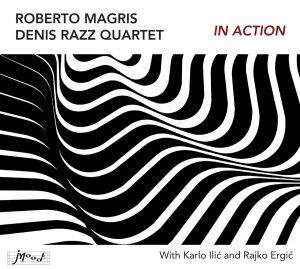Eric Dolphy con «Outward Bound», sulla linea di confine tra hard bop e volo libero (New Jazz, 1960)

/ di Francesco Cataldo Verrina //
Eric Dolphy, autentico genius loci, pur avendo lasciato orme indelebili sul cammino del jazz moderno, venne strappato al mondo degli uomini prima che potesse dare il meglio di sé. Nella sua «Biographical Encyclopedia Of Jazz», Leonard Feather cita Mingus che si complimenta con Dolphy: «Eric conosceva quel livello di linguaggio a cui pochi musicisti potevano arrivare». A volte, però, si ha come l’impressione che la figura di Eric Dolphy sia stata inquadrata male e si continui ad averne una visione sfuocata e non perfettamente definita. Se provate a chiedere ad un appassionato di jazz, il titolo di un suo album, vi risponderà «Out To Lunch», ma questa è un’arma a doppio taglio. È pur vero che Eric Dolphy sia uno dei jazzisti privilegiati, poiché nella sua opera omnia esiste almeno un album «epocale», commercialmente importante, che tutti conoscono, ma al contempo «Out To Lunch», uscito postumo nell’agosto del 1964, ne ha cannibalizzato tutta la discografia in vita, o quasi: se l’è mangiata, l’ha digerita ed in parte l’ha fatta sparire. Va precisato che il catalogo post-mortem di Eric Dolphy è caratterizzata da una serie di eccellenti registrazioni live, che testimoniano la vera grandezza del multistrumentista, insieme alle tante registrazioni realizzate alla corte di Charles Mingus.
Nonostante parte dell’attività discografica del polistrumentista nasca e si concluda con un «out…out», in realtà la musica di Eric Dolphy è sempre una corsa verso l’interno; c’è una turbinosa forza centripeta in lui, un’introspezione costante che non riuscirà mai ed esternare completamente. «Outward Bound», titolo che potremmo tradurre come «diretto verso l’esterno», ma che in realtà, per paradosso, avrebbe potuto essere anche «Directed Inward», ossia «diretto verso l’interno». Trattasi, comunque, di una sessione in quintetto del 1960, che mostra Dolphy in una fase transitoria, giocata sulla linea di confine, border line, tra hard bop anni ’50 e jazz a volo libero anni ’60. Le tre composizioni a firma Dolphy sono quelle che guardano più avanti, gli standard sono un continuum con la tradizione. I primi quattro album di Dolphy vengono considerati come una fase di assestamento, ecco perché si è propensi a far coincidere il massimo della sua espressività espositiva e compositiva tra i due «out…out», ossia tra il 1960 ed il 1964. «Outward Bound», registrato allo studio Van Gelder, è l’album che prefigura ciò che Dolphy avrebbe avuto in serbo nei successivi lavori, dove mostrerà di essere un eccelso interprete del sax contralto, un unicum sul clarinetto basso ed un compositore innovativo che suona il flauto ad alti livelli, raggiungendo il picco nella sua magnum opus «Out to Lunch», con la quale intendeva porre le basi per il futuro.
In «Outward Bound» Dolphy, accompagnato da Freddie Hubbard (tromba), Jackie Byard (piano), George Tucker (basso) e Roy Haynes (batteria), ha un sorprendente ed imperioso comando su contralto, flauto e clarinetto basso, giocando con la velocità e la furia di Charlie Parker ma con una dolcezza e una grazia del tutto personale. Un punto culminante della sessione è la batteria fantasiosa e raffinata di Roy Haynes. «245» è un blues notturno a firma Dolphy imperniato sul sax alto e testimonia la capacità del polistrumentista di mantenere forma e struttura, pur tracciando note veloci in una modalità che solo lui sembrerebbe comprendere, ottimo l’assolo di Hubbard sul registro blues. Lo standard «Glad To Be Unhappy» nasce da una bella e vivace lettura sul flauto, con i sodali che forniscono un accompagnamento vivace e adeguato. Per «Miss Toni» Dolphy sfodera il clarinetto basso prorompendo in un gioioso abbandono, mentre la mesmerizzante tromba di Freddie Hubbard diventa una sorta di riverbero alle progressioni del leader. Il gioiello della corona dell’album è «On Green Dolphin Street». Freddie Hubbard in sordina, ottiene un suono assai piacevole ed avvolgente, mentre Dolphy risponde con il clarinetto basso. Tra le molte, questa è una delle versioni più riuscite, capace di raggiungere un’aura di serendipità, ossia una rivelazione inattesa basata sulla scoperta di un nuovo elemento aggregante che nasce dalla combine fra due fiati, tanto che da sola varrebbe il prezzo della corsa. Nel complesso l’interpretazione del giovane e rampante Freddie Hubbard, uno dei pochi trombettisti in grado di eguagliare l’energia di Dolphy, è fortificante. Hubbard dimostra di avere una sua complessità tonale, specie quando si muove su un terreno più tradizionale, mentre con la sua tromba fornisce una pompa di calore di cui i ciclici vagabondaggi, talvolta astratti e pindarici di Dolphy, sembrano essere privi.
Anche se ai cultori delle avanguardie potrebbe apparire più leggero ed ammiccante rispetto ad alcuni lavori successivi, «Outward Bound» rivela un Dolphy che segna storicamente un passaggio essenziale: è una delle ultime volte in cui la giustapposizione tra le inclinazioni sperimentali e le origini hard bop sia ancora così evidente e marcata. Tra i solchi ci sono molto più swing e melodie a presa rapida che catturano immediatamente l’ascoltatore. Si potrebbe dire che sia l’album più mingusiano di Dolphy, proprio per questo suo guardare nello specchietto retrovisore della tradizione, tentando di proiettarsi verso quella «forma dl jazz che verrà». È, perfino, possibile tracciare un parallelo tra Dolphy e il primo Ornette Coleman, le cui concezioni armoniche non ancora estremizzate appaiono piuttosto simili, anche se il costrutto sonoro di Dolphy risulta più coerente, a monte di un talento maggiore. Dolphy è stato un unicum: il suo modo di suonare c’era la perfetta trascrizione di un’inquietudine interiore. A volte la sua musica sembrava in costante ebollizione, fitta di linee taglienti e frastagliate, capaci di sollevano l’ascoltatore muovendosi a spirale e di irretirlo in una girandola di cruda espressività, tra furia, frustrazione e sentimenti aspri e contorti che sgorgavano dalle fauci dei suoi strumenti. Nello specifico, quello con cui riesce meglio è il clarinetto basso (strumento a volte sconosciuto). Nel registro superiore, il suono del clarone è più nitido e descrittivo, quasi simile a quello del sax contralto, ma ciò toglie nulla alla sua unicità, mentre nel registro inferiore Dolphy emette un tono più tormentato e sofferente rispetto a quello che si è abituati a sentire da un clarinetto basso. Nel complesso «Outward Bound» è un disco estremamente espressivo e rimane, tutt’oggi, attualissimo e caratterizzato da qualche punta di virtuosismo. Come tutti di lavori Dolphy, a volte, è spigoloso con alcuni passaggi e ritmi discordanti, ma raggiunge una profondità abissale a livello di lirismo; mentre la creatività diventa il messaggio, oltre ad essere il mezzo espressivo. L’album è il primo OUT verso un’inedita concezione del jazz, una finestra su un mondo nuovo, misterioso e da esplorare, all’interno del microcosmo di un artista irrequieto, di cui non conosceremo mai quale sarebbe stato realmente l’OUT finale.