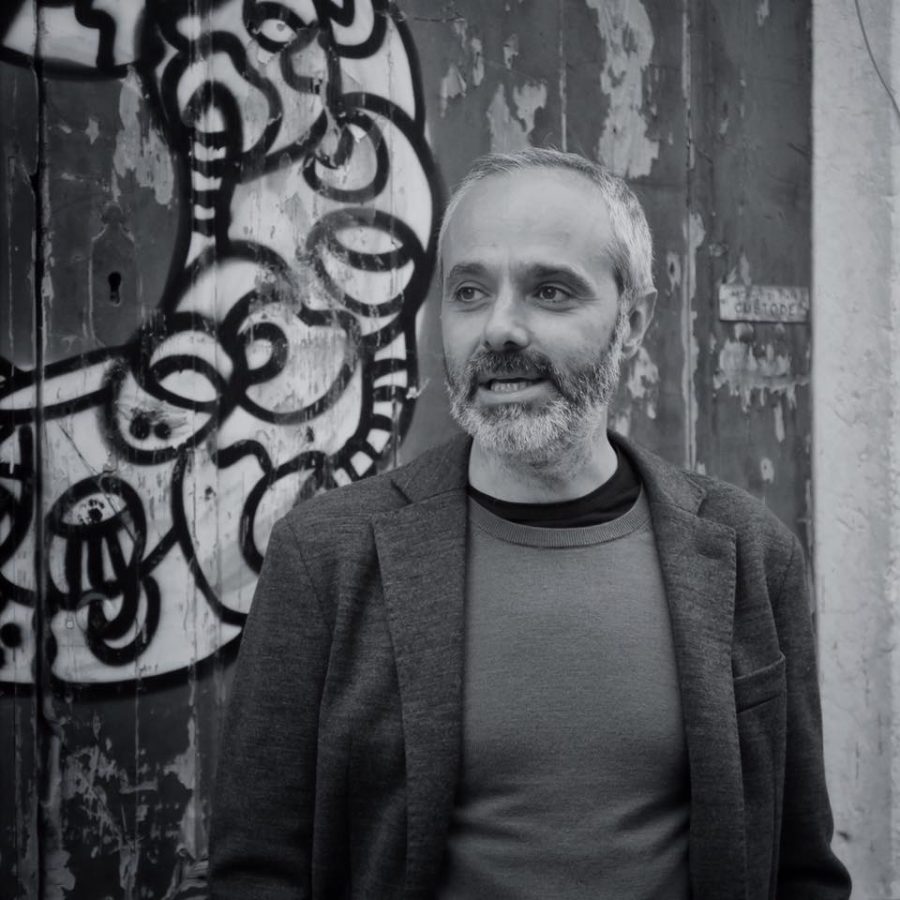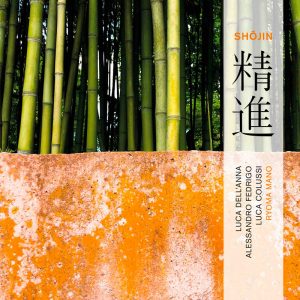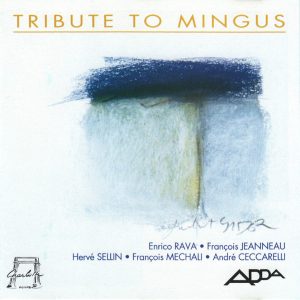Il jazz, fra storia e cultura secondo Enrico Bettinello: acquisire la complessità di una tradizione

Enrico Bettinello
di Guido Michelone
R In una comunicazione privata mi hai detto che ti occupi di molte cose relative al jazz. Evidenziandone almeno cinque – formazione, curatela, progettazione, critica e ricerca – vogliamo affrontarle?
D È più semplice – e forse anche comprensibile – raccontare in breve come ho iniziato a occuparmi di molti aspetti legati al jazz e alle pratiche musicali (e performative) in generale. Dopo avere studiato jazz, a Venezia e a Siena, ho iniziato a scrivere per Jazzit nel 1999 e da allora ho scritto e scrivo (sebbene con minore intensità rispetto a qualche anno fa) per tante testate tra cui BlowUp, il Giornale della Musica, Musica Jazz, Gli Stati Generali, Il Corriere del Veneto, nonché per Radio3 RAI e la Rete 2 Svizzera. Parallelamente ho iniziato a occuparmi di organizzazione, direzione artistica e curatela, dirigendo il Teatro Fondamenta Nuove di Venezia (dal 2008 al 2013) e curando molti progetti tra cui il San Servolo Jazz Meeting, Set Up a Punta della Dogana, nonché, attualmente, dirigendo il Centro di Produzione WeStart di NovaraJazz, come consulente del Centro Santa Chiara a Trento e Rovereto e curando il progetto New Echo System per Pro Helvetia a Venezia. Dal 2015 ho iniziato a occuparmi anche di jazz e di consulenza a livello internazionale, sedendo nel Board di Europe Jazz Network per sei anni e curando per I-Jazz, l’associazione italiana dei festival, il progetto Nuova Generazione Jazz di supporto ai giovani talenti. Dal punto di vista didattico, attualmente insegno “Elements of Theatre and Live Art Production” all’Università Ca’ Foscari di Venezia, “Music Production” al master dell’Università Cattolica di Milano, nonché “Storia del Jazz” al Conservatorio di Venezia.
D Hai provato a essere sintetico e ci sei riuscito perfettamente…
R Volevo dare una panoramica di queste attività, non tanto per il piacere di snocciolare un curriculum, quanto per provare a restituire quanto, nel mio caso, queste attività siano in totale dialogo tra loro. Per fare un esempio banale, lavorare come critico mi ha fornito tutta una serie di strumenti fondamentali per provare a essere un curatore che ragiona in modo innovativo, così come il lavorare a stretto contatto con tutte le sfaccettature delle professioni jazzistiche in Italia mi ha dato l’opportunità di scrivere spesso anche di argomenti (i finanziamenti, le strategie, la politica culturale) che spesso sono poco battuti negli articoli di jazz. Diciamo che, un po’ come il buon indovino Tiresia che tutto provò, sapere come funziona l’organizzazione di una rassegna e anche quali sono i meccanismi della produzione, credo mi abbia aiutato a inquadrare le tante tematiche del jazz di oggi dentro una cornice contestuale più articolata. I temi su cui mi sono di più concentrato sono certamente quelli della produzione (attraverso la pratica della residenza creativa e provando a immettere in un contesto spesso vissuto alla giornata e dispersivo, degli strumenti di maggiore progettualità) e della transdisciplinarietà, aprendo dei canali di dialogo con il mondo della coreografia e altre discipline. Come studioso e come curatore, sono poi fondamentalmente interessato ai meccanismi di fruizione, al ruolo del pubblico, alle relazioni spaziali e fisiche tra performer e spettatore. Come scrittore, mi concentro ormai prevalentemente su articoli e saggi più articolati e non scrivo quasi più le “classiche” recensioni, che trovo del tutto superate, specialmente se non aprono a altre riflessioni.
D Il primo ricordo che hai della musica? E il primo del jazz?
R In casa si è sempre ascoltata molta musica, classica e cantautori in particolare, ma c’erano anche alcuni dischi di jazz di mio papà, che ascoltavo in modo del tutto spontaneo, senza nemmeno chiedermi se fossero jazz o “altro” da altri generi, un’attitudine aperta verso l’ascolto che credo mi sia sempre rimasta. Forse i primi ricordi sono di qualche disco di De André ascoltato in salotto, ma avevo anche un mangiadischi arancione in cui potevano finire i Kiss o i New Trolls! Tra i dischi jazz di mio papà c’erano (ci sono ancora) alcuni vinili di Miles Davis e di Coltrane che ascoltavo con piacere. Tra l’altro Workin’ with the Miles Davis Quintet era in una versione stampata dall’italiana Celson, con una statuetta sarda in copertina e ho scoperto solo dopo anni che la copertina originale era un’altra, ma soprattutto che quel vinile che ascoltavo, magari senza nemmeno troppi riguardi, era tra i dischi più ricercati dai collezionisti!
D Come matura e si alimenta la tua passione per il jazz?
R Matura e si alimenta in modo del tutto naturale nella tarda adolescenza, grazie all’amicizia con Alberto, un coetaneo che fa tutt’altro mestiere oggi e che ho anche citato nei ringraziamenti del mio libro “Storie di jazz”, uscito per Arcana nel 2015; a lui devo le prime cassette di Bill Evans, di Mingus, le prime infatuazioni, le prime discussioni animate. E poi i primi concerti da spettatore e l’attività come musicista, sebbene sempre a livello locale. Ho iniziato a comprare un sacco di dischi e andare nei club e ai concerti e mi ha affascinato subito molto la varietà e la ricchezza di questa musica. Ma, come ti raccontavo prima, non c’è mai stata, nemmeno negli anni più intensi di passione giovanile, un’ossessione esclusiva. Andavo anche all’opera, mi piaceva il rock, l’elettronica, la contemporanea colta, la musica italiana, la musica di altre tradizioni, quella brasiliana in modo particolare e mi è sempre piaciuto arricchirmi della diversità e delle relazioni tra queste pratiche, più che dedicarmi solo a una. Anche se, a calcolare le ore che ho dedicato al jazz, si direbbe forse il contrario…
D Sei stato anche musicista: come ti vedi ora dall’altra parte della barricata?
R Sì, come ti dicevo, ho suonato per anni il piano jazz, anche decentemente forse, frequentando i Corsi Estivi di Siena Jazz, studiando con Pieranunzi, D’Andrea, Schiaffini e Stefano Zenni, ma senza mai che questo aspetto assumesse la forma di una carriera artistica professionale. Quanto alla barricata, non esiste. Esiste una comunità, delle comunità, nelle quali si ergono spesso delle barricate, ma in fondo il mondo della musica è un ecosistema, complesso quanto vuoi, ma sarebbe riduttivo pensare che esistano le artiste e gli artisti da una parte e il resto del mondo dall’altra. Sono felice di avere avuto modo di costruirmi un percorso professionale in un ambito che era ed è anche una mia passione, che mi consente di portare un contributo che probabilmente, anzi direi quasi certamente, come ennesimo mediocre pianista jazz non avrei potuto portare.
D Possiamo nel 2024 parlare di jazz? Ha ancora un senso oggi la parola jazz?
R Sì, perché non dovremmo poterne parlare? Proprio in quanto curatore e critico che non si è mai mosso all’interno delle etichette e delle categorie in modo dogmatico, a me la parola non crea nessun problema. Esiste ormai una vasta tradizione di studi sulla ricezione del jazz e delle musiche afroamericane in cui la problematizzazione del termine, spesso forzato ideologicamente verso un essenzialismo che non gli appartiene, è stata serenamente affrontata. E’ evidente che i linguaggi e le pratiche che accogliamo sotto questo ombrello definitorio sono vari e vasti, così come è chiaro a tutti, a meno di non volersi intestardire in atteggiamenti anacronistici, che i musicisti e le musiciste più giovani tengono in una considerazione davvero marginale la classificazione delle musiche per generi. Una musicista jazz oggi è, sperabilmente, un’artista nel cui mondo sonoro entrano influenze e lessici di ogni genere. In parte lo è sempre stato, ma aveva forse un senso identitario differente provare a dire che non era così, trovare una collocazione più definita. Oggi è interessante piuttosto lavorare attorno alla morfologia stessa della parola jazz, alla sua capacità di accogliere, di sviare, di raccontare delle ipotesi di pratica prima ancora che di linguaggio. Ma sì, ha certamente un senso.
D E si può parlare di jazz italiano? Esiste qualcosa di definibile come jazz italiano?
R Certo che si può, sempre che la definizione non voglia irrigidire un processo dentro un esame del DNA che darebbe pure esiti sorprendenti. Esiste il jazz praticato da musiciste e musicisti italiani, esiste un jazz organizzato e fruito in Italia, con dinamiche e gusti che non necessariamente coincidono con quelli di altre nazioni europee. Esiste una tradizione ormai lunga e solida, dei maestri, un sistema – per quanto ancora fragile in molte sue componenti – insomma c’è un’Italia del jazz che è giusto anche si riconosca in una definizione, necessariamente ampia e inclusiva. Poi, lavorando a contatto con colleghe e colleghi europei, mi sono reso conto di quanto esista per molti un’immagine percepita del jazz italiano, spesso riduttiva rispetto alla ricca varietà dei percorsi creativi praticati. Perché se da un lato la crescente professionalizzazione delle strutture formative fa sì che in Italia, come nel resto dell’Europa, emergano ogni anno figure artistiche tecnicamente e espressivamente complete e capaci di padroneggiare linguaggi trasversali, inevitabilmente qualcuno può in buona fede aspettarsi un “sapore” nazionale da una scena.
D Cosa distingue, secondo te, l’approccio al jazz di americani e afroamericani da noi europei?
R È una questione riduttiva, nel senso che in un mondo globalizzato convivono approcci differenti anche all’interno della stessa scena americana o di quella europea. I sistemi di produzione e di circuitazione sono molto diversi, sicuramente negli Stati Uniti la forza di una tradizione formalizzata unita al pragmatismo della società concorrono a un interessante “elastico” dinamico che però non si deve curare troppo – e in parte è un limite – del “resto del mondo”. In ambito Europeo ci sono sistemi di supporto e aspettative molto diverse, così come esistono linguaggi originali che devono comunque “convivere” – nei cartelloni, nello storytelling – con un modello di riferimento forte da cui non è facile prendere le giuste distanze, anche quando le pratiche sono chiaramente molto differenti. E anche questo in parte è un limite. Ma in fondo si tratta di questioni che ascoltatrici e ascoltatori che hanno vent’anni nemmeno si pongono e temo che a volte mentre ci sforziamo di dare risposta a questi dubbi, la realtà corra molto più veloce e ci superi da destra, come si dice.
D Il jazz deve parlare, attraverso i suoni, di temi sociali, politici, ambientali, filosofici?
R Non è un dovere, è una possibilità. Che secondo me – se percorsa con consapevolezza – ha anche il merito di tenere le artiste e gli artisti legate alle urgenze del proprio tempo. Non è ovviamente semplice farlo in modo efficace e non didascalico e deve essere un’esigenza che si sente davvero, ma credo, al di là degli slogan, che ne gioverebbe tutto il sistema, così come accade nel mondo della danza e delle arti performative, che su queste urgenze costruiscono progettualità molto incisive e in grado di raggiungere nuove comunità di spettatori e spettatrici.
D Come vivi tu in Italia la vita di docente di Storia del jazz in Conservatorio?
R A me insegnare piace, mi piace all’Università e al Conservatorio e imparo sempre tante cose, oltre a provare a trasmetterle. Come dico sempre agli studenti, la Storia del Jazz è, per chi si appresta a diventare professionista, non solo e non tanto un fatto di conoscenza storico-analitica, quanto una componente irrinunciabile della propria identità come musicista. Studiamo insieme non tanto per sapere chi suonava in quel disco di Horace Silver o come si chiamava il trombonista di Count Basie, ma per acquisire la complessità di una tradizione che è sempre in dialogo creativo con se stessa. La storia del jazz ha una serie di limiti di sistematizzazione – in cui la struttura “evoluzionista” di quasi tutte ne narrazioni tende a oscurarne l’articolata multidimensionalità – e mi piace a volte provare a fornire delle prospettive più oblique, che sorprendono gli studenti, ma mi sembra li stimolino anche a una minor passività. E poi si ha il vantaggio di riascoltare insieme tanti capolavori, cosa che rende quelle ore meno pesanti. Ma forse dovresti chiederlo a chi segue le lezioni…
D Cosa ne pensi dell’attuale situazione in cui versa la cultura italiana (di cui il jazz ovviamente fa parte da anni)?
R Avendo insegnato in passato sociologia della cultura e proprio per carattere, ho la tendenza a non generalizzare. E cerco di fare sempre molta attenzione a non abbandonarmi a nostalgie o insofferenze eccessive. Premesso questo, se per “cultura” vogliamo intendere le idee e le strategie che vengono messe in campo a livello di politica culturale, non credo sia difficile immaginare che si possa fare di più e di meglio (le percentuali del rapporto tra spesa pubblica in cultura e PIL pongono l’Italia tra i fanalini di coda in Europa). Se invece guardo al quadro generale, preferisco concentrarmi sulle tante iniziative che si pongono tra le best practices e che attivano territori, idee e produzione. E che restituiscono una vitalità che credo vada seguita, supportata e in qualche modo protetta dalle oggettive difficoltà che il sistema presenta. Non lo dico per buonismo, sia chiaro – mi sono ben evidenti molti limiti e storture, a partire dal sistema didattico – ma proprio perché il tempo che ho mi piace dedicarlo a costruire e a supportare chi prova a costruire.