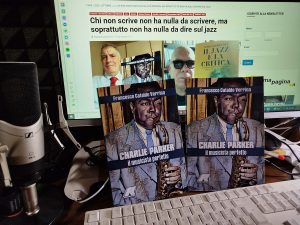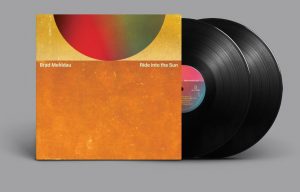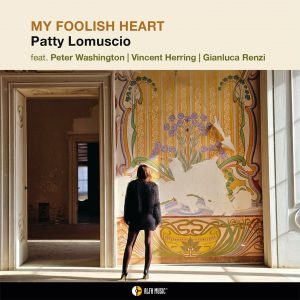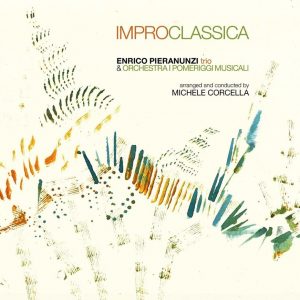Claudio Fasoli con «Lido»: un album che non si chiude in una forma, ma si propaga (Soul Note, 1983)

Nel complesso, l’album si radica in una geografia sonora capace di assorbire influenze e trasformarle. La presenza di Kenny Drew introduce una dimensione storica che si avvita alla ricerca formale di Fasoli; Pedersen opera come un controller che orienta il discorso; Altschul apporta una pulsazione costantemente espansiva. La circolarità del line-up sancisce un equilibrio instabile, finalizzato alla tensione costruttiva dell’impianto che si evolve in progressione.
// di Francesco Cataldo Verrina //
«Lido» di Claudio Fasoli s’innesta in una scena jazz europea attraversata da idiomi afroamericani e grammatiche locali, generando una pluralità di linguaggi che si stratificano sedimentandosi, si contaminano come pigmenti esterni, trasformandosi in materia viva che reagisce. Negli anni ’80, il jazz italiano elaborò una forma espressiva che privilegiava la precisione timbrica, la continuità del pensiero e la capacità di costruire senza ostentare. Il sassofonista veneziano s’inserì in tale contesto proponendo una logica compositiva che si sviluppa per sovrapposizione, per deviazione e per intensificazione. Il suo stile si distinse subito per una scrittura che si prolungava come linea non tesa ad un punto d’arrivo, ma alla tensione del percorso, mentre la scena internazionale si frammentava in direzioni divergenti: l’ipertecnicismo fusion, la radicalità del free e la riflessione timbrica dell’ECM. Fasoli attraversò queste traiettorie come un viaggiatore che non raccoglie souvenir, ma assorbe atmosfere.
Lungo le coste sonore tracciate da Claudio Fasoli nell’album «Lido», registrato il 22 ed il 24 febbraio del 1983, al Barigozzi Studio di Milano, prende corpo una sintassi vibrante. Il sassofono procede con decisione, modellando un lessico lirico che si mantiene teso tra rigore ed immaginazione, come una corda che non si spezza, ma risuona. Ogni frase si distende con precisione, ciascuna nota si afferma con lucidità e qualunque pausa si dischiude come soglia che trattiene. Fasoli, affiancato da Kenny Drew, Niels-Henning Ørsted Pedersen e Barry Altschul, conversa con la sezione ritmica alla stregua di un esploratore che non cerca appoggio, ma orientamento, tramutando il dialogo in soluzione e la risposta in struttura. Il sassofonista leader emette un linguaggio che si propaga lentamente, diffondendo una luce che oltrepassa una superficie traslucida, la quale lascia dietro di sé una trama di riflessi. Dal canto loro, le sezioni si rincorrono senza urgenza, accatastandosi come strati di sabbia spinti dal vento. Il portato melodico si dipana in virtù di pensiero aerobico che si rapprende, evitando le scorciatoie, dissolvendo le opposizioni e rifiutando ogni decorazione superflua. L’improvvisazione si manifesta alla stregua di una composizione istantanea, dove ogni nota si dispone con intenzione e qualsiasi pausa genera spazio critico, quale interpunzione pensante. Scorrendo le tracce, affiora una continuità che si appoggia sulla capacità di variare senza smarrire la bussola, con una pulsazione che sostiene senza gravare, come un fondale che regge senza ingombrare, reinventando il punto di confluenza strumentale, convertendolo in sintassi urbana. Kenny Drew interviene con un tocco che orienta senza ostentare, contribuendo ad una fluidità che s’infila tra le fenditure del discorso, come la corrente di un fiume inquieto che modella le rocce. Niels-Henning Ørsted Pedersen imposta il contrabbasso come struttura mobile e portante al contempo, generando un sostegno stabilizzante. Dal canto suo Barry Altschul modella il groove con precisione scultorea, trattando la percussione quale materia malleabile e superficie vibrante. Avanzando nel disco, si riconosce una scrittura che ripensa la forma, generandola dall’interno. Fasoli assembla senza voler dimostrare, lasciando che ogni assolo si sviluppi per necessità, evitando dispersioni e mantenendo una ratio strutturante. La sua perifrasi sonora include il silenzio, lo assorbe, rendendolo parte della narrazione, quasi una pausa che non interrompe, ma intensifica. Ad abundantiam, Il sassofonista procede tracciando percorsi evocativi, lasciando che il suono suggerisca più di quanto dichiari, mentre il suo fraseggio s’innalza. Egli, però, non punta alla simmetria, ma distilla tensione, mentre la fisionomia acustica si conforma come una pietra levigata dall’acqua. «Lido», nel suo insieme, sancisce un sistema coerente e la mappa critica di un pensiero jazzistico che rifiuta la superficie e mira allo scandaglio, promulgando un esempio raro di come la musica possa diventare laboratorio di sintassi ed esercizio di lucidità.
La facciata A si apre con «Snob» che si annuncia come una fenditura nel silenzio, una crepa che lascia filtrare una luce obliqua. Fasoli imposta il sassofono come uno scalpello che incide la pietra del tempo, mentre il fraseggio si allunga similmente ad un’ombra su un muro antico ed il timbro si definisce come metallo battuto. Drew interviene con armonie che si dispiegano come lenzuola stese al vento, la mano sinistra affonda alla stregua di una radice nel terreno armonico, mentre la destra traccia sentieri che si intrecciano come rami. Pedersen scolpisce la vibrazione come un cesello su legno vivo, dove ogni nota si afferma come passo su un sentiero nascosto. Altschul modella il ritmo alla stregua di un ceramista che conforma l’argilla: il ride vibra come superficie d’acqua e dai tom emergono rilievi montuosi. «Lyrical Touch» si volatilizza come brezza che attraversa una stanza chiusa. Fasoli modula il suono, usando la tecnica di un un pittore che sfuma i contorni; il vibrato si trattiene, quasi come un respiro prima del canto, il legato si estende alla maniera di un filo che cuce lembi di memoria. Drew costruisce l’armonia nei panni di un architetto che disegna ponti sospesi, in cui ogni accordo si apre come un portale e qualunque arpeggio s’inabissa similmente ad corrente sotterranea. Pedersen, con l’arco, genera una voce che si avvicina al canto umano, al punto che la profondità s’illumina come un pozzo che riflette il cielo. Altschul, con le spazzole, cesella il tempo con la precisione di incisore su rame, dove ogni colpo diviene un dettaglio. «Etna» si sviluppa per stratificazione geologica, simile ad un magma che fermenta sotto la crosta. Fasoli plasma il tema da intagliatore che lavora il basalto, in cui gli intervalli discendenti precipitano a valle come colate laviche, mentre il timbro s’ispessisce ricordando la roccia fusa. Drew imbastisce cluster armonici che ricordano vestigia in rovina, su cui le mani si muovono fungendo da scavatori tra le macerie. Pedersen disegna la linea di basso, alla medesima stregua di un geologo che traccia faglie, mentre qualsiasi nota si radica come minerale. Altschul interviene con rullate che liberano verticalmente esplosioni controllate, grazie alle quali il groove si sedimenta come cenere ed il tempo si trasforma in materia incandescente. «Lido» emerge come un istmo che collega due rive, quale ponte sospeso tra memoria ed invenzione. Fasoli lascia affiorare il tema come fotografo che sviluppa un’immagine in camera oscura, mentre il registro medio diventa luogo di riflessione, e la melodia fluisce come una corrente marina. Drew articola il pianoforte con la tecnica di un cartografo che disegna coste frastagliate, mentre gli accordi si aprono come baie ed il silenzio entra come marea. Pedersen galleggia tra le armonie con la leggerezza di una nuvola che riflette il tramonto, mentre la profondità muta in direzione. Altschul sospende il tempo con la cautela di un equilibrista su filo teso, facendo in modo che la vibrazione si dirami come un’eco in una cattedrale.
La title-track «Lido» è simile ad hub che collega. Il tema emerge gradualmente, come se fosse già presente, in attesa di essere riconosciuto. Fasoli utilizza il registro medio per costruire una melodia che si staglia con eleganza, in cui ciascuna frase si dispone in maniera lineare ed ogni nota sembra ambisce al diritto di parola. Drew articola il pianoforte con accordi aperti, lasciando che il silenzio diventi parte del tema, mentre ogni movimento si deposita nel contesto con misura e ciascuna pausa si carica di significato. Pedersen costruisce una linea di basso che cammina con leggerezza, mentre Altschul modella il tempo con variabili sospese, dove ogni battito alimenta il funzionamento del sistema operativo. «Map» si sostanzia come una traiettoria instabile. Fasoli annoda linee che si rincorrono, generando un’architettura che cresce per accumulo, in cui qualunque frase si diventa in una svolta ed ogni pausa un bivio. Drew frammenta il fraseggio, lo ricompone e lo espande, mentre le sue mani si muovono con fluidità, disponendo ogni accordo quai fosse uno snodo. Pedersen disegna traiettorie che si dimenano tra i vari registri, dove il walking-bass procede tra variazione e deviazione. Altschul lavora con il charleston aperto, generando un battito che s’integra nella narrazione con precisione ed intensità. «Jazz Job» distilla il discorso, lo rilancia e lo converte in sintesi. Fasoli articola il tema con chiarezza, mentre ogni frase si attesta come pensiero compiuto; Drew costruisce un accompagnamento che si sposta tra swing ed impressionismo; Pedersen secerne una linea di basso che si colloca con precisione nel parenchima sonoro; dal canto suo Altschul utilizza il tamburo come centro ritmico, lasciando che ogni colpo divenga un richiamo, mentre il tempo si fa struttura e la percussione muta in sintassi. Nel complesso, l’album si radica in una geografia sonora capace di assorbire influenze e trasformarle. La presenza di Kenny Drew introduce una dimensione storica che si avvita alla ricerca formale di Fasoli; Pedersen opera come un controller che orienta il discorso; Altschul apporta una pulsazione costantemente espansiva. La circolarità del line-up sancisce un equilibrio instabile, finalizzato alla tensione costruttiva dell’impianto che si evolve in progressione.