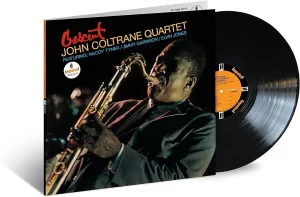Donald Byrd, l’arte della tromba dialogica: estetiche, interazioni e metamorfosi stilistiche, dal bop al soul-funk

Donald Byrd
Fino alla scomparsa, avvenuta il 4 febbraio 2013, Byrd mantenne viva una concezione del fare musica come processo di continua trasformazione, resistendo alla cristallizzazione in uno stile univoco. La sua eredità risiede non soltanto nella molteplicità di album incisi, ma nella capacità di attraversare con coerenza epoche, linguaggi e pubblici differenti, incarnando un’idea di musicista moderno come figura poliedrica, intellettualmente vigile ed artisticamente inesausta.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Donald Byrd ha tracciato una traiettoria artistica che, più di molte altre nel jazz del secondo Novecento, riflette l’irrequietezza di chi rifiuta la clausura stilistica per abbracciare una continua metamorfosi linguistica. Formatasi nelle aule severe della Cass Technical High School di Detroit e poi forgiata nell’esperienza universitaria ed orchestrale, la sua tromba, sin dagli esordi accanto ad Art Blakey e ai Jazz Messengers, manifestava una chiarezza di fraseggio che sembrava attingere tanto alla retorica di Clifford Brown quanto ad un’urgenza comunicativa più terrena, intrisa di swing urbano e vigore afroamericano. Non vi è in lui il compiacimento calligrafico del mero virtuoso, ma una tensione narrativa che ricorda certi movimenti di macchina di Orson Welles: improvvisi cambi di prospettiva, campi lunghi e dettagli ravvicinati, luci ed ombre in drammatico equilibrio. Donaldson Toussaint L’Ouverture Byrd II, nato il 9 dicembre 1932 a Detroit, incarna una delle menti più eclettiche e trasversali della tromba jazzistica, capace di attraversare con consapevolezza e perizia stilistica territori apparentemente eterogenei: dal bebop ereditato dai maestri newyorkesi alla sperimentazione elettrica degli anni Settanta, senza trascurare un impegno intellettuale rivolto alla formazione accademica e alla trasmissione pedagogica del linguaggio afroamericano. Byrd compì il proprio apprendistato professionale in un contesto già proiettato oltre l’ortodossia parkeriana, tanto che la produzione discografica per la Blue Note, da «Byrd In Hand» (1959) a «Free Form» (1961), sancisce una progressiva apertura verso strutture meno convenzionali.
Negli anni Sessanta, mentre molti colleghi consolidavano il proprio lessico, Byrd si avventurava verso un orizzonte modale e hard bop di declinazione personale, affine per certi aspetti alla poetica di Hank Mobley o di Herbie Hancock, con il quale intrecciò un sodalizio decisivo. In opere come «A New Perspective» (1964) la tromba si pone come protagonista di un oratorio secolare, dove il coro gospel diventa una sorta di coro tragico sofocleo, sospeso fra sacro e profano, amplificando la dimensione rituale della musica. Quella fusione di spiritualità e modernità suggerisce una sensibilità affine alla pittura di Aaron Douglas, in cui figure stilizzate emergono da campi cromatici densi di significati storici e culturali. Il decennio successivo lo vide, come un viaggiatore omerico, spingersi oltre le Colonne d’Ercole del jazz acustico per approdare a territori elettrificati, dove funk, soul e proto-fusion si mescolavano in architetture sonore dal forte impatto fisico. Dischi come «Black Byrd» (1973) e «Places And Spaces» (1975), nati dalla collaborazione con i Mizell Brothers, rivelano una sapienza produttiva quasi cinematografica: come in un montaggio di Sergej Ėjzenštejn, i motivi si susseguono per attrito e contrappunto, costruendo una tensione che non si risolve mai del tutto, sospesa fra il piacere immediato della danza e una più sottile riflessione sociale. L’uso delle sezioni di fiati, filtrate da arrangiamenti levigati ma incisivi, assume una funzione scenografica, quasi fossero quinte teatrali dietro cui si muove una coreografia collettiva. Il Byrd docente universitario, attento alla formazione delle giovani generazioni, testimonia un legame organico fra pratica e trasmissione del sapere. La sua attività pedagogica, sviluppata parallelamente alla carriera discografica, non fu un’appendice, bensì parte integrante del progetto culturale, ossia rendere il jazz una lingua viva, permeabile a influssi molteplici, e restituirlo alla comunità afroamericana come strumento di emancipazione e autoaffermazione. In questa prospettiva, Byrd non appare soltanto come un trombettista innovatore, ma come un intellettuale della diaspora nera, capace di leggere i segni del proprio tempo e tradurli in un linguaggio sonoro in perpetuo mutamento. Se si volesse collocare la sua parabola in una cornice iconografica, si potrebbe pensare a un trittico: l’incipit luminoso e vigoroso dell’hard bop, la parte centrale intrisa di spiritualità e sincretismo, l’epilogo elettrico e funk come approdo in un porto cosmopolita. In ogni fase, la tromba di Byrd agisce come una voce narrante, ora lirica, ora abrasiva, talvolta seduttiva, capace di muoversi fra tradizione e avanguardia con la naturalezza di chi considera il confine non una barriera, ma una soglia da attraversare.
Il percorso di Donald Byrd, pur intrecciandosi con la storia complessiva della tromba jazzistica, si distingue per un rapporto peculiare con il tempo storico e con le modalità di ibridazione stilistica. Rispetto a Freddie Hubbard, suo quasi coetaneo e compagno di alcune avventure discografiche, Byrd condivide la perizia tecnica, il fraseggio nitido e l’inclinazione all’improvvisazione modulare, ma se Hubbard tendeva a proiettare la propria energia in una direzione ascensionale, talvolta eroica e teatrale, Byrd preferiva una costruzione più narrativa, dove il climax si raggiungeva per accumulo di dettagli e microvariazioni, come in un romanzo di Toni Morrison che disvela il senso attraverso stratificazioni sottili. Clifford Brown, pur prematuramente scomparso, rappresentava un modello di chiarezza timbrica e di purezza melodica che Byrd assimilò solo in parte, rifiutandone l’assoluta linearità in favore di un uso più obliquo delle pause e di certi accenti spiazzanti, vicini a quelli che Woody Shaw avrebbe sviluppato negli anni successivi. Con Shaw condivideva, inoltre, un gusto per l’inatteso, per il «fuori registro» che, lungi dall’essere mero esercizio virtuosistico, assumeva valore drammaturgico. Se si considerano i coevi bianchi, ad esempio Lee Morgan – che pur era afroamericano – non rientra in questa distinzione, ma possiamo confrontare Byrd con musicisti come Art Farmer e Chet Baker. Farmer, con la sua eleganza sorvegliata e l’approccio quasi cameristico al fraseggio, costituiva una sorta di contrappunto estetico: dove Byrd tendeva a plasmare ampie arcate narrative ed a cercare l’innesto fra idiomi differenti (dal gospel alla fusion), Farmer rimaneva ancorato a un lirismo misurato, come una scena dipinta da Vermeer, ordinata nella composizione ed attenta alla luce più che al moto convulso. Chet Baker, invece, percorreva sentieri ancora più introspettivi, scolpendo linee melodiche di una fragilità quasi vocale, mentre Byrd, pur non rinunciando alla cantabilità, mirava ad un impatto più assertivo, in grado di reggere anche le architetture funk e le orchestrazioni corali. Un altro parallelo illuminante si potrebbe tracciare con Maynard Ferguson, il quale spingeva la tromba verso vette acrobatiche e spettacolari, quasi barocche. Byrd, pur capace di simili slanci, non fece mai dell’acuto estremo o dell’esibizione atletica un feticcio, ma la sua era piuttosto una ricerca di contesto e di funzione, simile a un regista che sceglie l’inquadratura non per la sua virtuosità formale, ma per la necessità narrativa della scena. In sintesi, mentre molti dei suoi contemporanei – afroamericani e non – sviluppavano un linguaggio riconoscibile e relativamente stabile, Byrd trattava la tromba come un medium capace di attraversare mondi sonori diversi senza mai perdere il filo della propria identità, una sorta di Ulisse musicale per cui il viaggio e la trasformazione costituivano l’essenza stessa dell’opera.
Se si volesse collocare Donald Byrd entro un orizzonte comparativo europeo e italiano, il discorso richiederebbe una certa cautela, poiché la sua parabola – dall’hard bop accademicamente rigoroso, alla sperimentazione gospel-corale, fino alla fusione funk e soul – non trova un corrispettivo diretto nel vecchio continente. Tuttavia, alcune affinità di metodo, attitudine o sensibilità possono essere rintracciate. Sul versante europeo, dove l’inglese Ian Carr offre forse il parallelo più stimolante. Anch’egli formatosi in un contesto rigoroso, attivo tanto come strumentista quanto come docente e divulgatore, Carr univa un linguaggio jazzistico solido ad una curiosità per la contaminazione con il rock, il funk e le avanguardie orchestrali. Album come «Belladonna» (1972) o il percorso con i Nucleus testimoniano un analogo desiderio di connettere idiomi afroamericani e pulsazioni urbane di matrice europea, pur con un impianto armonico e timbrico meno legato al gospel e più filtrato da atmosfere psichedeliche. In Francia, François Chassagnite o, ancor più, il lavoro di Michel Portal (pur non trombettista) mostrano un’analoga disponibilità a far dialogare discipline e linguaggi, con un’attenzione alla dimensione comunitaria e all’educazione musicale che rimanda all’impegno accademico di Byrd. In Germania, Manfred Schoof rappresenta un altro caso pertinente, tanto che il suo percorso, radicato nella free improvisation e nella musica contemporanea, condivide con Byrd il rifiuto di cristallizzarsi in un unico stile e la tensione a creare architetture sonore in cui la tromba non sia semplice protagonista solistica, ma elemento immerso in un disegno più ampio, quasi scenografico. Sul piano italiano, il confronto diretto appare più complesso, poiché il contesto socio-culturale del jazz nostrano negli anni ’60-’70 aveva meno contiguità con le matrici funk e soul.

Il raffronto fra Donald Byrd e Fabio Morgera apre un campo di osservazione interessante proprio perché non si tratta di un parallelismo immediato, ma di un incontro a distanza, scandito da coordinate storiche, geografiche e culturali assai diverse. Byrd è un protagonista interno al cuore pulsante della black music statunitense, formatosi negli anni ’50 in un ambiente in cui il jazz, il gospel e il rhythm & blues erano parte di un unico ecosistema sociale. Morgera, pur assorbendo a fondo il linguaggio afroamericano e immergendosi a lungo nella scena newyorkese, proviene da un’Italia che, negli anni della sua formazione, viveva il jazz come fenomeno soprattutto d’importazione, mediato da festival, tournée di artisti stranieri e un numero limitato di contesti locali realmente connessi con le comunità afroamericane. L’affinità più evidente sta nell’attenzione alla componente soul-funk: Byrd, specialmente nel periodo dei ’70 con i Mizell Brothers, non si limita a «colorare» il jazz con groove funk, ma ne fa il baricentro ritmico e timbrico, integrando sezioni di fiati compatte, linee di basso pulsanti e un uso scenografico degli arrangiamenti, come in un film di Gordon Parks dove l’energia della strada diventa materia estetica. Morgera, pur con mezzi e contesti produttivi differenti, dimostra una simile capacità di muoversi in territori dove il jazz incontra il funk e il soul, specie nei progetti in cui la sua tromba si inserisce con naturalezza in ensemble dalle sonorità calde, ritmicamente stratificate, spesso pensate per un’interazione diretta con il pubblico. Le differenze stilistiche, tuttavia, sono marcate. Byrd si muove lungo una parabola che lo porta dall’hard bop accademicamente strutturato alle aperture fusion, mantenendo sempre un solido ancoraggio al linguaggio bebop e post-bop, e sviluppando un suono lucido, incisivo, con un attacco spesso netto e una scansione ritmica da narratore urbano. Morgera, invece, pur padroneggiando i codici del bop, tende a una pronuncia più elastica, a volte più vicina alla conversazione che alla declamazione, con una duttilità timbrica che gli consente di passare da contesti acustici a situazioni elettriche senza perdere una certa fluidità mediterranea. Sul piano spazio-temporale, Byrd risulta immerso nel crocevia degli Stati Uniti anni ’60-’70, quando le tensioni sociali, le trasformazioni urbane e il ruolo crescente delle etichette black-oriented influenzavano direttamente le scelte artistiche. Morgera, al contrario, si forma e si afferma in un’epoca di globalizzazione musicale, dove l’accesso alle fonti e la mobilità geografica permettono di assorbire linguaggi senza viverne necessariamente l’humus originario. In questo senso, se Byrd è un testimone interno della stagione d’oro del soul-funk, Morgera ne è un interprete transnazionale, capace di portare quell’idioma in territori italiani ed europei senza che perda la sua energia primaria.
Il rapporto di Donald Byrd con il soul-funk non si manifesta come semplice episodio di contaminazione, ma come un vero e proprio approdo estetico e politico. Dopo un decennio di rigore hard bop e di aperture modali, la svolta dei primi anni ’70 – in particolare con Black Byrd (1973) e le successive collaborazioni con i Mizell Brothers – trasforma la tromba in un elemento scenico all’interno di un paesaggio sonoro in cui basso elettrico, chitarre wah-wah e groove sincopati assumono la funzione di «motore narrativo». Byrd vi agisce non tanto come solista in senso tradizionale, ma come orchestratore della propria voce strumentale: le frasi brevi ed incisive, si inseriscono in un dialogo fitto con sezioni di fiati e tastiere elettriche, richiamando la logica dei call and response gospel ma filtrata dalla grammatica della musica urbana afroamericana. In questo contesto, la tromba diventa un mezzo di affermazione identitaria e di appartenenza comunitaria, aderendo pienamente all’immaginario sonoro che, nella cultura black, univa intrattenimento e consapevolezza politica. Fabio Morgera, pur mosso da una radice culturale e geografica differente, ha saputo declinare la tromba in un territorio soul-funk secondo coordinate proprie. Inseritosi nella scena newyorkese tra anni ’80 e ’90, in una fase in cui il jazz viveva un rinnovato dialogo con l’R&B, l’hip-hop nascente e le riletture neo-soul, Morgera trova collocazione nel ruolo di «mediatore linguistico», capace di adottare le inflessioni ritmiche e le articolazioni tipiche della tromba funk statunitense, ma filtrandole attraverso una sensibilità più aperta alla cantabilità lirica e a una gestione melodica meno assertiva rispetto a Byrd. Nei suoi progetti, la tromba mantiene spesso un ruolo più flessibile, oscillando tra intervento solistico e funzione di raccordo timbrico all’interno di ensemble dal respiro collettivo. Sul piano dell’ibridazione, Byrd agisce dall’interno di un contesto che genera il soul-funk come forma «nativa» e, dunque, il suo linguaggio si modella in simbiosi con esso, partecipando alla sua stessa costruzione estetica. Diversamente, Morgera si muove da «viaggiatore culturale», assimilando codici già consolidati; li rielabora e li reimmette in contesti europei o ibridi, dove il soul-funk diventa una delle componenti di un mosaico che può includere afrobeat, latin-jazz e inflessioni pop. Le loro traiettorie, seppur distanti nel tempo e nello spazio, condividono un punto cardine: l’idea che la tromba, nel soul-funk e nei territori ad esso contigui, non debba limitarsi ad una funzione virtuosistica, ma possa agire come elemento strutturale, narrativo e identitario all’interno di un tessuto musicale collettivo. In Byrd questo principio si traduce in un’estetica dichiaratamente afroamericana, radicata nel crocevia fra cultura nera urbana e tradizione jazzistica; in Morgera assume i tratti di una «diplomazia sonora» capace di attraversare frontiere stilistiche e geografiche, portando l’idioma soul-funk in dialogo con un contesto cosmopolita.
Il lungo radicamento di Fabio Morgera negli Stati Uniti, a stretto contatto con comunità afroamericane e diasporiche, ricalibra il confronto con Donald Byrd, perché sposta Morgera da una posizione puramente «esterna» ad una condizione di immersione diretta, quasi antropologica, nel tessuto culturale che genera il soul-funk. Non si tratta dunque di un semplice trapianto stilistico, ma di una lunga convivenza con l’habitat sociale e musicale in cui quella grammatica sonora si è formata e trasformata. Byrd, negli anni ’70, agiva da insider pienamente consapevole del proprio ruolo nella costruzione dell’estetica black contemporanea, intrecciando prassi musicali e istanze comunitarie. La sua tromba era non solo strumento solistico ma voce politica, radicata nella storia afroamericana e in dialogo con le trasformazioni urbane dell’epoca. Morgera, pur provenendo da un’altra matrice culturale, attraverso decenni di vita e lavoro negli Stati Uniti ha potuto assorbire la stessa logica «interna» che guidava Byrd: la comprensione del groove non come mera struttura ritmica, ma come pulsazione sociale; l’uso del fraseggio funk non come semplice colore ma come veicolo identitario. Il contatto con musicisti afroamericani e con scene diasporiche caraibiche, africane e latinoamericane ha contribuito a rendere il suo approccio meno derivativo e più organico, capace di dialogare con le stesse sorgenti culturali a cui attingeva Byrd, pur con esiti timbrici e narrativi diversi. Laddove Byrd declinava il soul-funk da una prospettiva storicamente fondativa, inserita nel momento della sua massima espansione commerciale e simbolica, Morgera lo affronta da una posizione «diadica»: insider per esperienza vissuta, outsider per origine, capace quindi di muoversi con consapevolezza fra codici e sfumature, ma anche di trasporli in contesti più ampi, compreso il ritorno in Europa. In entrambi i casi, la tromba diventa un attore drammatico, non un semplice narratore, ossia nel Byrd degli anni ’70, una figura quasi cinematografica da poliziesco urbano; nel Morgera maturo, un personaggio capace di attraversare set differenti, dal club di Harlem alla jam session mediterranea, senza perdere il proprio accento soul-funk.
Cinque dischi per disegnare la traiettoria di Byrd da interprete hard-bop a innovatore soul-funk. In ogni album, la sua tromba non è mai esercizio di virtuosismo isolato, bensì protagonista di narrazioni collettive. Egli dialoga a rango con la coralità spirituale, si immerge nel colorismo bop, poi assume la funzione di voce urbana in paesaggi elettrificati. I compagni di strada, da Hancock a McLean, dai Mizell a Rainey, non sono comprimari, ma co-autori di contesti sonori che riflettono i mutamenti culturali del jazz tra anni Cinquanta e Settanta. «A New Perspective» (Blue Note, 1964) si staglia come uno snodo fra hard-bop e matrice corale gospel; concezione formale che fa della tromba una voce liturgica inserita in un dispositivo corale e da camera. L’assetto strumentale (tromba, sax tenore, piano, vibrafono, chitarra, contrabbasso e batteria) più il coro e l’arrangiamento di Duke Pearson rendono l’album una prova di equilibrio fra improvvisazione individuale e scrittura collettiva. «Elijah» mostra una struttura modulare basata su campi modali in Re/Sol minore con inserti di II–V che rimandano ad una giustapposizione tra sistema tonale e modalità pentatoniche/gospel. Gli accordi di pianoforte di Hancock tendono all’impiego di cluster quartali e quartine sospese, creando una base sospensiva. La tromba assume un registro narrativo sacro; le frasi brevi sono trattate come chiose rituali. Il coro funge da commento continuo, più che da semplice riempimento. Byrd dialoga con il vibrafono di Donald Best in termini timbrici, mentre il vibrafono filtra e rifrange le linee della tromba; Hancock e Kenny Burrell costruiscono un contrappunto armonico che alterna sostegni arpeggiati e pad coloristici; il coro entra come terzo interlocutore, elevando l’atto solistico a discorso collettivo. «Beast of Burden» si erge su progressione basata su un movimento circolare di II–V che si risolve talvolta in tonalità inattese; uso frequente di accordi con nona e undicesima addizionata per ricreare densità armonica senza ostentare cromatismi complessi. La dinamica narrativa che procede per accumulo, con Byrd che imposta il fraseggio come sviluppo tematico più che come virtuosismo. La ritmica sorretta da Warren/Humphries crea uno spazio metrico ampio; il sax di Mobley risponde in controfrase, mentre la chitarra di Burrell enfatizza il colore blues-infuso; ogni intervento solistico sembra leggere e «riscrivere» il tema corale originario. «Cristo Redentor» (Duke Pearson) si avvale di una progressione armonica minimalista, limitata a pochi accordi con cromatismi ascensionali che favoriscono il canto della tromba, con sospensione sulle quarte e sull’uso della pedale tonale. La tromba assume un timbro vocalico, come una voce che fonde sacro e profano. La compresenza del coro e del pianoforte crea una trama di domande e risposte; Hancock usa lo spazio armonico per «dare aria» alle frasi di Byrd, che a sua volta risponde con lunghe note tenute e micro-ornamentazioni. «The Black Disciple» / «Chant» volteggiano su passaggi più aspri, con cromatismi beffardi e alterazioni che spostano continuamente la funzione tonale, mentre la sezione ritmica lavora su pedali e ostinati. Il coro non canta semplicemente ma articola un discorso ritmico. Da canto loro, i solisti si succedono come attori sul palcoscenico: ogni intervento rilegge il materiale tematico in chiave personale, ma la struttura corale ri-orienta la frase verso il centro rituale del pezzo. «Royal Flush» (Blue Note, 1962) si sostanzia come un disco apparentemente più «classico» e votato all’hard-bop ma significativo per la concisione formale e la nitidezza timbrica. La scrittura accompagna una spontaneità, fatta pochi accordi, densità melodica elevata ed una spaziatura delle funzioni timbriche per evidenziare il dialogo solista-gruppo. «Hush» / «I’m a Fool to Want You» / «Jorgie’s» / «Shangri-La» / «6M’s» / «Requiem» presentano la tipica architettura bebop, con rapide sequenze di II–V–I, sostituzioni tritonali, ed uso puntuale di minori armonici per colorire le cadenze. «I’m A Fool To Want You» mantiene progressioni più standard, lasciando spazio ad una frase cantabile. L’attacco della tromba è calibrato, la dinamica studiata per massimo effetto espressivo con minima dispersione. Pepper Adams (baritono) contribuisce a un contrappunto spesso «terreno» rispetto al timbro più limato di Byrd; Hancock fornisce costruzioni armoniche che non sovrastano ma stimolano il solista; Higgins e Warren mantengono un dialogo ritmico di costante «domanda-risposta» con la tromba, permettendo variazioni di sospensione ed impulso.
«Fuego» (Blue Note, 1960) è l’album che riafferma le radici hard-bop ma lo fa spostando l’accento sul colore timbrico e sulla tensione melodica, con interventi di Jackie McLean che accentuano l’asprezza espressiva. «Fuego» / «Bup a Loup» / «Funky Mama» / «Low Life» / «Lament» / «Amen», titoli che utilizzano con frequenza turnaround diatonici e cromatici; «Lament» si serve di una successione armonica sospesa, quasi corrispondente ad una modalità blues-lamentosa; «Funky Mama» comincia a suggerire l’appeal ritmico che porterà Byrd verso il funk. Nel confronto fra liricità classica e motivi aspri, l’album mantiene una forte coesione narrativa. McLean provoca Byrd con fraseggi tesi, scalfendo il lirismo per introdurre tensione; Pearson e Watkins sostengono con figure ostinate che mettono in evidenza la capacità di Byrd di creare micro-architetture melodiche; i contrasti dinamici tra fiati e ritmica esaltano la teatralità degli sviluppi. «Black Byrd» (Elektra/Blue Note, 1973) costituisce un punto di svolta estetica e commerciale: dall’hard-bop alla costruzione di grooves urbani, architetture di studio ed arrangiamenti dei Mizell Brothers che trattano l’album come un film di strada. La tromba cambia funzione, passando da protagonista melodica a voce solistica inserita in un’orchestra di groove. «Flight Time» / «Black Byrd» / «Love’s So Far Away» / «Mr. Thomas» / «Sky High» / «Slop Jar Blues» / «Where Are We Going?» si stendono su progressioni orientate al groove; basso elettrico e tastiere costruiscono pad di accordi con voicing a quattro parti, dove le none e le undicesime sono prassi; prevalgono cicli tonali corti con modulazioni parziali. I Mizell usano armonie «apparentemente semplici» ma con sofisticati contrappunti di timbro (synth, Fender Rhodes, chitarra wah-wah). Dal punto di vista dell’involucro, il suono risulta studiato come immagine filmicacon luci di strada, tagli rapidi, contrasti netti; la tromba di Byrd assume un timbro più filtrato e spesso si muove su micro-frasi ritmiche che dialogano con riff preordinati. Il basso elettrico di Chuck Rainey e la batteria di Harvey Mason (in varie tracce) creano un «motore» implacabile; i Mizell riscrivono le gerarchie, in cui il solista non è più al centro assoluto, ma interpreta la parte come punto focale di un mosaico timbrico. Byrd risponde a questa grammatica con frasi precise, ritmate, spesso affidate a brevi e reiterati fraseggi; i fiati aggiuntivi (flauto, sax) e le percussioni (King Errisson) cui si sovrappone la tromba generano un dialogo di call & response, ma ora in chiave funk urbana. Nella title-track, «Black Byrd», la progressione armonica risulta relativamente essenziale, I–IV con passaggi pentatonici, ma l’interesse nasce dalla sovrapposizione di ostinati, dallo spazio ritmico e dagli effetti timbrici; la tromba spesso lavora per frammenti melodici che fungono da «gancio» emotivo. Gli interventi di Larry Mizell (arrangiamento, tastiere) e dei chitarristi (Walker e Parks) creano una pletora di attenzioni timbriche alle quali Byrd risponde ritmicamente, misurando la lunghezza della frase come fosse un battito di macchina da presa.
In «Places & Spaces» (Blue Note/1975) emerge uno sviluppo e raffinamento del linguaggio funk-soul dei Mizell, dove la progettazione di suono raggiunge livelli quasi «cinematografici» di montaggio sonoro, con Byrd che recita la parte del narratore urbano. «Change (Makes You Want to Hustle)» / «Wind Parade» / «Dominoes» / «Places & Spaces» / «You and Music» / «Night Whistler» / «Just My Imagination», tutti brani che mostrano un’armonia sofisticatae stratificazione di voicings; frequente ricorso a progressioni con armonie planate (accordi che si muovono per voce interna), modulazioni via substitute dominants ed uso sapiente delle estensioni per colorare il groove. Le tastiere orchestrano masse armoniche che lasciano intervalli giustificati alla tromba per emergere o scomparire a piacimento. Dal punto di vista stetico, album pensato come collage; Byrd si muove come un narratore che sa quando sospendere e quando riaffermare la linea melodica. L’attenzione alla tessitura sonora risulta massima ed ogni elemento ha spazio proprio nel mix. La dialettica fra Byrd e gli arrangiamenti dei Mizell appare fondamentale, poichè non si tratta solo di solista vs. accompagnamento, ma di una cooperazione nella costruzione del materiale tematico. Le sezioni ritmiche (basso, batteria, percussioni) impongono il tempo sociale; le tastiere orchestrali offrono il «paesaggio» emotivo; i fiati dialogano con Byrd stabilendo frasi in eco o risposte controfrastiche. In «Wind Parade», ad esempio, la tromba si comporta come voce solista sospesa su un tappeto armonico che scivola per quarte, mentre in «Change» le frasi di Byrd fungono da segnali ritmici che galvanizzano gli strati sottostanti. Attraverso i cinque lavori delineati, la parabola di Donald Byrd mostra una progressione non semplicemente stilistica ma semiotica, dove la tromba passa da «voce eroica» del jazz bebop a «voce collettiva» nelle sperimentazioni corali, fino a divenire «voce urbana» nei pezzi funk-soul. Dal punto di vista armonico, il viaggio procede da sequenze II–V–I e lavorazioni modali (anni ’60) verso costruzioni basate su ostinati tonali, voicings estesi e pianificazioni di colore (anni ’70). Sul piano delle relazioni comunicazionali, muta la funzione del solista, ossia prima interlocutore principale nella dialettica improvvisativa, poi elemento integrato in un paesaggio orchestrale dove la comunicazione diventa multilivello e spesso mediata da arrangiamenti di studio. Fino alla scomparsa, avvenuta il 4 febbraio 2013, Byrd mantenne viva una concezione del fare musica come processo di continua trasformazione, resistendo alla cristallizzazione in uno stile univoco. La sua eredità risiede non soltanto nella molteplicità delle opere incise, ma nella capacità di attraversare con coerenza epoche, linguaggi e pubblici differenti, incarnando un’idea di musicista moderno come figura poliedrica, intellettualmente vigile ed artisticamente inesausta.