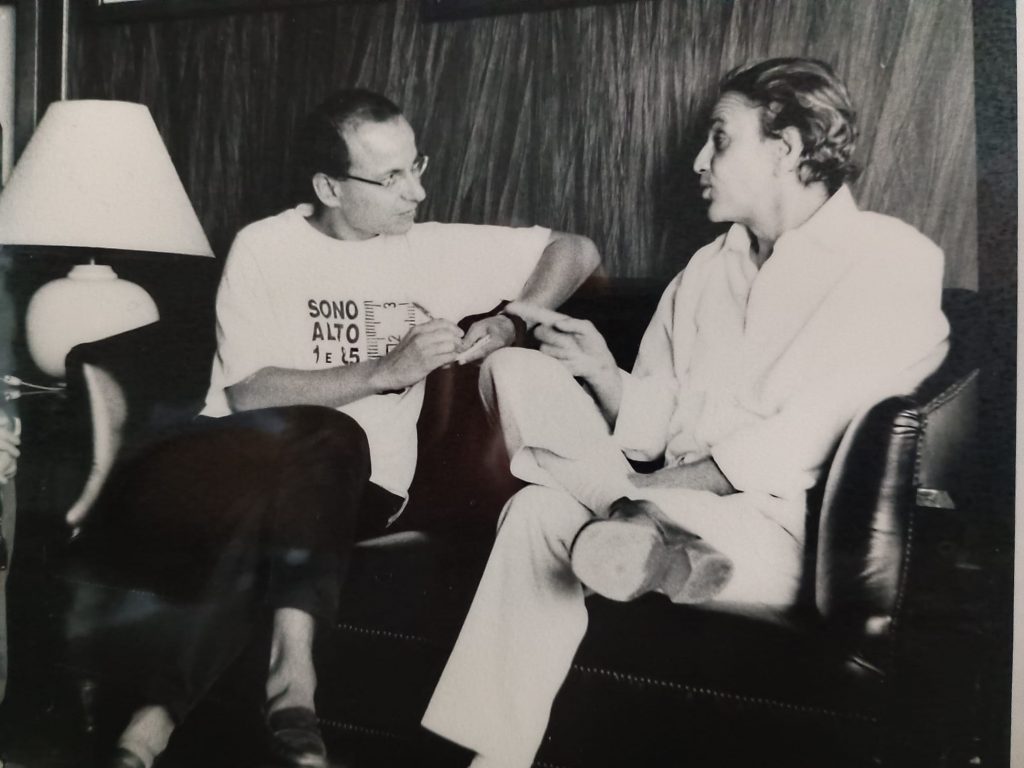Intervista a Ivo Franchi. «La musica più completa e libera che ci sia»

Ivo Franchi
// di Valentina Voto //
Ivo Franchi è un giornalista professionista di lungo corso, attualmente vicedirettore di Nuovo e di Nuovo TT, due importanti settimanali familiari pubblicati da Cairo editore. In passato ha scritto per La Stampa e ha lavorato diversi anni per i giornali di viaggio, tra cui il mensile Meridiani, sempre scrivendo in parallelo di musica per diverse testate, tra quotidiani o riviste specializzate come Il Giorno, Il Sole 24 Ore e Amadeus. Oggi è editorialista di MusicPaper e collaboratore fisso di Musica Jazz. Da giovane si è occupato di marketing per la Fonit Cetra e ha lavorato a lungo per le emittenti radiofoniche private e per Radio Rai.
D In tre parole, chi è Ivo Franchi?
R Un giornalista appassionato di musica.
D Quali sono i tuoi primi ricordi della musica da bambino?
Ho un’immagine nitida di quando mia madre mi faceva ascoltare i primi 45 giri dei Beatles, mentre mio padre mi faceva addormentare sulle note di un vecchio Lp di Tommy Dorsey: possiamo dire che questo sia stato il mio imprinting musicale, tra pop e jazz.
D Quali sono stati invece i tuoi ascolti da ragazzo e come sei arrivato (o meglio, tornato) consapevolmente al jazz?
R Ai tempi di Dorsey avevo due o tre anni, quindi me lo sono presto dimenticato. In seguito, data la mia anagrafe (sono nato nel 1959), come tutti quelli della mia generazione scambiavo dischi e ascolti con i compagni di scuola e così sono passato dal pop facile al soul, al rhythm’n’blues e al rock. In età adolescenziale la mia formazione è avvenuta per un 50 per cento sulla musica americana, da Bob Dylan alla cosiddetta West Coast (quindi Crosby, Stills, Nash & Young, Jackson Brown, Byrds, Eagles, Joni Mitchell) e per un altro 50 per cento nel progressive rock inglese e in quello che una volta si chiamava hard rock, ossia Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull, Gentle Giant, Genesis, Pink Floyd e altro ancora. Poi è arrivata una prima folgorazione grazie al jazz-rock, quindi il Miles Davis di Bitches Brew, la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin, il Chick Corea dei Return to Forever; solo dopo sono arrivate le cose più jazzate, e quindi Keith Jarrett, il Miles Davis dei primi anni Sessanta. Infine, dopo i vent’anni, sono arrivati la passione e l’approfondimento per il jazz tout court, compresi il free e il post free: quindi Charles Mingus, John Coltrane, l’Art Ensemble, Anthony Braxton, Archie Shepp e altri eroi musicali di quel periodo.
D Visto questo mosaico variopinto di ascolti mi viene da chiederti: nella tua esperienza di giornalista e critico musicale di cosa ti sei occupato con maggiore preferenza e/o maggiori competenze?
R Diciamo che io ho sempre seguito molto i miei gusti guardando allo spirito del tempo, ma facendo comunque una ricerca che in qualche modo mi appassionasse. Come tanti negli anni della fusion ho ascoltato anch’io gli Steps Ahead e altri gruppi del genere, eppure il mio percorso seguiva le mie preferenze, quindi moltissimo Keith Jarrett, filtrato da Bill Evans e da Paul Bley. Miles Davis lo adoro in tutte le sue incarnazioni – anche perché mio padre, che purtroppo non c’è più, aveva una prima edizione di Birth Of The Cool, ora malconcia e che all’epoca non sapevo fosse preziosa – e poi da lì in avanti ho allargato i miei orizzonti. La mia formazione è soprattutto nel jazz moderno e modernista, da Charlie Parker a Thelonious Monk e ad Art Blakey, tra gli anni Cinquanta e i Sessanta e oltre, che poi si è legata al free e al post-free. Solo in una seconda fase, mi sono avvicinato ai grandi del jazz classico, Louis Armstrong, Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton e così via, muovendomi a ritroso nel tempo.
D Quali sono i motivi che ti hanno spinto a occuparti di giornalismo e di critica musicale?
R Io sono giornalista puro, nel senso che nella vita svolgo questa professione, indipendentemente dalla musica. Quindi non vivo di giornalismo musicale, attività che faccio in aggiunta al mio lavoro principale. Occuparmi di musica mi permette di aprirmi un mondo altro rispetto a quella che è la mia attività quotidiana, che consiste nel lavorare sulla carta stampata e nel macinare pagine su pagine che vanno dal nuovo Papa a Belén Rodríguez, dal caso di Garlasco a Carlo Conti e ad altri personaggi della tv e del cinema. Si capisce quindi che il mio approccio alla musica non è quello del critico puro o militante, ma piuttosto del giornalista. E questo credo che si noti anche nel linguaggio e nel tipo di scrittura che cerco di usare.
D Per te cos’è il jazz? E ha ancora un senso oggi la parola “jazz”?
R Per me il jazz è la musica più completa e libera che ci sia, innanzitutto perché nasce da un mélange ed è di una straordinaria complessità fin dai suoi albori. Credo infatti che dal meticciato provengano le cose migliori della vita e il jazz è per eccellenza una musica meticcia e “sporca”, che però nel corso del suo itinerario storico è riuscita a stare in equilibrio miracoloso tra la tradizione popolare e quella colta: credo che questa sia la sua principale caratteristica. Per rispondere invece alla tua seconda domanda, sì, ha ancora senso oggi parlare di jazz. Qualche tempo fa ho avuto il piacere di intervistare Louis Sclavis e il grande clarinettista francese mi ha detto: «Per me il jazz è ciò che resta quando si è provato tutto». Quindi non è folk, non è classica, non è rock, non è pop, non è world music: è semplicemente jazz. Naturalmente l’improvvisazione ha un ruolo fondamentale nel jazz, ma esistono anche musiche improvvisate che non sono jazz.
D Si può parlare di “jazz italiano”? Esiste per te qualcosa di definibile come “jazz italiano” o “jazz europeo”?
R Questa è un’annosa questione. Sul jazz italiano ti direi che è in uno stato di grazia, ma che forse bisognerebbe parlare di “jazz europeo” più che di “jazz italiano”, anzi, meglio, di “vie nazionali al jazz”. Con questo intendo dire che quando negli anni Trenta in Francia Django Reinhardt ha dato vita al cosiddetto jazz manouche, mescolando la musica tzigana con il jazz, o quando John Surman ha fuso certe melodie barocche inglesi con l’elettronica e una certa improvvisazione (nei dischi di fine anni Settanta per l’ECM), entrambi ci hanno detto quali erano le loro vie nazionali al jazz; e lo stesso, uscendo dall’Europa, si può dire di Gato Barbieri, quando ha ripreso le musiche di tutto il continente latino-americano e ha seguito una via, una poetica, personale ma anche continentale, al jazz. Nello stesso modo si potrebbe parlare anche di certi jazzisti afroamericani di oggi, che vengono da una certa città e da un certo tipo di mondo e che sono più vicini all’hip hop piuttosto che al blues elettrico. Ecco, in questo senso devo dire che il jazz è una musica unica. Però io starei attento a costruire troppi steccati. Il jazz è un ponte, non innalza muri o barriere.
D Si può dire dunque che per te il jazz è uno?
R Sì, secondo me il jazz è uno, ma esistono delle declinazioni che possono essere personali, geografiche o nazionali; se poi dovessi chiedermi se il jazz italiano è diverso da quello europeo o americano, ti risponderei: «Dipende». Ad ogni modo ci sono tratti comuni, un comune sentire nel jazz europeo e nel jazz di certe aree: per farti un esempio, l’area mediterranea (che comprende Spagna, Italia, Francia, ma non solo) partorisce un tipo di sensibilità musicale che presenta diversi punti in comune, come ne hanno infatti, per esempio, Paolo Fresu e Richard Galliano (e non soltanto per il fatto che suonano insieme!). Per restare in Francia poi, le radici basche di Michel Portal hanno qualcosa in comune con un Richard Galliano che riporta con la fisarmonica il bal-musette nel jazz, che in parte già era presente negli anni Trenta con Django Reinhardt. Quindi ci sono corsi e ricorsi della storia, idiomi che si intrecciano, ma il jazz resta uno, anche se esistono varie vie per declinare questo linguaggio, vie che possono essere nazionali o continentali, oppure filoni, che hanno una loro originalità e che, come un fiume carsico, in certi momenti emergono, in altri si inabissano, pur continuando a scorrere sotto terra.
D Che cosa distingue l’approccio al jazz di americani e afroamericani da quello di noi europei?
R Banalmente la tradizione da cui i musicisti provengono e le influenze delle varie musiche popolari e colte che hanno toccato le corde della loro poetica e del loro universo umano e musicale. Se vieni da un grande centro urbano come Chicago hai una formazione musicale ben diversa da quella di un musicista che è originario della campagna inglese o dalla cosiddetta Sicilia africana. Ciascuno si porta dentro un proprio mondo e riesce a sintetizzare questo mondo nella propria poetica a seconda dei materiali su cui si è formato. Poi, per fortuna, i musicisti si mescolano, gli incontri e il dialogo cambiano la vita.
D Esistono ancora la politica e l’avanguardia nel jazz statunitense e in quello europeo?
R Sì, esistono ancora, soprattutto negli Stati Uniti, dove la tematica razziale è ancora disgraziatamente attuale. Ed esistono ancora musicisti che fanno del loro engagemént un tratto distintivo, che si declina attraverso una ricerca musicale d’avanguardia. Mi verrebbe però da risponderti che, per esempio, anche un musicista francese – ma originario della Costa d’Avorio – e davvero molto interessante, il flautista e sassofonista Magic Malik, unisce radici che vanno da una certa musica folclorica all’afro-beat di Fela Kuti fino all’M-Base di Steve Coleman e di Greg Osby. Qui il discorso identitario è molto forte e si traduce in ricerche musicali espresse in un modo particolare. E lo stesso vale per certi musicisti sudafricani, per esempio Nduduzo Makhathini, il quale oggi fa un’operazione che una volta con l’Art Ensemble of Chicago si chiamava Great Black Music e che poi si è chiamata BAM (Black American Music), stando però anche sulla lunghezza d’onda di Abdullah Ibrahim o di un pianista e bandleader bianco sudafricano quale Chris McGregor. Insomma, esiste ancora un collegamento tra ricerca, impegno civile (“politica” in senso lato) e identità culturale – tema molto importante oggi – come, sia pure in modo diverso, esisteva negli anni Sessanta, nell’epoca del free, del post-free e della riscoperta del patrimonio africano da parte degli artisti di origine afroamericana.
D Il jazz deve parlare, attraverso i suoni, di temi sociali, politici, ambientali, filosofici?
R Non necessariamente secondo me. Cioè non “deve” farlo, nel senso che la musica non è un linguaggio denotativo come la parola. È arte che evoca, ma non fa comizi. Ben venga se un musicista è ispirato da certi argomenti e dall’impegno civile, ma la bontà di questi temi non rende di per sé migliore o peggiore, più o meno nobile, la sua musica. Parlare di sentimenti in musica – pensiamo a un brano come My Funny Valentine nella versione cantata di Chet Baker – è nobile tanto quanto parlare di battaglie civili come ha fatto Archie Shepp in un album quale Attica Blues. Non penso che l’engagemént sia a tutti i costi un valore aggiunto. Lo può essere solo se si traduce in una qualità musicale più stimolante.
D Che vuol dire essere un critico musicale oggi? La critica musicale sta davvero scomparendo, come molti dicono? O ha ancora spazio e/o ragion d’essere?
R Non credo che la critica stia scomparendo, anche se gli spazi che le si riservano sono sempre meno. Questo discorso vale non solo per il jazz, ma anche per la musica classica e il cinema, forse un po’ meno per la letteratura: mentre un tempo sui quotidiani venivano pubblicate recensioni musicali di concerti, festival e dischi, oggi questa attività è ridotta al minimo e se c’è un evento musicale lo si presenta, ma ben di rado viene seguito a livello critico. Questo ovviamente vale meno per le riviste specializzate, ma di certo, anche se il livello della critica musicale italiana è più che buono, oggi tale pratica è un pochino in difficoltà, nella musica in particolare e più in generale nell’arte. I suoi spazi sono confinati alle riviste che se ne occupano programmaticamente. Il Corriere della Sera o la Repubblica, quando si svolgono i vari festival di Venezia o di Cannes li seguono, sia a livello di costume sia di critica, e lo stesso vale per la televisione, con le sue serie sempre recensite e raccontate. Per la musica invece, jazz e classica, con forse qualche eccezione per il rock e il pop, la critica sui grandi media (grosse testate, tv, ecc.) è ridotta ai minimi termini. In un mondo come quello contemporaneo – quello dei social, della velocità, dell’IA – si avverte la difficoltà a far circolare il pensiero e, in particolare, il pensiero critico, che per prima cosa richiede lentezza, studio, tenacia. Quindi no, la critica non è morta, è confinata. Ma non sarei così pessimista, perché ancora esiste e secondo me esisteranno sempre spazi per il suo esercizio, anche se dobbiamo trovare nuove strategie di comunicazione e coinvolgere un nuovo pubblico, quello dei giovani.
D Se ti chiedessi, a bruciapelo, di dirmi gli artisti a tuo avviso più significativi di questo primo quarto di ventunesimo secolo, quali nomi faresti?
R Di primo acchito ti direi Brad Mehldau, Bill Frisell, John Scofield, Pat Metheny, Joshua Redman o band come gli Snarky Puppy e Artemis, il gruppo tutto al femminile della pianista canadese Renee Rosner; poi trovo molto interessante la scena israeliana di oggi, dal sassofonista Oded Tzur al trombettista Avishai Cohen. E, ancora, ti direi il trombettista Ambrose Akinmusire e un sassofonista come James Brandon Lewis, non tanto perché io sia un suo fan, quanto piuttosto per il suo approccio di rilettura e rivitalizzazione del patrimonio del jazz degli ultimi quarant’anni. Senza dimenticare Chris Potter, a mio avviso uno dei migliori improvvisatori di sax tenore (e non solo) in circolazione. E sono sempre in attività anche tanti “grandi vecchi”, come Dave Holland, John Surman o Ron Carter, che danno ancora lezioni di stile e di intelligenza. Infine, visto il mio amore sconfinato per la Francia, ti citerei nuovamente Richard Galliano, che certo non è più un giovanotto, ma è un musicista che ha condotto e conduce tuttora operazioni culturali di grande spessore. In questa mia lista ci sono tante lacune, visto che ti ho fatto i primi nomi che mi sono venuti in mente. Oggi sono tanti i musicisti interessanti, ma questi che ti ho citato, secondo me, hanno davvero cambiato qualcosa.
D Come vivi tu il jazz in Italia, anche in rapporto alle tue esperienze sul territorio?
R Io vivo a Milano, una città internazionale. Però ti darei una risposta relativa a tutto il jazz italiano, dicendoti che oggi si trova in una fase eccellente e che gode di una salute molto migliore rispetto al passato – quando si parlava di rinascita del jazz italiano – perché ha una qualità e una varietà veramente notevoli, e soprattutto, in linea di massima, non ci sono musicisti che scimmiottano il revival dell’hard bop come accadeva negli anni Novanta. Attualmente ci sono una maggiore creatività e una notevole ricerca di originalità, e il panorama nostrano può vantare improvvisatori davvero eccellenti. C’è un fiorente filone, chiamiamolo “jazz mediterraneo”, di cui Paolo Fresu è il caposcuola e che conta musicisti come Francesco Cafiso, Daniele di Bonaventura, Dino Rubino ecc. che fanno cose estremamente interessanti. Senza dimenticare i Fearless Five, giovani musicisti notevolissimi. Amo molto anche Alessandro Sgobbio, Anais Drago, Federica Michisanti, Jacopo Ferrazza, Ferdinando Romano, Alessandro Lanzoni, una cantante e chitarrista come Simona Severini. Insomma, c’è una generazione di musicisti eccellenti, accanto ai “grandi vecchi” come Enrico Rava, Franco D’Andrea, Claudio Fasoli, Gianluigi Trovesi, Enrico Pieranunzi, Giovanni Tommaso e altri big.
D Cosa pensi dell’attuale situazione in cui versa la cultura italiana, di cui il jazz ovviamente fa parte?
R In linea di massima mi sembra che siano più interessanti le cose del jazz che non quelle di altri settori della cultura italiana. Ossia credo che altre discipline artistiche siano un po’ più “sedute” rispetto al jazz, il quale vive a mio parere una situazione ben più vivace, essendo caratterizzato da una maggiore permeabilità e da un maggiore dialogo con l’estero e, quindi, da un fuoco creativo tuttora meritevole di attenzione. Musicisti bravi certo ci sono anche in ambito classico, cantautorale e pop, però ritengo che la situazione del jazz sia più vitale. E questo anche e soprattutto rispetto a quella di altre discipline artistiche, come la letteratura, il cinema, il teatro, l’arte figurativa. In questi ambiti mi sembra che ci sia molta produzione ma un’originalità minore rispetto al passato. Naturalmente è solo un’opinione molto personale e di parte: quindi va presa con beneficio d’inventario.