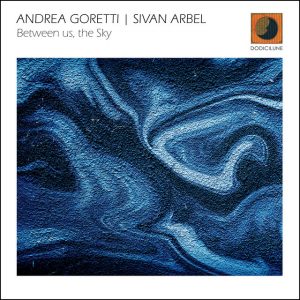Italian Instabile Orchestra con «Plays Ellington» quando l’instabilità genera aderenza (Felmay, 2025)

…il singolo episodio sonoro si collega al successivo per affinità strutturale, ciascun cambio armonico si dirama per tensione interna, mentre il cromatismo si dispone secondo una logica di costruzione modulare. Il documento sonoro che ne deriva compone un paesaggio.
// di Francesco Cataldo Verrina //
L’Italian Instabile Orchestra, nell’affrontare l’opera di Duke Ellington, si propone come un’indagine critica, un esercizio di reinvenzione che va oltre la semplice celebrazione. Nel dicembre del 2013, la città di Porto divenne il luogo di un evento che trascende la mera documentazione dell’ultima esibizione pubblica dell’orchestra prima di un periodo di sospensione. Questo episodio si rivela quale profonda sedimentazione e dichiarazione estetica manifestandosi attraverso una consapevole frizione tra memoria e rinnovamento.
Il programma, dedicato interamente al libro dei sogni di Duke Ellington, non si limita ad un omaggio convenzionale o a una rilettura reverente. Piuttosto, affiora come un’indagine critica e un atto di riscrittura che funge da frantumatore della formalità, più che della forma. L’orchestra, libera da una direzione stabile e basata su una rotazione autoriale, non si limita ad interpretare Ellington, m alo restituisce sotto nuove sembianze. L’approccio a un corpus canonico come quello ellingtoniano, peraltro inedito nella storia dell’ensemble, non scaturisce da logiche celebrative. L’Instabile ricerca la frizione e la tensione strutturale. Il titolo stesso, «Plays Ellington», si carica di ambiguità semantica: il verbo play si sdoppia in esecuzione e manipolazione, in performance e interrogazione. L’orchestra non si limita a eseguire Ellington: ne smonta il telaio, ne espone le fragilità, ne rilancia le traiettorie armoniche. La registrazione realizzata a Porto, ultima testimonianza di un’attività concertistica che ha segnato il jazz europeo tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, assume un valore archivistico e progettuale. Nella scelta di Ellington, l’Instabile rilancia, aprendo nuove prospettive. E qualora la reunion del 2024 dovesse segnare un nuovo inizio, sarà da questa scrittura che si potrà ripartire: tensione, frizione, sviluppo. La nascita dell’Italian Instabile Orchestra, collocabile tra il 1989 e il 1990, non coincide con la fondazione di un semplice ensemble, bensì con l’emersione di una postura collettiva e di una visione musicale che rifiuta la verticalità, la gerarchia e la prevedibilità estetica. L’aggregazione si sviluppa come una coalizione sorgiva una convergenza volontaria di musicisti provenienti da aree geografiche, generazioni e percorsi formativi differenti, accomunati da una propensione condivisa verso l’improvvisazione radicale, la scompattazione e la partizione multilevel. La denominazione «Italian Instabile Orchestra» delinea un codice. Il termine «Italian» indica una postura linguistica, una fisionomia sonora che, pur nella varietà delle voci, lascia affiorare un gusto melodico, una verve comunicativa ed una modalità di porgere che rimanda ad una tradizione non codificata, ma riconoscibile. Il termine «Instabile» sancisce una visione, in cui l’instabilità diventa punto di sutura. La logica interna della compagine si fonda su una rotazione autoriale che dissolve la figura del direttore, sostituendola con una pluralità di voci compositive. Ogni membro divine, al contempo, solista, compositore e tessitore di trame ardite, con una leadership pro-tempore. Persino personaggi di forte individualità come Giorgio Gaslini, la cui storia musicale appare segnata da una regale postura direttoriale, accettavano di cedere sovranità, di entrare in un sistema armonico collettivo fondato sulla convergenza e sulla dialettica. Questa ratio anarchica genera, per contro, un ordine interno, il quale si regge su una grammatica condivisa, Nel corso dei due decenni successivi al debutto al festival di Noci nel 1990, l’Instabile ha attraversa il continente europeo, lasciando tracce indelebili in festival di riferimento come Le Mans, Mulhouse, Moers, nonché in città come Berlino, Colonia, Zurigo, Amsterdam e Parigi. La sua presenza, più frequente all’estero che in Italia, diventò un termine di confronto, capace di mettere in crisi le forme orchestrali consolidate. Le collaborazioni con figure come Cecil Taylor e Anthony Braxton si manifestarono alla stregua di dichiarazioni d’intenti, come avvenuto nel 2000 a Ruvo di Puglia, nel 2002 a Bobigny, nel 2003 a Sant’Anna Arresi e in qualsiasi altra venue che finì per tradursi in un’occasione di riscrittura e di revisione linguistica. La sua italianità non si misura in coordinate geografiche, ma in gusto melodico, verve comunicativa e capacità di tenere insieme indisciplina e convergenza. Il termine «Italian» non indica provenienza, ma un preciso modus agendi.
La decisione di affidare a Giancarlo Schiaffini la direzione e l’arrangiamento del programma ellingtoniano si fonda su una necessità sostanziale, non su una semplice rotazione interna o su una logica curatoriale. Schiaffini, perno centrale del primo free jazz italiano, protagonista della Roma avant-garde degli anni Sessanta accanto a Mario Schiano, proclama una visione. Nel corso della sua traiettoria musicale, Schiaffini ha esplorato territori compositivi e performativi che spaziano dall’improvvisazione radicale alla musica rinascimentale, dalla collaborazione con Giacinto Scelsi e Luigi Nono alla sperimentazione elettroacustica, dalla Nuova Consonanza alla pratica orchestrale non convenzionale. Nella riscrittura orchestrale di Schiaffini per «Plays Ellington» le pagine musicali del Duca vengono sottoposte ad un processo di scomposizione e ricomposizione. La dissonanza diviene principio fondativo, per contro, le sezioni si accatastano sena fondersi,, mentre la narrazione sembra sconfinare in un altrove. La distribuzione delle voci, la disposizione dei colori sonori e la geometria timbrica che ne deriva, interrogano Ellington. Schiaffini fa vibrare il profilo acustico originario in una nuova tessitura, mentre l’impianto formale si dissolve in una trama tematica che persegue la stratificazione. La scelta di valorizzare le dissonanze scoperte, di esporre frizioni timbriche e di far dialogare sezioni strumentali in contrappunto, risponde ad attitudine critica. La sua direzione, non abituale all’interno dell’organico, si manifesta come ruolo operativo. La sua presenza tra i tromboni si trasforma in regia armonica e in disegno acustico, evidenziando una visione collettiva capace di travasare il passato nel presente.
Il programma ellingtoniano concepito da Giancarlo Schiaffini per l’Italian Instabile Orchestra si presenta come un impianto compositivo articolato, dove ogni pagina musicale del Duca viene rimodellata secondo una logica di stratificazione e rilancio. Le strutture originarie vengono ridisegnate; le progressioni tonali si espandono in geometrie timbriche che prediligono l’esposizione alla risoluzione, la frizione alla sintesi. La distribuzione delle delle partiture si configura in seno a un’orchestra priva di gerarchie fisse, dove ogni sezione strumentale assume funzione costruttiva. I fiati scolpiscono il profilo acustico, le percussioni delineano il ritmo interno, le fusioni orchestrali generano una trama sonora dove ogni intervento strumentale agisce come tessera di un mosaico espressivo, in cui la varietà diventa un plus. La scrittura di Schiaffini, fondata su una pratica compositiva che taglia di traverso la musica colta, l’improvvisazione radicale e la sperimentazione elettroacustica, imposta un ordine interno che valorizza le dissonanze quali elementi generativi. Le voci strumentali si posizionano secondo una logica di contrappunto, le sezioni dialogano per sovrapposizione e le armonie si articolano in sagomature non lineari, mentre il risultato evoca le faglie di Ellington, ne accende le tensioni latenti, e ne risveglia le possibilità inespresse. La compagine, rinnovata rispetto alla formazione originaria, mantiene una coerenza che si regge sulla variazione. L’assenza di Gianluigi Trovesi, la presenza direzionale di Schiaffini, la sedimentazione di esperienze radicali, la memoria di figure come Mario Schiano e Renato Geremia, contribuiscono a promulgare una fisionomia che si affina in progressione, dove qualunque mutamento diviene occasione di riscrittura e qualsiasi differenza si trasforma in risorsa. La monografia ellingtoniana, divergente rispetto al repertorio originale sedimentato negli anni, si sviluppa come esercizio di traslazione formale, in cui il Duca vibra, mentre sue pagine musicali vengono rielaborate. Nella registrazione di Porto il singolo episodio sonoro si collega al successivo per affinità strutturale, ciascun cambio armonico si dirama per tensione interna, mentre il cromatismo si dispone secondo una logica di costruzione modulare. Il documento sonoro che ne deriva compone un paesaggio. La forma orchestrale prolunga, il gesto musicale si trattiene. E nel fluire di questa tessitura, l’Instabile riafferma la propria vocazione.
L’Italian Instabile Orchestra, nel corso degli anni, ha realizzato una rete di rapporti transnazionali, la quale ha agito come un dispositivo critico nel panorama jazzistico europeo, ben oltre la semplice circuitazione festivaliera. L’adesione a contesti come Le Mans, Mulhouse, Moers, Berlino, Colonia, Zurigo, Amsterdam e Parigi, ha generato confronti impliciti, tensioni formali e differenze sostanziali che hanno contribuito a sancirne una fisionomia distintiva. A differenza di molti ensemble continentali, spesso sostenuti da istituzioni nazionali e fondate su modelli direttoriali durevoli, l’Instabile ha operato secondo una logica di aggregazione volontaria, di rotazione autoriale e di costruzione modulare; la sua struttura ha perseguito l’articolazione di una grammatica alternativa, capace di far emergere divergenze e di scolpire differenze. Nel confronto ravvicinato con orchestre di lunga tradizione – sia nei festival tematici, sia nelle serate condivise – l’Instabile ha agito come soggetto perturbante, capace di far affiorare faglie estetiche, di risvegliare atteggiamenti compositive, di delineare variazioni timbriche non assimilabili. La modalità di porgere, la verve comunicativa e la capacità di far dialogare generazioni e provenienze, hanno generato scarti percettivi che si sono tradotti in rilanci estetici e strutturali. La compagine ha costruito una pratica, non una scuola. Ciascuna esibizione ha assunto la forma di un esercizio critico, di una tessitura armonica e di una costruzione acustica che ha espanso il campo delle possibilità orchestrali. La sua italianità si è riflessa in una sintassi musicale capace di far vibrare le differenze, di modellare le divergenze, di comporre paesaggi sonori in equilibrio instabile. Le relazioni internazionali dell’Instabile hanno generato una rete di scambi e di convergenze che ne hanno alimentato la grammatica interna. Gli incontri con figure come Cecil Taylor e Anthony Braxton, le collaborazioni con musicisti provenienti da ambiti radicali e sperimentali, hanno contribuito a delineare un codice espressivo nutrito di tensioni costruttive, di sovrapposizioni generative e di dialoghi non conciliativi.
Nel programma «Plays Ellington», questo atteggiamento transnazionale si riafferma con precisione, mentre l’approccio ad un corpus canonico si traduce in rilancio. Ciascuna pagina musicale del Duca viene rimodellata secondo una ratio di impiantistica modulare ed ogni episodio sonoro si staglia all’interno di una geometria timbrica che riflette una concezione orchestrale maturata nel confronto, nella divergenza e nella distribuzione, grazie ad esecutori dal portato non convenzionale tra cui: Daniele Cavallanti, sax tenore come asse ritmico e narrativo. Fondatore del progetto Nexus con Tiziano Tononi, Cavallanti imposta il sassofono come colonna armonica e vettore narrativo. La sua voce è un dispenser di idee, in cui qualunque intervento scolpisce la progressione ed ogni fraseggio modella la curva interna del dell’intreccio tematico. Cavallanti agisce come regista ritmico, alla stregua di tessitore di divergenze e quale come memoria attiva della tensione formale. Roberto Ottaviano, soprano come linea critica ed alto come detonatore lirico. Con una traiettoria che attraversa il jazz europeo ed americano, Ottaviano usa il sax come strumento di escavazione tematica. Il soprano si nutre di tensioni elegiache, mentre l’alto affonda nelle divergenze. La sua modalità di porgere, nutrita da una sensibilità espressiva che attraversa generazioni e geografie, agisce come propulsore critico, mentre ogni frase sancisce un segmento formale, che riforma e deforma. senza mai scivolare sul piano inclinato della prevedibilità. Carlo Actis Dato, il baritono quale fondale timbrico e geometria acustica. Figura centrale della scena torinese, co-fondatore di Art Studio, Actis Dato usa il baritono come descrittore di paesaggi sonori. Il suo suono profondo marca il territorio orchestrale senza mai ammassarsi, mentre il clarinetto basso disegna simmetrie oblique. Il suo ruggito agisce come fondale narrativo, tessitura armonica, geometria timbrica multi direzionale. Martin Mayes, il corno francese portatore di un’ortografia dell’immaginazione. Definito da Mario Schiano come «il derviscio rotante del corno», Mayes promulga il suo strumento come un variatore acustico, facendo affiorare traiettorie sonore che si avvitano nel percorso improvvisativo. Ciascun intervento stabilisce una scultura timbrica, un carotaggio interiore, un innesco visionario: Mayes penetra il parenchima sonoro deflorandolo. Pino Minafra, tromba e flicorno l’assertività come modulo espressivo. Fondatore dell’Instabile, promotore del Talos Festival, Minafra si approccia alla tromba con la trasversalità del dubbio. Il flicorno emette schegge di trasversalità a controllo numerico, mentre la tromba accende divergenze e dissonanze, mai incongrue, in cui la sua aura fonica emerge per tensioni ed il fraseggio per frizioni. La sua voce rappresenta un moltiplicatore associativo ed una memoria sonora. Emanuele Parrini: il violino tra tessitura armonica e tensione narrativa. Figura di riferimento del violino jazz italiano, Parrini implementa lo strumento come vettore di costruzione. Le sue traiettorie attraversano la tonalità, l’improvvisazione libera, la scrittura etnica e la tensione politematica, dove ciascun arco disegna una progressione ed ogni vibrazione modella una geometria. Tiziano Tononi, batteria come impianto compositivo e deflagrazione armonica. Percussionista e compositore, Tononi fornisce alla batteria la consistenza di sistema accordale. I suoi colpi articolano, mentre le pause rilanciano. La sua postura, nutrita da esperienze con Andrew Cyrille e Bob Moses, agisce come asse interno, dove Tononi distribuisce tensioni, modella forme, compone geometrie ritmiche che fissano il tempo in uno spazio che si dilata. Ogni strumentista, evocato, si annoda ma non si somma, comportandosi come il segmento di una costruzione modulare, dove ogni singolo atto espositivo innesca una visione, quanto meno apre una prospettiva.
L’album si apre con «Come Sunday», una soglia timbrica che invita all’ascolto, una sorta di preludio che prepara l’ascolto. L’ensemble, emergendo con delicatezza, delinea una linea melodica di lenta necessità, quasi a voler scandire il tempo con la sua esitazione, mentre la sua profondità crea un’eco sonora che trattiene e rilascia, mentre, con discrezione, guida le traiettorie armoniche. La spiritualità timbrica si manifesta attraverso la sospensione, l’attesa e l’espansione, dilatando il tempo per effetto della pulsazione interna, che privilegia la fondazione rispetto all’avanzamento. La melodia, infine, si rivela gradualmente, come un campo di ricerca. L’atmosfera che si crea è quella di un’attesa e di un’apertura, che prepara l’ascoltatore al viaggio. Il secondo brano, «Perdido», devia la traiettoria impostata, tracciando una linea obliqua che moltiplica le traiettorie, le quali spezzano la scansione, generando un groove che distribuisce senza enfasi, mentre vengono esposte divergenze timbriche che alimentano la tensione. Il tema, deformandosi progressivamente, si traduce in un campo di attriti. Le voci, sovrapponendosi, creano una molteplicità politematica, procedendo per urti e rilanci, mentre implementa un’intelaiatura rizomatica e ramificata. L’armonia si fa più opulenta, mentre il ritmo si infittisce, e l’ascoltatore viene risucchiato in un vortice di suoni. Con «Cotton Tail», l’energia si fa più intensa. Il flusso motivico, trascinato da una corrente instabile, genera deviazioni che si moltiplicano, mentre l’ensemble procede con urgenza, scavando nella materia timbrica, mentre la scansione metrica, frammentando il tempo in cellule che si rincorrono, accoglie le tensioni che cercano la correlazione fra le parti in causa. La melodia si distribuisce per interrogativi, espandendosi per innesti e generando una forma stratificata, sorretta da ritmo incalzante, da improvvisazioni vorticose e da una deflagrante vitalità. «Mood Indigo» offre un momento di respiro, un’oasi di densità solcata da un’aura di rarefazione, insinuandosi con delicatezza negli anfratti della memoria, alla una direzione, mentre la struttura si articola per zone, lasciandosi attraversare da linee divergenti. Il tempo, sospeso, dispensa tensione quasi all’infinito, così come la melodia, affiorando per sublimazione, consente all’impianto armonico di generare un’atmosfera di malinconia e introspezione. Il cuore dell’album batte intorno «The Duke Of Medley», a firma Schiaffino, una vera e propria celebrazione della musica di Ellington. Il portato del Duca, contaminandosi, genera una un riforma più che una forma, dove l’organico disarciona il limite armonico. La struttura, agglutinandosi, si autogenera per proliferazione, mentre il tempo, abitato come spazio mobile, si diffonde in ogni direzione. La partitura, agendo come tessitura, elabora, avanzando per innesti e deviazioni, mentre genera una dimensione acustica dalla consistenza elastica. Simo difronte ad un omaggio complesso e multistrato, che riporta su carta millimetrata la profonda conoscenza ed il rispetto dell’Italian Instabile Orchestra per il compositore americano. «Do Nothing «Till You Hear From Me» è un invito all’attesa, locupletato da un canto limaccioso che sembra emergere dalle acque di una palude interiore, quasi un rito apotropaico, in cui gli uomini dell’orchestra procedono dubbiosi e divorati dall’attesa, orientandosi con cautela, mentre cercano una via di fuga. La melodia suggerisce come affiorando da un fiume sotterraneo, mentre progressivamente il ritmo sembra intensificarsi dilatandosi. La struttura, innervata da differenti sensibilità timbriche, genera una forma che si lascia facilmente avvicinare. L’atmosfera, apparentemente intima e raccolta, propone un invito all’ascolto attento e puntiglioso. «Sophisticated Lady» costituisce un’altra perla dell’album, dove le note, sedimentandosi, costruiscono una forma multitasking, in cui dalla tensione germina una trama vischiosa che mira ad intrappolare il fruitore. L’intreccio motivico, respirando come un organismo che vive per antitesi nutrendosi di contrasti, dimostra la capacità dell’orchestra di rileggere, con autentica, ma non convenzionale sensibilità, le composizioni di Ellington. Infine, «Take The A Train» rappresenta la metamorfosi finale. Il tema subisce una traslazione, mentre i ritmi si moltiplicano, disegnando nuove traiettorie. Il tessuto accordale, abitato da tensioni interne, si reinventa, mentre il ritmo s’ingrossa increspandosi. L’intreccio motivico, avanzando per innesti e deviazioni, genera una sagoma che s’ingigantisce. Siamo alle prese con una chiusura esplosiva, che suggella l’omaggio, non tributaristico e riverenziale dell’Italian Instabile Orchestra, a Duke Ellington.