Fra le pieghe del jazz europeo: «Mandala» di Rastko Obradovic come forma aperta (A.MA Records)
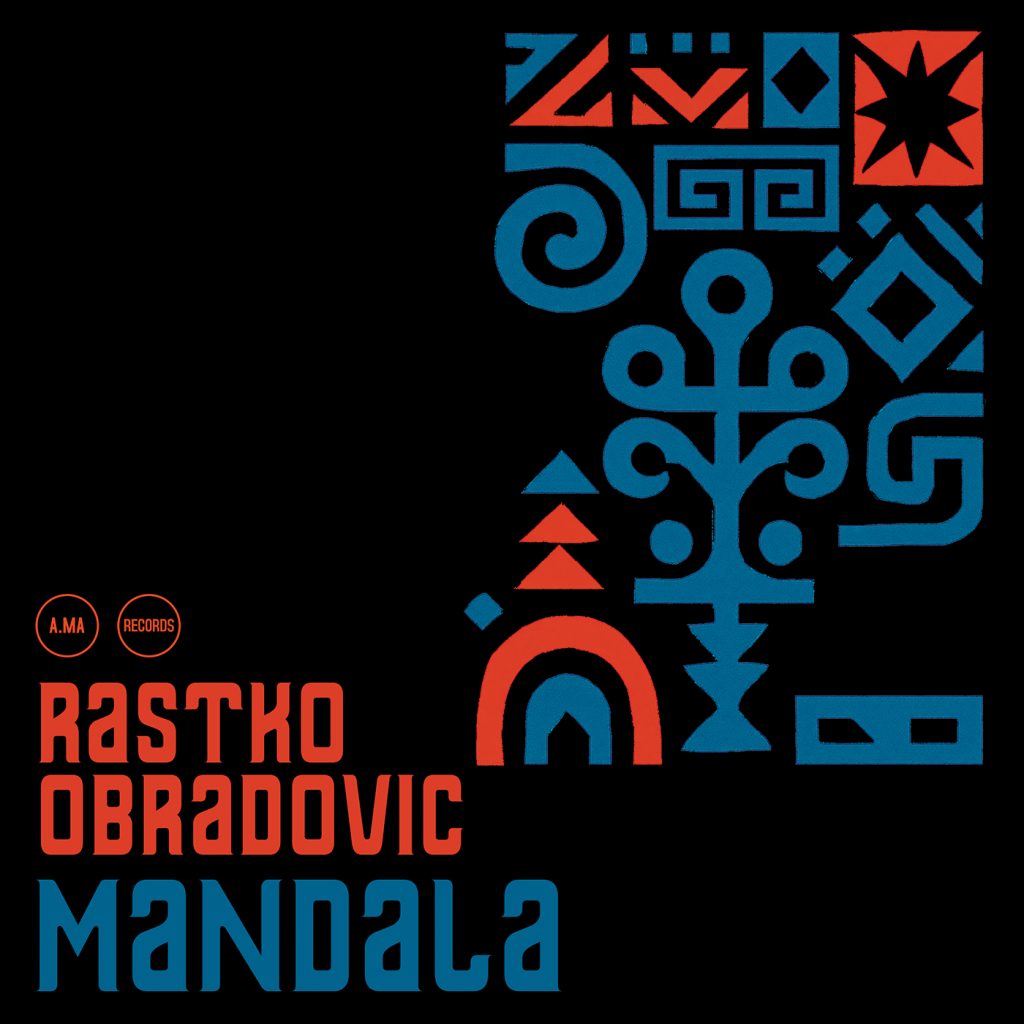
«Mandala» si offre come un paesaggio; si ascolta come si osserva un disegno armonico che si coagula nel tempo, dove ogni nota diventa progressivamente il tratto di un quadro più completo. Il titolo stesso, lungi dall’essere metafora esotica, attiene ad una logica circolare che si espande, diramandosi in direzioni molteplici.
// Francesco Cataldo Verrina //
«Mandala», pubblicato da A.MA Records di Antonio Martino, si presenta c come una dichiarazione di intenti, un tracciato sonoro che restituisce la fisionomia musicale di Rastko Obradovic con una coerenza interna che rifugge ogni formula. La sua voce strumentale, affidata al tenore, si articola nel respiro collettivo del quartetto, dove Vladan Veljkovic (pianoforte e sintetizzatore basso), Aleksandar Petrovic (chitarra) e Nikola Banovic (batteria) partecipano attivamente all’implementazione del costrutto sonoro.
Rastko Obradović è nato in Serbia, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel circuito jazzistico belgradese già da adolescente, frequentando le jam session del club «Čekaonica», luogo emblematico per la scena locale, nel quale il jazz costituisce da sempre un modulo di sperimentazione costante. La sua formazione si distingue per una precocità non ostentata, ma interiormente maturata. Dopo aver completato il percorso presso il dipartimento jazz della Scuola Musicale «Stanković» in soli due anni, il sassofonista serbo ha proseguito gli studi a Oslo, fondando un quartetto con alcuni colleghi norvegesi. Questo passaggio non rappresenta una semplice tappa geografica, ma piuttosto un momento di dislocazione fertile, in cui il suo modus agendi ha iniziato a riflettere una sintesi fra il folklore balcanico ed le atmosfere nordiche, fra la logica modale e la rarefazione acustica. I modelli di riferimento che hanno orientato la sua fisionomia sonora non si limitano ad un canone, ma delineano un background articolato. Jan Garbarek gli ha indicato una soglia d’ingresso, non tanto per la sonorità, quanto per l’apertura verso le musiche tradizionali del mondo, in particolare quelle celtiche e scandinave. Bojan Z, con la sua capacità di fondere il jazz con le metriche balcaniche, gli ha offerto un esempio di costruzione modulare tesa alla coesistenza. Sonny Rollins e Kenny Garrett hanno contribuito a definire la postura strumentale, ma sempre filtrata da una sensibilità che rifugge l’emulazione. La musica di Rastko Obradović non cita: si avverte la presenza di una tradizione afro-americana che viene rielaborata in seno ad un impianto compositivo europeo. In tal senso, la sua voce si colloca nel solco di artisti come Louis Sclavis, John Surman, e persino Tomasz Stańko, non per somiglianza ma per l’attitudine a pensare la musica come espressione identitaria.
Obradovic, già primo alto nel Serbian Radio & Television Big Band, non si attesta come solista, bensì come tessitore di trame sonore, capace di modulare la propria voce nel tessuto di un ensemble generativo, tra jazz americano contemporaneo, tradizioni balcaniche, classica europea e indiana che amalgamano in un impianto compositivo giocato sulla sintesi La struttura tematica dell’album si sviluppa lungo otto episodi che non si dispongono secondo una logica di affioramenti e ritorni, dove ogni titolo non designa un altrove ed una postura espressiva. «Kanda» apre il ciclo con una struttura tematica che si fonda su un impianto modale, costruito sulla scala dorica ed una variante balcanica della minore armonica. Il tenore di Obradovic sembra suggerire progressivamente un’evoluzione imperniata su una linea che si dipana in un registro medio, evitando l’enfasi, ottenendo la complicità di pianismo che ne segue pedissequamente il disegno motivico. Veljkovic impiega il basso synth con parsimonia, creando una velatura acustica che rimanda a certe soluzioni di Craig Taborn, ma con una coloritura più terrosa e meno astratta. La chitarra di Petrovic oltrepassa il semplice contrappunto contrappunto, mirando alla sovrapposizione timbrica, con un uso del delay che ricorda le stratificazioni di Jakob Bro, mentre Banovic da vita ad un ambiente ritmico proteso in avanti. «Nemir» affiora come una pagina musicale in bilico fra tensione e rilascio, dove la progressione armonica si sviluppa secondo una logica di espansione, in cui si avverte una sequenza che ruota attorno a un II-V-I alterato, ma con deviazioni che ne destabilizzano la funzione tonale. Il quartetto cerca la sospensione, avvicinandosi a certe pratiche di Paul Motian, dove la batteria sembra respirare mentre scandisce il ritmo. Il colore sonoro del tenore si fa più granulare, con un vibrato controllato che rimanda alla scuola di Joe Henderson, ma con una pronuncia meno assertiva. «Prisoner And The Soldier (Part 1)» si presenta come una struttura modulare, dove l’alternanza fra sezioni libere e segmenti metricamente definiti da corpo ad una narrazione non lineare. L’armonia si muove per sovrapposizioni, in cui si avverte l’uso di cluster pianistici che non definiscono accordi, bensì masse sonore, mentre il basso synth interviene come elemento destabilizzante, creando una tensione fra profondità e superficie. Il dialogo fra sax e chitarra si fa più serrato, con un uso del fraseggio che rimanda a certe pratiche di Tim Berne, ma con una maggiore attenzione alla cantabilità. La seconda parte («Part 2») non prosegue per analogia, bensì trasforma, mentre la struttura si semplifica, al punto che si avverte una progressione discendente, la quale allude ad una cadenza plagale, ma il trattamento armonico la rende ambigua. Banovic impiega il ride come elemento narrativo, generando una trama ritmica che si fa quasi melodica.
«Rumunjesku» si fonda su un impianto ritmico dispari trattato con flessibilità. L’armonia si muove su gradi modali, con una predilezione per la scala frigia dominante, che rimanda a talune pratiche della musica romena e turca. Il tenore espone frammenti, mentre il pianoforte interviene con accordi spezzati che costruiscono una geometria timbrica. La chitarra impiega il tremolo come elemento espressivo, avvicinandosi alla sensibilità di Ralph Towner, mentre la batteria lavora per sottrazione, lasciando emergere il vuoto come spazio compositivo. «Benjamin’s Blues» non si rifà al blues come forma, bensì come clima. La progressione armonica si sviluppa secondo una logica di sostituzioni, mentre si avverte l’uso di accordi diminuiti e di dominanti secondarie che destabilizzano la struttura. Il sax lavora su intervalli di quarta e quinta, evitando la triade, avvicinandosi alla pronuncia di Oliver Lake, ma con una maggiore attenzione alla linea. Il pianoforte impiega voicing aperti, con la mano sinistra senza marcare il basso. Dal canto suo, la chitarra interviene con armonici e bending, creando una fisionomia sonora che si fa quasi vocale. «What If» si estrinseca come una pagina contemplativa, dove l’armonia si addensa per accatastamento di triadi, secondo una logica quartale. Il sax si muove in un registro alto, con un fraseggio che si avvicina alla sensibilità di Mark Turner, ma con una maggiore flessibilità ritmica. Il pianoforte impiega il pedale come elemento strutturale, creando una tessitura accordale che si espande nel tempo, mentre la chitarra lavora per sottrazione, e la batteria impiega le spazzole come strumento timbrico, non ritmico. «Afternoon» chiude il ciclo con un impianto che si avvicina alla forma canzone, ma trattata con libertà. L’armonia si staglia su gradi diatonici, con deviazioni modali che ne arricchiscono la coloritura. Il sax espone un tema basato su una progressione variata, con il plauso del pianoforte che interviene con arpeggi che delineano l’habitat sonoro. La chitarra impiega il chorus come effetto timbrico, e la batteria lavora su pattern sincopati che creano una pulsazione interna. Nel complesso, «Mandala» si colloca nel solco di una tradizione che cerca di dialogare, tra echi di Kenny Wheeler, di Tomasz Stańko, di Louis Sclavis, ma anche di Wayne Shorter ed Andrew Hill. Nel complesso «Mandala» si offre come un paesaggio; si ascolta come si osserva un disegno armonico che si coagula nel tempo, dove ogni nota diventa progressivamente il tratto di un quadro più completo. Il titolo stesso, lungi dall’essere metafora esotica, attiene ad una logica circolare che si espande, diramandosi in direzioni molteplici. Belgrado non viene evocata come crocevia, ma quale luogo dove le lingue sonore si ricompongono.






