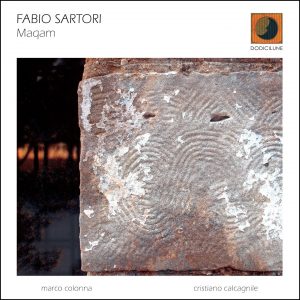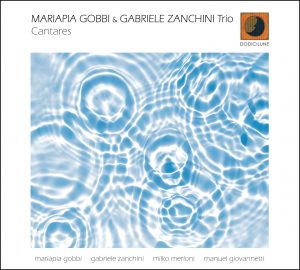Brassense con «Stay Funky»: tensioni e ritmi di una sinfonia urbana, tra funk, jazz ed arte visiva (Alfa Music, 2025)
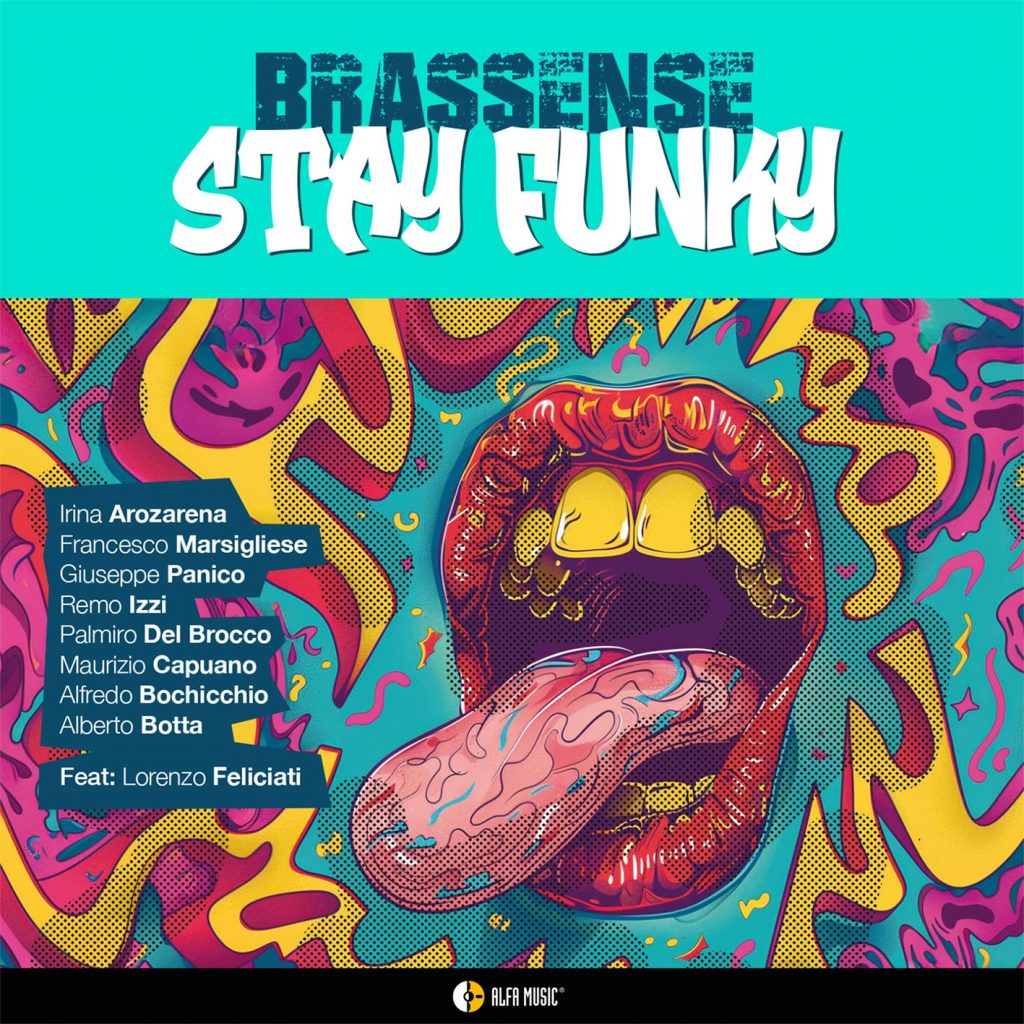
Ogni segmento funge da tessera autonoma ed al contempo necessaria alla formazione di un mosaico più ampio. L’intersezione tra musica e altre arti non è un mero ornamento retorico, ma una chiave ermeneutica utile a comprendere la profondità progettuale dei Brassense, la forma pensante di un collettivo che suona il presente senza paura di sporcarlo, plasmandolo con consapevolezza e desiderio.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Nel solco di una tradizione brassistica rinnovata, «Stay Funky» dei Brassense, edito da Alfa Music, si presenta come un congegno sonoro meticolosamente orchestrato, versato nel coniugare rigore tecnico e libertà espressiva. L’organico, originariamente quintettistico, si amplia attraverso l’innesto di una sezione ritmica incalzante e di una voce solista dalla caratura soul, generando una materia musicale pulsante, meticcia e attraversata da tensioni stilistiche feconde.
Lontano da qualsiasi classificazione rigida, il repertorio s’insinua nei territori più disparati: dal funk viscerale al jazz contaminato, da suggestioni pop ad omaggi rielaborati all’universo sonoro degli anni Ottanta, restituendo una tessitura policroma, per nulla derivativa. La scrittura degli arrangiamenti, affidata alla sapiente mano del M° Ivan Marini, non si limita ad un’operazione calligrafica, bensì plasma l’intero impianto timbrico secondo una logica interna, che tiene conto tanto delle peculiarità di ciascun interprete quanto delle geometrie dinamiche dell’ensemble. Ogni traccia delinea un microcosmo autonomo, in cui convergono riferimenti al canone afroamericano (Stevie Wonder, Tower of Power), echi orchestrali (Canadian Brass), fino a riletture trasfigurate (Nina Simone, Foo Fighters), il tutto filtrato da una cifra stilistica riconoscibile e coerente. Si percepisce un lavoro artigianale nella gestione dei pesi armonici, nella distribuzione delle tessiture, nella scelta accurata dei materiali sonori, spesso virati verso una grana espressiva corposa e mai stucchevole. L’intervento vocale di Irina Arozarena non funge da mero ornamento melodico, ma assume una funzione strutturale, abile nel dialogare con le masse ottonali in un contrappunto emotivo che amplifica l’impatto percettivo dell’ascolto. La scrittura per gli ottoni evita sia l’effetto fanfara che la saturazione da esercizio virtuosistico, preferendo un fraseggio cesellato, vibratile, ricco di sfumature dinamiche e di affondi ritmici sapientemente incastonati.
L’esecuzione, peraltro, beneficia della presenza di strumentisti con esperienze in ambiti artistici di assoluto rilievo – da Ennio Morricone a Gegè Telesforo, da Mario Biondi a Renzo Arbore – e questa pluralità di percorsi si riverbera in un suono collettivo opulento, stratificato, immune da qualsiasi appiattimento estetico. Particolarmente efficace risulta l’apertura affidata a «Do To Me», che grazie alla presenza del basso di Lorenzo Feliciati instaura subito una tensione propulsiva, agendo da catalizzatore per l’intero sviluppo successivo. Non si tratta semplicemente di un disco, ma di un’offerta estetica compiuta, che mette in crisi le barriere tra generi e ridefinisce la relazione fra interpreti e uditori. L’esperienza concertistica dei Brassense, infatti, non si esaurisce nella riproposizione dei materiali registrati, bensì si reinventa come rito collettivo, permeato da un’energia performativa che rifugge ogni forma di distanza liturgica tra palco e platea. Dedicato alla memoria di Rino Zurzolo, musicista e didatta dal profilo umano ed artistico difficilmente eguagliabile, questo lavoro rappresenta non solo un omaggio, ma una prosecuzione ideale di quella ricerca musicale votata all’autenticità ed alla profondità di una visione.
L’album si apre con «Do To Me» (T. M. Andrews, R. M. Montbleau), imponendosi per immediatezza fisica e consistenza timbrica. Il basso elettrico di Feliciati, carico di risonanze viscerali, guida l’intero sviluppo come una linea d’ombra felliniana su cui si costruisce un paesaggio sonoro articolato e pulsante. Il dialogo tra fiati e voce si colloca tra la sensualità di un soul urbano e la frenesia cromatica di un’opera di Jean-Michel Basquiat, pregna di complessità, sovrapposizione ed urgenza espressiva. Sul piano emotivo, l’impatto risulta diretto, quasi cinematografico, simile ad un montaggio serrato da videoclip anni ’90, ma con la lucidità formale di una sequenza firmata da Spike Lee. «Faith» di Stevie Wonder non una semplice cover, bensì un’esplorazione. Il materiale originario viene decostruito e poi ricomposto in chiave cameristica, con una propulsione ritmica che richiama i primi esperimenti del funk orchestrale. I fiati lavorano come pennellate veloci su un fondo monocromo, alla maniera di un’opera di David Hockney, fatta di leggerezza apparente, precisione formale e luminosità interiore. La voce, invece, agisce per opposizione, instillando una dose calibrata di pathos. Ne risulta una resa emotiva festosa, ma mai ingenua, dove ogni accento appare cesellato con cura quasi artigianale. In «Push It Up» (L.R. Ferguson, I. Khatchoyan, J.E. Mason) il registro si sposta su territori più aggressivi, intrisi di groove e tensione urbana. Il trattamento strumentale si fa muscolare, con gli ottoni che lavorano per strati, in un crescendo che richiama la logica visiva dei murales metropolitani, caratterizzata da segni veloci, contrasti netti e saturazioni cromatiche che sfondano la superficie. Emotivamente si avverte un senso di urgenza, di necessità comunicativa, affine a certa cinematografia di strada, tipica di La Haine, di Trainspotting, o degli incastri sincopati di Guy Ritchie. La forma si tende verso l’esterno, come se volesse uscire dallo spazio del disco per invadere quello reale. «Brassense Groove» (I. Marini) costituisce il manifesto estetico del collettivo, composizione che esplicita la grammatica fondativa del progetto. L’intelaiatura ritmica diventa struttura portante su cui si innestano cellule melodiche iterate, quasi a suggerire un moto perpetuo. Stilisticamente, l’andamento circolare ed il gioco tra pieni e vuoti ricordano le opere cinetiche di Jesús Rafael Soto, dove movimento reale e percezione soggettiva si annodano. L’effetto emotivo risulta ipnotico, ma non anestetizzante. Si tratta di un groove «pensante», che invita tanto al corpo quanto all’ascolto analitico. «Hole In My Pocket» (Ferguson, Khatchoyan, Mason) si sostanzia come un costrutto intriso di ironia ritmica, dove l’apparente disinvoltura della forma nasconde una scrittura minuziosa, giocata su contrasti e sincopi. Il fraseggio vocale suggerisce atmosfere alla Tarantino, fatte di divertissement elegante, con retrogusto noir. Strumentalmente, la scelta di mantenere un’impronta funkified con sfumature jazzate consente all’ensemble di muoversi con agilità, come in una coreografia urbana tra luci al neon e marciapiedi notturni. Il tutto conserva una qualità liquida, plastica ed affine alla street art più istintiva, ma profondamente pensata.
«Golden Tulip» (C. Ott) si manifesta come una composizione dal respiro più contemplativo, costruita su un impasto sonoro vellutato e introspettivo. Qui la sezione fiati si comporta come una velatura pittorica, simile a certe tele monocrome di Rothko, dove la forza risiede nella modulazione impercettibile del tono. L’emozione prevalente è quella del sospeso – non come assenza, ma come attesa gravida di senso. Il tema, quasi sussurrato, evoca spazi aperti, atmosfere da road movie in controluce, alla Wim Wenders. Il tutto vibra di una malinconia trattenuta, mai esplicitata. «Ain’t No Use (Modeliste, Neville, Porter Jr., Nocentelli) rappresenta un affondo nel funk più crudo, con una sezione ritmica che pulsa come una metropoli in stato d’assedio. I fiati si muovono in modo organico, come se respirassero insieme, restituendo un senso di compattezza quasi rituale. Si potrebbe pensare a una scena da Shaft o da Superfly, con luci basse, tensione costante, groove che non concede tregua. Dal punto di vista pittorico, la dinamica interna del componimento potrebbe accostarsi alle opere stratificate di Mark Bradford, fitte di materiali, cariche di storia e memoria sociale. L’impatto emotivo è dirompente e viscerale. In chiusura «The Pretender» (Shiflett, Grohl, Mendel, Hawkins), che sorprende per la capacità di trasformare un inno alt-rock in un’esplosione brassistica. L’arrangiamento trasfigura la materia originale in un vortice di linee ascendenti, come un’architettura sonora che si innalza verso l’alto. La tensione emotiva, sempre sotto controllo, si libera in un climax gestito con precisione chirurgica. Sul piano immaginifico, il brano evoca un’estetica da graphic novel, fatta di linee nette, contrasti violenti, dramma e catarsi. Il gruppo mette in scena una forma di resistenza sonora, che affonda le radici nella coralità e si emancipa dalla semplice cover. Il corpus delle otto tracce si attesta come una suite organica e multiforme, dove ogni segmento funge da tessera autonoma ed al contempo necessaria alla formazione di un mosaico più ampio. L’intersezione tra musica e altre arti non è un mero ornamento retorico, ma una chiave ermeneutica utile a comprendere la profondità progettuale dei Brassense, la forma pensante di un collettivo che suona il presente senza paura di sporcarlo, plasmandolo con consapevolezza e desiderio.