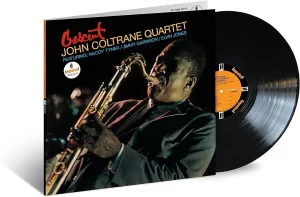La tromba sospesa: Kenny Wheeler e la dialettica tra jazz traslato e modernità

Kenny Wheeler
Wheeler s’inserisce in una genealogia trasversale, che include più poeti che trombettisti, più architetti del suono che solisti; la sua voce si affaccia sul bordo del jazz per contemplarlo, non per dominarlo. In questo sguardo obliquo, talvolta malinconico ma mai compiacente, risiede forse il tratto più distintivo e duraturo della sua arte.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Kenny Wheeler appare come figura liminale e silenziosamente rivoluzionaria nella storia del jazz del secondo Novecento, incarnando una poetica che rifugge tanto l’ostentazione virtuosistica quanto la calligrafia manierista. Nato a Toronto nel 1930, ma radicatosi stabilmente in Inghilterra a partire dal 1952, Wheeler ha saputo dar vita ad un itinerario artistico duplice, in cui coesistono la dedizione alla forma e alla misura del linguaggio post-bop e l’attrazione per i territori inclassificabili della libera improvvisazione. Laddove altri avrebbero avvertito un conflitto o una frattura, egli ha edificato una grammatica personale che fa dell’ambiguità e della porosità tra i generi il proprio asse generativo.
Nel fervido scenario londinese degli anni Sessanta, la sua figura emerse come crocevia fra due poli: da un lato, la lezione di Clifford Brown ed Art Farmer, da cui assimilò la cantabilità intensa e la lucentezza timbrica; dall’altro, il confronto con gli esponenti dell’improvvisazione radicale come John Stevens, Evan Parker, Dave Holland e Derek Bailey, con i quali condivideva un’adesione inquieta all’istante sonoro come terreno di indagine. L’osmosi tra questi due versanti, l’uno strutturato e l’altro anarchico, divenne matrice del suo stile compositivo ed improvvisativo, che si nutriva di contrasti fecondi: «Il free playing rilassava il mio modo convenzionale di suonare», osservava il trombettista, «e il suonare convenzionale dava forma ai miei assoli liberi». Le sue composizioni si distinguono per un uso sapiente degli intervalli, sovente arditi ed inattesi, tratti direttamente dall’esperienza improvvisativa, ma sempre incastonati entro architetture armoniche complesse, talora eccentriche, mai arbitrarie. L’influenza esercitata da orchestratori come Duke Ellington, Gil Evans e Stan Kenton risulta evidente non tanto nella superficie timbrica quanto nella capacità di scolpire lo spazio sonoro con equilibrio e visionarietà, mentre l’ascolto attento della musica colta del Novecento, da Hindemith a Bartók, ne alimentava il rigore costruttivo e l’attenzione per la densità polifonica. Il nucleo emotivo della sua scrittura resta tuttavia melodico, in cui ogni struttura si pone al servizio di un’intuizione lirica che sfugge tanto alla linearità narrativa quanto al sentimentalismo. Si ravvisa in Wheeler un culto della malinconia, non come languore estetizzante, ma come dispositivo critico. «La musica triste mi rende felice», confessava, evocando con affinità elettiva figure come Billie Holiday e Miles Davis, due archetipi di un’emotività trattenuta, crepuscolare, che nell’incompiutezza timbrica trova la propria verità. La svolta che ne consacrò l’autorevolezza su scala internazionale fu l’invito di Manfred Eicher a New York nel 1975 per la registrazione di «Gnu High», accanto a Keith Jarrett, Dave Holland e Jack DeJohnette. L’album, impastato di lirismo febbrile e geometrie rarefatte, rappresenta uno spartiacque: da quel momento Wheeler cessa di essere «un musicista per musicisti» per assumere lo statuto di compositore riconosciuto ed apprezzato da un pubblico più ampio, senza tuttavia tradire la propria indole appartata. La lunga collaborazione con l’etichetta ECM – sotto l’egida di una produzione sempre attenta a valorizzarne la scrittura obliqua e la timbrica vellutata – darà vita a numerosi progetti come leader di formazioni sia cameristiche che orchestrali, come membro del trio Azimuth insieme a John Taylor e Norma Winstone, come parte integrante del quintetto di Dave Holland e, ancora, come complice di musicisti dal lessico radicalmente differente, da John Abercrombie a Pierre Favre, da Bill Frisell a Ralph Towner, fino a Leo Smith. La sua voce trovava uguale dimora nei contesti più ascetici e rarefatti come nei territori incandescenti della Globe Unity Orchestra di Alexander Von Schlippenbach e della Berlin Contemporary Jazz Orchestra, in cui alcune sue partiture vennero eseguite e registrate, a testimonianza ulteriore della capacità del musicista canadese di dialogare con le dinamiche del grande ensemble senza cedere a rigidezze accademiche. L’ultimo tassello discografico, Songs for Quintet, inciso ad Abbey Road nel dicembre 2013, suggella con discrezione e nobiltà una traiettoria esistenziale interamente consacrata all’arte del suono pensante. Uscito postumo nel gennaio 2015 – proprio nel giorno in cui Wheeler avrebbe compiuto 85 anni – il disco risulta pervaso da una serena gravità, come se l’autore avesse voluto congedarsi lasciando in sospeso la domanda, mai la risposta.
L’accostamento di Kenny Wheeler ai grandi trombettisti afroamericani del Novecento richiede uno sguardo non solo stilistico, ma anche culturale e poetologico. Se da un lato egli si muove all’interno di un reticolo linguistico che deve molto all’eredità nera del jazz, da cui attinge grammatiche, gesti e simboli, dall’altro la sua voce appare collocata ai margini di quella stessa tradizione, per sensibilità, contesto e intenzionalità estetica. Ciò che lo lega a figure come Miles Davis, Booker Little, Clifford Brown e Don Cherry è, anzitutto, una comune tensione verso la sottrazione, l’abbandono dell’enfasi retorica in favore di un’espressività misurata, ambigua e talora ermetica. Come Davis, Wheeler predilige la suggestione all’affermazione, la sospensione alla risoluzione, la cesura al climax. Come Little, condivide un’idea di cantabilità inquieta, nutrita di silenzi ed intervalli obliqui. Come Cherry, guarda all’improvvisazione come atto esistenziale, aperto, anti-dogmatico. Tuttavia, laddove questi artisti operavano all’interno di una tradizione radicata in una storia di resistenza e rivendicazione culturale – quella afroamericana, segnata dal trauma, dalla diaspora e dall’urgenza identitaria – Wheeler pare muoversi secondo una traiettoria interiore più appartata, quasi post-identitaria, dove la malinconia non è protesta ma meditazione. In lui l’emozione non si fa grido, ma pensiero trattenuto; la spiritualità non è rito collettivo, bensì interrogazione individuale. La sua provenienza canadese e il successivo insediamento nella temperie anglosassone contribuiscono a situarlo in una geografia musicale altra, estranea sia all’estetica delle blue notes che alle impennate del soul-jazz. Non esiste in Wheeler traccia dell’urgenza panica di un Freddie Hubbard, né della matericità tellurica di un Lee Morgan. Laddove l’espressività afroamericana si costruisce spesso come gesto oppositivo, incarnato, corale, la voce di Wheeler pare muoversi in uno spazio rarefatto, intimista e talvolta ascetico. Le affinità più profonde si rilevano con musicisti mossi da una simile inquietudine formale ed emotiva, non necessariamente trombettisti. Paul Motian, con cui condivide una poetica della reticenza e dell’impermanenza, appare come un fratello spirituale. John Taylor, sodale nel trio Azimuth, rappresenta il compagno ideale per un’idea di interplay fondata sull’ascolto e sulla sospensione. Norma Winstone, voce evanescente e trasparente, restituisce con efficacia la dimensione elegiaca delle sue composizioni. Infine, sul versante della scrittura orchestrale, la parentela con Gil Evans appare evidente non tanto per imitazione quanto per affinità di pensiero. Entrambi trattano la densità timbrica come materia viva, permeabile ed in grado di respirare. Wheeler s’inserisce dunque in una genealogia trasversale, che include più poeti che trombettisti, più architetti del suono che solisti; la sua voce si affaccia sul bordo del jazz per contemplarlo, non per dominarlo. In questo sguardo obliquo, talvolta malinconico ma mai compiacente, risiede forse il tratto più distintivo e duraturo della sua arte.
Se la produzione di Kenny Wheeler, in quanto non statunitense, possa essere considerata derivativa o adattiva rispetto al paradigma afro-americano del jazz, tocca un nodo teorico cruciale, che investe non solo l’analisi musicale, ma anche la prospettiva culturale e geopolitica del discorso jazzistico. Occorre innanzitutto distinguere tra derivazione intesa come epigonismo sterile, e adattività come operazione di trapianto culturale complesso, capace di generare forme originali a partire da una matrice altra. In tal senso, definire l’opera di Wheeler come «derivativa» rischia di ricondurre la sua poetica a un semplice riflesso europeo del jazz afroamericano, laddove invece essa costituisce una rielaborazione profondamente personale, capace di metabolizzare l’eredità statunitense e, al contempo, di innestarvi istanze estranee al contesto originario. Risulta innegabile che la parabola di Wheeler si sviluppi ai margini dell’asse centrale del jazz afroamericano, da cui pure attinge materiali lessicali e dispositivi formali: dalla prassi dell’improvvisazione collettiva all’uso dell’interplay, dal fraseggio post-bop alla costruzione modulare dei temi. Tuttavia, l’assenza di una tensione bluesy marcata, il distacco dall’impulso swing quale forza propulsiva e, più in generale, la predilezione per atmosfere introverse, sospese, talora disincarnate, lo collocano su un versante estetico che potremmo definire traslato, se non propriamente para-jazzistico. Rebus sic stantibus, la sua piena sintonia con la poetica ECM – etichetta paradigmatica di un jazz europeo della rarefazione, e in larga parte disancorato dalle matrici afroamericane – accentua ulteriormente questa distanza. Il suono ECM, con la sua tendenza alla diafanità timbrica, alla temporalità dilatata, alla pulizia formale talvolta ascetica, ha spesso alimentato il sospetto di una sorta di «jazz evirato», privo di quella componente carnale, tellurica e rituale che costituisce l’ossatura storica del jazz nero. Wheeler, pur non rinunciando mai del tutto all’impulso jazzistico, s’innesta in questa traiettoria come uno degli esponenti più emblematici di un jazz che potremmo definire lirico-meditativo, in cui il retaggio afroamericano è trasfigurato, sottratto alla propria funzione originaria, talvolta persino sublimato in chiave cameristica. Tuttavia, liquidare questa operazione come derivativa equivarrebbe a misconoscere l’intelligenza formale e la specificità poetica dell’autore. Piuttosto, Wheeler potrebbe essere visto come uno dei principali artefici di un jazz post-identitario, nel quale l’elemento afroamericano non è soppresso ma messo tra parentesi, sottoposto a una sorta di distillazione spirituale e retorica. Laddove il blues viene spesso vissuto come gesto aurorale e affermazione di sé, in Wheeler esso diventa eco, fantasma, residuo emotivo. Il swing, più che impulso motorio, si fa fluttuazione, irregolarità respiratoria e battito interiore. A conti fatti, la sua produzione non va misurata con il metro della filiazione diretta dal jazz afroamericano, bensì come il risultato di un attraversamento culturale che implica sottrazioni, dislocamenti e riappropriazioni. Wheeler non imitava il jazz, ma ne abitava una possibilità laterale, e proprio in questa lateralità si annida la sua specificità poetica. Non è stato un epigono, ma un cartografo di zone marginali e sfuggenti, dove l’ombra del jazz si proiettava su territori ancora inesplorati.
Nel panorama italiano del secondo Novecento e oltre, Enrico Rava rappresenta senza dubbio la figura che più coerentemente si avvicina a Kenny Wheeler per affinità stilistiche, propensioni espressive e postura estetica. Tuttavia, la vicinanza tra i due non è tanto frutto di una parentela idiomatica nel senso stretto, quanto piuttosto il risultato di una convergenza poetica, maturata attraverso percorsi paralleli ma indipendenti, accomunati da una medesima tensione verso un jazz che si emancipi dalla retorica del gesto muscolare e trovi nella rarefazione, nella sospensione e nell’enigma melodico, la propria necessità. Entrambi operano una sorta di ritrazione della tromba dalla sua iconografia eroica, trasformandola da strumento assertivo e solistico – cifra del dominio fonico e scenico – a veicolo di meditazione, strumento del dubbio, della nuance e del non detto. In Wheeler, questo atteggiamento prende forma in una grammatica armonicamente ellittica, nutrita di dissonanze lievi, movimenti intervallari inattesi e un uso metamorfico del flicorno, spesso preferito alla tromba per il suo timbro crepuscolare. Rava, pur restando più fedele alla tromba in senso stretto, persegue una simile etica dell’assenza, in cui la nota emerge come riflesso più che come affermazione, e la melodia si presenta come scheggia evocativa, mai esposizione completa. Perfino sul piano della scrittura orchestrale e della concezione dell’ensemble, vi sono risonanze interessanti. Ambedue hanno saputo tessere trame cameristiche in contesti jazzistici, elaborando un’idea di collettivo che non coincide con la massa sonora, ma con l’articolazione delle voci come spettri in dialogo. Tuttavia, laddove Wheeler rivela un background più nutrito di rigore contrappuntistico, probabilmente alimentato dallo studio della musica colta mitteleuropea e dall’esperienza con l’ECM, Rava conserva una sensibilità più iconica e narrativa, in cui la dimensione europea si manifesta non tanto nella forma quanto nel pathos latente. Sul piano dell’espressività, la malinconia di Wheeler è di natura contemplativa, distaccata, talvolta quasi atarassica, al punto che il suo dolore sembra sempre velato, detto in terza persona, filtrato da uno sguardo che ha attraversato il silenzio. Rava, invece, elabora una malinconia più viscerale, più prossima al frammento lirico ed alla risonanza mediterranea, in cui l’eco del cinema, della letteratura novecentesca e dell’immaginario collettivo italiano si fa più udibile. Le sue linee melodiche, pur trattenute, sembrano talora sul punto di aprirsi ad un’emozione incontrollabile, come se contenessero l’onda prima del disastro. Infine, mentre Wheeler ha incarnato un ascetismo del suono portato alle estreme conseguenze nei paesaggi silenziosi dell’ECM, Rava ha mantenuto una vocazione più narrativa, anche ironica, più incline all’invenzione di maschere che alla ricerca dell’essenza pura. Su questo piano, Rava risulta forse più teatrale, più contaminato, anche visivamente, da una certa idea di personaggio, mentre Wheeler si è sempre sottratto a ogni costruzione identitaria appariscente, consegnandosi interamente alla propria musica. In conclusione, se esiste un luogo di incontro tra i due, esso risiede nella capacità di interrogare la tromba non come emblema di potenza, ma come dispositivo poetico, strumento attraverso cui ascoltare il silenzio, non sovrastarlo. Entrambi, con accenti diversi, appartengono a una genealogia laterale del jazz, ossia quella degli introversi, dei reticenti, dei cartografi dell’invisibile.

Il confronto tra Kenny Wheeler e Claudio Fasoli offre uno spunto prezioso per interrogare l’idea stessa di jazz traslato, inteso come spostamento semantico e topologico del linguaggio jazzistico oltre i suoi epicentri storici – afroamericani e statunitensi – verso forme di riflessione esistenziale, di astrazione lirica e di ibridazione culturale. Entrambi appartengono a quella genealogia europea che ha assorbito il lessico afroamericano non per imitarlo, ma per rifondarlo in un contesto altro, segnato da un diverso rapporto con la tradizione, con la corporeità del suono, con la funzione sociale e rituale della musica. Se Wheeler agisce entro una poetica della rarefazione, Fasoli si muove in un territorio affine, dove il jazz diventa linguaggio pervasivo ma non totalizzante, sempre disponibile al dialogo con il silenzio, con la forma aperta, con l’indeterminatezza come scelta etica prima che estetica. Sul piano stilistico, entrambi prediligono un fraseggio non assertivo, franto, inclinato verso la sospensione piuttosto che verso la risoluzione. Mentre, però, in Wheeler la malinconia sembra distendersi in un’atmosfera quasi metafisica o un lirismo che sfuma nell’indefinito, quasi ascetico, Fasoli sembra mantenere un legame più diretto con la corporeità del suono, pur nella sua tensione rarefatta. Il suo sax (soprattutto il tenore, ma anche il soprano) conserva una tessitura più materica, più terrigna, come se la vibrazione dell’ancia restituisse ancora un’eco del respiro originario del jazz, pur trasfigurato dalla distanza geografica e culturale. Un punto di contatto evidente risiede nella comune fiducia nella forma aperta e nell’improvvisazione come processo di pensiero in atto. Ciascuno dei due rifugge le strutture chiuse e simmetriche, prediligendo un’organizzazione mobile, policentrica, in cui ogni elemento del gruppo contribuisce alla costruzione di un flusso sonoro non gerarchico. Le rispettive scritture, pur differenti per impianto timbrico e retaggio armonico, condividono una vocazione a concepire l’ensemble come un organismo respirante, in cui le voci non si stratificano ma si intersecano, si rifrangono, si dissolvono l’una nell’altra. Un altro terreno comune è l’assenza di enfasi idiomatica, poiché né Wheeler né Fasoli fanno del jazz una questione di appartenenza culturale o di stile codificato. Piuttosto, entrambi trattano il jazz come un dispositivo generativo, un lessico aperto che può contenere la tonalità e la sua dissoluzione, la cantabilità e la sua negazione, la struttura e la sua erosione. In questo senso, la musica di Fasoli, come quella di Wheeler, si pone in una linea poetica vicina alla scrittura bianca di certo modernismo letterario, ossia una sintassi che rifugge il patetico e il didascalico, e che affida tutto alla qualità della linea, all’ambiguità della forma, all’irriducibilità del gesto. Tuttavia, alcune differenze sono decisive. Fasoli manifesta, anche nei momenti più rarefatti, una verticalità analitica che lo radica nella cultura mitteleuropea del pensiero formale: la sua musica sembra spesso ragionare su se stessa, porsi domande di struttura e di direzione, mentre Wheeler, pur consapevole architetto di forme, agisce secondo una logica più emozionale-evocativa, come se ogni nota fosse la traccia di un sentimento trattenuto, mai del tutto decifrabile. Dove Fasoli analizza l’orizzonte, Wheeler lo abita con l’aria di chi lo attraversa per sottrazione. Infine, il rapporto con la temporalità distingue profondamente i due. Wheeler tende a sospendere il tempo, costruendo uno spazio sonoro dilatato, quasi immobile, in cui la pulsazione risulta evanescente, interiorizzata. Fasoli, pur attento alla fluidità e alla variazione agogica, conserva una tensione ritmica più marcata, una memoria del tempo jazzistico, che non diventa mai urgenza metronomica ma che resta comunque presente come riferimento interno. In conclusione, tra Kenny Wheeler e Claudio Fasoli esiste un rapporto di prossimità poetica, non imitativa, fondato su una comune visione del jazz come lingua da rifondare piuttosto che da replicare. Entrambi contribuiscono a costruire un jazz europeo del pensiero, dove la liricità non è mai facile, dove l’improvvisazione è gesto critico e dove il suono, nella sua fragilità e nella sua forma mobile, diventa figura del tempo interiore.
Kenny Wheeler e Claudio Fasoli hanno avuto occasione di collaborare, ed uno degli esiti più rilevanti del loro incontro viene documentato nel disco «Welcome», pubblicato nel 1986 per l’etichetta Soul Note. Questo album, oggi oggetto di meritata riscoperta da parte di collezionisti e studiosi, testimonia un momento di particolare fecondità per il jazz europeo, in cui la convergenza di personalità affini produceva un linguaggio elegante e fortemente individuale, ben distante dagli stereotipi mainstream. In «Welcome», Fasoli guida un ensemble cameristico e meticolosamente calibrato, che accoglie Wheeler in qualità di ospite, ma in realtà l’interazione fra i due rivela un equilibrio profondo, non gerarchico, in cui le voci si intrecciano come linee contrappuntistiche in una partitura fluida e sempre mobile. Il gruppo include anche Jean-François Jenny-Clark al contrabbasso e Daniel Humair alla batteria, due personaggi cardine dell’avant-garde europea, capaci di operare sul crinale fra pulsazione e rarefazione, ancoraggio tonale e disgregazione ritmica. Il disco si struttura come un insieme coeso, non frammentario, in cui ogni traccia s’inscrive in una poetica della continuità, della tensione verso l’unità formale pur nel libero fluire dell’improvvisazione. Wheeler vi appare in stato di grazia, con il suo flicorno emana un calore meditativo che ben si sposa con il fraseggio essenziale e affilato di Fasoli, mai ridondante, sempre pronto a lasciare spazio all’ascolto. I due non si rincorrono, né si sovrappongono, ma sembrano piuttosto disegnare a distanza una forma condivisa, come due calligrafie che, pur diverse, rispondono alla medesima idea di silenzio, di sospensione e di tensione verso un altrove. Nonostante la registrazione si collochi a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, periodo spesso segnato da produzioni sovraccariche e da derive fusion, «Welcome» si distingue per una sobrietà formale ed una lucidità di pensiero che lo rendono anacronistico nel miglior senso del termine. Il suono appare asciutto, privo di compiacimenti timbrici, tutto è votato alla ricerca di una sintesi fra forma ed improvvisazione, lirismo ed astrazione. Questa collaborazione rappresenta una convergenza emblematica di due modi di intendere il jazz non come territorio di appartenenza identitaria, bensì come linguaggio aperto, capace di assorbire il silenzio europeo, la ricchezza del pensiero formale e la libertà dell’improvvisazione afroamericana senza mai ridursi ad semplice collage. «Welcome» costituisce non soltanto un documento storico di alto profilo, ma anche una manifestazione limpida di quel jazz traslato di cui entrambi, Fasoli e Wheeler, sono tra i più lucidi interpreti; un jazz che non rinnega le sue radici, ma le sublima in un tempo altro, più riflessivo, più appartato, più vicino alla poesia che all’intrattenimento.
«If Only» apre il disco con un’atmosfera di lieve tensione sospesa, quasi un’ipotesi mai del tutto formulata, incarnata nella scelta di un tempo moderato e di un fraseggio fluido ma trattenuto. Le note di Wheeler si dispiegano con ampi intervalli, tratteggiando una linea melodica che sembra inseguire un ideale sfuggente, un rimpianto non dichiarato. Fasoli risponde con un sax dal timbro tenue, quasi un sussurro, come a confermare questa dimensione di sottrazione emotiva. La struttura armonica si fonda su accordi di nona e undicesima che fluttuano senza risoluzioni definitive, conferendo all’insieme una qualità «aperta» e vagamente indefinita. L’interazione ritmica, affidata a Daniel Humair e Jenny-Clark, appare discreta, oscillante tra marcature liquide e sospensioni che favoriscono l’ampiezza spaziale del dialogo. La tromba (o più spesso il flicorno) di Wheeler si sovrappone con discrezione, introducendo una linea melodica costruita su intervalli ampi, quasi a mimare l’eco di un pensiero che si srotola nel vuoto. L’armonia si appoggia su accordi sospesi, con quinte e none lasciate aperte, mai chiuse su risoluzioni cadenzali: una grammatica che predilige la suggestione tonale piuttosto che l’affermazione funzionale. Nel proseguo, «Invisible Sound» intensifica l’indagine sul piano dell’astrazione sonora: il titolo allude con efficacia a un’impronta acustica che si percepisce senza manifestarsi direttamente. Il sax soprano di Fasoli percorre sentieri improvvisativi segnati da dinamiche mutevoli e timbri sfumati, come sospesi in un ambiente rarefatto. La tromba di Wheeler, meno lineare, costruisce fraseggi ricchi di cromatismi e intervalli dissonanti, evocando un paesaggio emotivo denso di ambivalenze. La struttura armonica qui si sposta verso un uso più frequente di scale modali e passaggi per cluster, quasi a suggerire un’eco delle avanguardie europee, ma filtrate da un lirismo mai tradito, trasformando il dialogo tra Wheeler e Fasoli in un vero e proprio contrappunto timbrico. Il sax soprano, qui impiegato da Fasoli con misura quasi ascetica, insegue le inflessioni liquide del flicorno, generando un intreccio che richiama certe astrazioni della Third Stream, ma senza la freddezza accademica che spesso le accompagna. Si avverte una pulsazione sotterranea, più suggerita che dichiarata, che guida l’improvvisazione verso uno sviluppo orizzontale, svincolato da climax o strutture tripartite. La terza composizione, «Emptiness», costituisce un vero e proprio fulcro espressivo e concettuale del disco. Il titolo si fa manifesto attraverso una musica che sfida ogni pienezza e compiutezza, privilegiando l’idea del vuoto come forma sonora. Wheeler modula su intervalli ampi, ma con una soffusa malinconia, attraverso frammenti melodici che sembrano citazioni interiori, reminiscenze di un blues spettrale, purissimo nella sua assenza di cliché. La tonalità si sfalda in un’ambiguità modale, quasi debussiana, in cui il centro tonale è sempre ritardato, dislocato, evocato più che nominato. Dal canto suo, Fasoli accarezza note lunghe, quasi sospese, che si adagiano su una base ritmica volutamente rarefatta e destrutturata. L’armonia si sottrae a ogni riferimento tonale stabile, oscillando fra accordi sospesi, pedal point indefiniti e improvvisazioni libere, senza cadere però nel caos. L’estetica dell’assenza si traduce in un invito all’ascolto attento, a cogliere il valore di ogni silenzio e di ogni pausa. Con «Epic», il disco introduce un contrasto netto, in cui la brevità e l’intensità del pezzo evocano un gesto quasi aforistico. Fasoli suona con un controllo del respiro e della dinamica che sfiora l’ascetismo, dove ogni nota distilla un frammento di silenzio inciso, un stilla di luce in penombra. Wheeler, da par suo, disegna linee che ricordano certi lamenti modali mediorientali, in un contesto armonico che alterna triadi aumentate, accordi di settima con la quinta diminuita e impasti tonali senza gerarchie. Il contrabbasso di Jenny-Clark non fornisce fondamento, ma interferenze armoniche, quasi armonici artificiali inseriti con sapienza nel tessuto sonoro. Nonostante la durata ridotta, la traccia non rinuncia all’opulenza espressiva, mentre la ritmica si fa più marcata. L’approccio armonico, pur restando complesso, predilige passaggi più definiti, con accenti improvvisi e tensioni dissonanti che sembrano interrompere il fluire del tempo in modo quasi teatrale. Fasoli risponde con un contrappunto serrato, spezzato, capace di restituire la frammentarietà implicita nel titolo. Il titolo successivo, «Oblivion», riprende e approfondisce il clima di sospensione meditativa, mentre si percepisce la sensazione di un lento dissolversi, di una scomparsa progressiva che trova nella musica la propria traduzione più efficace. Wheeler articola frasi dai contorni sfumati, spesso sul registro grave, mentre Fasoli adopera un approccio più rarefatto e accennato, giocando con il timbro del sax per sottolineare la dimensione eterea del pezzo; si avverte una tensione lirica più esplicita, pur sempre trattenuta, specie dove Wheeler tocca il registro acuto con un controllo timbrico che non cerca mai l’esplosione, ma la vibrazione interna, quasi intima, della nota. Fasoli sembra ripercorrere la memoria del jazz, ma senza nostalgia. Le sue linee ricordano Tristano, Warne Marsh, ma anche il Debussy più rarefatto. La sezione ritmica mantiene un’andatura fluttuante, con un uso sapiente del silenzio e delle pause, mentre le scelte armoniche si muovono fra modi dorico e lidio, alimentando un senso di immobilità dinamica. «Sagittario» introduce una componente più narrativa, quasi programmatica, tanto che il nome rimanda a un archetipo simbolico di dinamismo, movimento e tensione verso il bersaglio. La musica riflette questa idea attraverso un aumento del respiro melodico e una maggiore articolazione ritmica. Wheeler affonda la sua linea in un fraseggio più lirico, con passaggi diatonici alternati a momenti di dissonanza studiata, mentre Fasoli amplia il proprio registro, passando dal soprano al tenore con una flessibilità che conferisce varietà timbrica al dialogo. Le armonie si fanno più esplicite, con moduli che richiamano la tradizione jazzistica ma reinterpretati con sensibilità contemporanea, creando un effetto di sospensione tra passato e presente. Il penultimo motivo, «Zen», racchiude in sé la quintessenza della filosofia estetica del disco. La musica si fa essenziale, contemplativa, sospesa nel tempo. Wheeler e Fasoli si cimentano in un dialogo in cui la rarefazione è parola d’ordine, dove ogni nota risulta misurata, ponderata, quasi un segno calligrafico. La sezione ritmica, delicata e attenta, si pone al servizio di un discorso che privilegia la qualità del suono e la sua spazialità. L’armonia si dispiega attraverso pedali minimi e accordi sparsi, spesso privi di funzione tonale, mentre l’approccio improvvisativo privilegia la sottrazione piuttosto che l’aggiunta, con pause e silenzi che definiscono lo spazio stesso del discorso. Chiude il lavoro, in modo emblematico, la traccia intitolata «Welcome», ossia una breve meditazione, un invito sommesso a entrare in uno spazio di ascolto e riflessione. Wheeler sussurra note dal flicorno con una dolcezza intima, mentre Fasoli risponde con poche frasi essenziali, creando un contrappunto lirico che sembra simbolizzare il dialogo tra due anime musicali affini. L’armonia è trasparente, quasi evanescente, e il tempo dilatato all’estremo, come per sottolineare la funzione di apertura e chiusura che il pezzo esercita nell’economia complessiva del disco. Nessun epilogo trionfale, nessuna sintesi, piuttosto, un invito all’ascolto continuo, alla percezione del non-finito come gesto musicale. Le armonie si disfano in campi tonali aperti, senza centro, mentre Wheeler affida alle ultime note un’emozione trattenuta e irreversibile. Il sax di Fasoli sembra rispondere da lontano, come se la musica stesse già svanendo, non nella memoria, ma nel tempo stesso. «Welcome» non è un disco a tema, né un lotto di prove solistiche, bensì un organismo vivente, articolato attorno ad un’estetica dell’impermanenza e dell’ascolto reciproco. L’interazione tra Wheeler e Fasoli non si basa su call and response né su gerarchie improvvisative, ma su una grammatica comune fondata sulla leggerezza, sull’assenza di peso retorico, sull’equilibrio tra scrittura e voce interiore. In questo incontro, il jazz si trasfigura, oltrepassando il concetto di linguaggio identitario e divenendo, per contro, forma del pensiero, veicolo poetico ed occasione di sparizione controllata.

La discografia di Kenny Wheeler si presenta come un affresco complesso e raffinato, in cui ogni incisione rivela sfumature emozionali e sperimentazioni armoniche capaci di tracciare il profilo di un’artista in costante dialogo con le tensioni del jazz moderno e della musica contemporanea. Cinque album, in particolare, si ergono come pilastri fondamentali di questo percorso, offrendo un panorama espressivo e tecnico di straordinaria ricchezza. «Gnu High» (1975) rappresenta uno spartiacque nella carriera di Wheeler, suggellando l’incontro con l’etichetta ECM e la collaborazione con musicisti come Keith Jarrett, Dave Holland e Jack DeJohnette. «Smatter», la traccia d’apertura espone un lirismo modale rarefatto; Wheeler gioca su intervalli ampi mentre Jarrett inserisce commenti armonici improvvisati che fanno da contrappunto sospeso, vibrando come echi interiori. «Everybody’s Song But My Own» è una ballata dilatata che tocca una melanconia sussurrata; la tromba evoca una linea flebile, fatta di sospiri, mentre l’accompagnamento ritmico fluisce in silenzio sommesso, conferendo all’insieme un’aura contemplativa. L’atmosfera dell’album è pervasa da un lirismo meditativo che sfocia in spazi aperti e rarefatti, dove la tromba di Wheeler si eleva con un fraseggio fluido, intessuto di ampi intervalli e tensioni non risolte. La struttura armonica riflette un uso sapiente di modulazioni modali e accordi sospesi, veicolando un senso di sospensione temporale che si traduce in un ascolto contemplativo e avvolgente. In «Deer Wan» (1977), sempre per ECM, Wheeler espande ulteriormente la sua tavolozza sonora, articolando composizioni che oscillano tra un lirismo intensamente malinconico e momenti di libera improvvisazione strutturata. Jan Garbarek (sax soprano), John Abercrombie (chitarra), Dave Holland (contrabbasso), Jack DeJohnette (batteria) L’atmosfera si dilata ulteriormente, con tessiture timbriche incandescenti e paesaggi emotivi rarefatti ma intensi. «Peace For Five» nasce da una progressione lenta ma carica di tensione interiore; le armonie si distendono in cluster sottili, sospesi in spazi armonici indefiniti. Il fraseggio di Wheeler si fa più dialogico, come se cercasse un contatto diluito nel non-detto. «Deer Wan» sviluppa un lirismo morbido a dissonanze lievi; Garbarek e Wheeler si guardano senza sovrapporsi, trattenendo ogni parola in un dialogo timbrico di rara eleganza. L’intreccio timbrico si arricchisce di arrangiamenti sofisticati, dove le armonie si fanno più complesse e stratificate, integrando cluster e dissonanze di raffinata eleganza. Il senso emotivo dell’album si sviluppa su un continuum che attraversa introspezione, delicatezza e un’ineffabile nostalgia, sostenuto da una tensione armonica che sfida le convenzioni tonali.
«Flutter By» (1988) si caratterizza per un approccio più intimista e raccolto, in cui Wheeler approfondisce la ricerca di una melodia sussurrata, quasi evanescente, e di un fraseggio misurato che privilegia il senso dello spazio e della sospensione. Jon Christensen (batteria), John Taylor (piano), Dave Holland (contrabbasso) «Ma Belle Hélène» si sostanzia come un incanto sospeso aperto da piano e contrabbasso; Wheeler disegna una linea tremante, che non cerca la conclusione ma piuttosto l’aria tra le note. «Flutter By», il motivo eponimo, assume il ritmo di un battito leggero, quasi impercettibile; le armonie sono sospese, il fraseggio altrettanto elusivo, in un’incarnazione del minimalismo lirico. Le progressioni armoniche risultano più scarne ma non meno suggestive, puntellate da accenti occasionali di cromatismo e da una ritmica rilassata che favorisce una respirazione musicale pacata, quasi meditativa. L’estetica sonora si muove tra delicatezza e tensione appena accennata, suggerendo un dialogo intimo e personale. «Angel Song» (1997) testimonia una maturazione stilistica che coniuga lirismo e complessità formale, con un ensemble di musicisti di altissimo livello che valorizzano la tessitura compositiva di Wheeler. Lee Konitz (sax alto), Bill Frisell (chitarra), Dave Holland (contrabbasso) e Jon Christensen (batteria), un ensemble eterogeneo che amplifica la sensibilità compositiva di Wheeler, avvolgendola in un’aura sofisticata e poetica. «Peau Douce» rappresenta un dialogo tra linee filtrate, come carezze timbriche; l’armonia si distende in silenzi pienamente musicali, vibranti nella loro leggerezza. «Quintet and Duo» alterna momenti solisti appesi, quasi sospesi, a sezioni in cui l’ensemble si ricompone in un respiro collettivo, sospeso tra malinconia e dolcezza meditativa. L’armonia si fa più articolata e varia, attraversando passaggi diatonici e momenti di dissonanza controllata, mentre l’emotività si fa più incisiva, oscillando tra malinconia e dolcezza. L’estetica complessiva si impone come una sintesi armonica e melodica, capace di fondere tradizione e innovazione con naturalezza e rigore. Infine, «Songs for Quintet» (2015), l’ultimo lavoro registrato poco prima della scomparsa di Wheeler, si presenta come un testamento artistico nel quale convergono le sue esperienze compositive e improvvisative. John Taylor (piano), Dave Holland (contrabbasso), Chris Laurence (contrabbasso) e Pete Erskine (batteria). Ultimo sguardo discografico, profondamente introspettivo e riflessivo: «Craig’s Song» si basa su trattenuto, essenziale; Wheeler scioglie poche note sospese sopra un tappeto armonico quasi impercettibile, che tuttavia contiene una tensione emotiva intensa e silenziosa. «Column» respira di moduli armonici che si dilungano; il contrabbasso è più presente, ma mai invasivo, sostenendo con discrezione una linea melodica sostenuta da armonie sottili. La scrittura si mostra matura, equilibrata tra la ricerca melodica e la libertà espressiva, con un uso raffinato delle modulazioni armoniche che crea atmosfere intense e contemplative. Il fraseggio di Wheeler si fa più introspettivo e pacato, mentre l’interplay con il gruppo evidenzia una profonda empatia sonora, rendendo l’album un monumento di quieta intensità emotiva e raffinata eleganza tecnica. In sintesi, attraverso questi cinque album, Kenny Wheeler emerge come un artista capace di fondere un lirismo meditativo a una sofisticata esplorazione armonica, ponendo sempre al centro la melodia e la tensione emotiva, in un equilibrio fluido tra tradizione e sperimentazione.