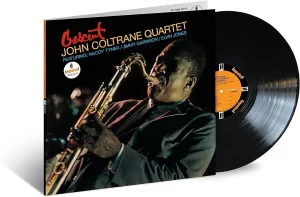Don Cherry: l’eco di un futuro mai del tutto compiuto, un orizzonte di possibilità sonore sospeso tra utopia e memoria

Don Cherry / Ornette Coleman
Cherry, pur muovendosi in un’epoca segnata dall’esplosione del free jazz e dall’apertura multiculturale, ha mantenuto un analogo disinteresse per la brillantezza virtuosistica fine a sé stessa, scegliendo di fare della propria voce strumentale un canale emotivo diretto, a volte volutamente fragile, altre volte icasticamente ruvida.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Don Cherry incarnò una singolare condizione di nomade sonoro, capace di trasfigurare il lessico del jazz in un linguaggio visionario, che travalicava generi, geografie e convenzioni. Nato da una madre di ascendenza Choctaw e da un padre trombettista dilettante, crebbe immerso in una dimensione in cui l’oralità, la memoria e la pratica musicale costituivano veicoli di conoscenza e di relazione. La sua traiettoria iniziale, segnata dal sodalizio con Ornette Coleman, si inscrive in quella rivoluzione armolodica che dissolse le gerarchie dell’armonia funzionale, proiettando la musica in un territorio dove melodia, timbro ed impulso ritmico si muovevano secondo logiche autonome. In quel quartetto, la sua tromba tascabile – una cornetta ottocentesca in si♭ dal suono arcaico e sfumato – fungeva da contrappunto lirico al sassofono plastico di Coleman, unendo fragilità materica e ardore inventivo.
L’incontro con Ornette Coleman segnò, infatti, un punto di non ritorno nella formazione di Don Cherry, inaugurando un sodalizio che, per intensità e conseguenze, può essere letto come una delle matrici originarie del jazz più anarcoide. In quel quartetto, completato da Charlie Haden e Billy Higgins, poi Ed Blackwell, Cherry divenne il catalizzatore di un dialogo in cui la melodia, anziché fungere da premessa a sviluppi armonici predefiniti, si configurava come matrice germinativa di un discorso in continua metamorfosi. La celebre teoria armolodica di Coleman, che mirava a mettere melodia, armonia e ritmo sul medesimo piano gerarchico, trovò nella tromba tascabile di Cherry un veicolo di traduzione immediata, in cui il suo fraseggio, intriso di microvariazioni timbriche e intonative, rifiutava la retorica virtuosistica per abbracciare un’essenzialità lirica, quasi epigrammatica. La relazione tra i due musicisti possedeva tratti di vera e propria simbiosi creativa. Coleman offriva un contesto armonicamente aperto, privo di vincoli tonali rigidi, e Cherry, con il suo approccio intuitivo e narrativo, ne occupava gli spazi come un pittore che, di fronte a una tela senza griglie prospettiche, potesse impregnarla di segni e colori con libertà primigenia. Questa interazione generava un continuum sonoro in cui gli assoli si intrecciavano senza soluzione di continuità, alternando densità incalzanti a sospensioni rarefatte, fino a dissolvere il concetto stesso di chorus o di chorus-based improvisation. Il loro lavoro comune contribuì a legittimare il free jazz come linguaggio non solo di rottura, ma di costruzione di un nuovo paradigma estetico, ossia una musica che accoglieva le inflessioni del blues e le cellule tematiche folk con la stessa naturalezza con cui integrava accenti mediorientali o ritmi africani. In questo senso, il rapporto Cherry–Coleman non fu semplicemente quello di due co-leader, ma l’espressione di un’osmosi culturale e poetica, destinata a influenzare intere generazioni di improvvisatori.
L’alleanza artistica con Leandro «Gato» Barbieri rappresentò per Don Cherry un capitolo cruciale nella costruzione di un lessico improvvisativo a vocazione planetaria. Insieme diedero vita a una musica febbrile e visionaria, capace di incorporare, nell’arco di un’unica performance, frammenti melodici di provenienza disparata: dal tango deformato in chiave free form alle cellule ritmiche afro-cubane, dai rag indiani ai lamenti mediorientali. La tessitura sonora che scaturiva da questa complicità era un vero mosaico nomade, nel quale i confini tra tradizione ed invenzione evaporavano. La tromba tascabile di Cherry, dal timbro argenteo e penetrante, si avvolgeva attorno al sassofono tenore di Barbieri come un contrappunto mobile, alternando linee scarne ed oblique a scatti melodici di inattesa cantabilità. Barbieri, con il suo suono graffiato ed incendiario, sembrava a tratti trascinare l’ensemble in un vortice quasi chamánico, mentre Cherry interveniva a deflagrare o ricomporre la trama, innescando svolte improvvise di direzione. In tale dialettica, la narrazione musicale si costruiva per accumulo di episodi e deviazioni, secondo una logica più affine all’oralità rituale che alla forma jazzistica canonica. Ne derivava un’estetica dell’erranza sonora, dove l’improvvisazione non era fine a se stessa, ma veicolo per un racconto polifonico delle geografie interiori e reali attraversate dai due. La loro collaborazione non solo ampliò le possibilità timbriche e narrative del free jazz, ma prefigurò, con decenni d’anticipo, le ibridazioni transculturali che sarebbero poi state etichettate come world music.
Sin dai tardi anni Sessanta, Cherry varcò la soglia di un percorso esclusivamente jazzistico per intraprendere una ricerca di respiro antropologico, in cui la musica diventava terreno d’incontro tra tradizioni lontane. In anticipo sui fenomeni mediatici della world music, concepì un neo-folklore radicale, in cui strumenti e idiomi provenienti da Africa, Asia, Americhe e Nord Europa si fondevano in un continuum organico. Più che un’operazione di sincretismo estetico, era una pratica di comunione: l’arte e la vita si saldavano in un unico gesto, come testimonia l’esperienza dell’Organic Music Theatre insieme a Moki Karlsson, Nana Vasconcelos e altri sodali, dove concerti e scenografie, suono e gesto, si intrecciavano in una ritualità collettiva. Il nomadismo di Cherry non era un mero peregrinare geografico, ma un’erranza interiore nutrita di letture, incontri e meditazioni. Come un Gauguin della sonorità, o un Thoreau armato di cornetta, cercava paesaggi musicali ancora inesplorati, dove il sacro ed il quotidiano potessero convivere senza gerarchie. La sua estetica accoglieva tanto la compostezza di un raga hindustano quanto la sferzata improvvisa di un canto berbero, l’ostinato poliritmico delle percussioni ewe quanto le volute minimali di un tema modale.
Miles Davis ebbe sempre un rapporto ambivalente con Don Cherry, che si intrecciava a una posizione complessivamente scettica, se non apertamente critica, verso il free jazz nella sua accezione più radicale. Per Miles, l’arte dell’improvvisazione doveva poggiare su un’architettura ritmica e armonica solida, anche quando questa veniva dilatata o sovvertita, come accade nei suoi lavori modali di fine anni ’50. Il linguaggio di Ornette Coleman e, per estensione, di Don Cherry, gli appariva invece troppo privo di ancoraggi strutturali: un’energia affascinante ma, ai suoi occhi, priva di direzione definita. Non di rado, nelle interviste, Miles liquidava il free jazz come un insieme di “suoni senza logica”, un flusso in cui la rottura dei codici tradizionali si traduceva in una perdita di tensione narrativa. Sul piano personale, Davis nutriva una certa diffidenza verso la tromba tascabile di Cherry, uno strumento considerato marginale nel repertorio jazzistico e associato, più che ad una scelta estetica deliberata, ad una sorta di eccentricità. In conversazioni riportate da testimoni, Miles definiva quel suono acerbo ed imperfetto, incapace di reggere il confronto con la potenza di una tre pistoni standard. Questo giudizio tecnico si accompagnava a un disinteresse per la dimensione nomadica e multiculturale che Cherry stava elaborando. Per Davis, la vera innovazione doveva avvenire nel cuore della modernità urbana afroamericana, non nei sincretismi etnici o nei rituali extra-occidentali. Nonostante tali distanze, è interessante notare che Miles non fu mai del tutto impermeabile a certe intuizioni del free. Pur restando distante dal linguaggio di Coleman e Cherry, negli anni Settanta integrò nella propria estetica alcuni principi di libertà formale e di flessibilità ritmica che erano stati proprio il marchio di fabbrica del movimento free. Si può dire, dunque, che il giudizio di Miles su Don Cherry fu critico e talvolta sprezzante, ma che, sul piano sotterraneo, il confronto con quella generazione di musicisti contribuì a ridefinire, anche per contrasto, la traiettoria della sua stessa musica.
Il paragone fra Don Cherry e Bix Beiderbecke, a prima vista, potrebbe sembrare un esercizio di pura suggestione: due cornettisti separati da quasi mezzo secolo, cresciuti in contesti sociali, geografici e musicali radicalmente differenti, inscritti in tradizioni sonore apparentemente inconciliabili. Eppure, se si scava oltre la superficie cronologica e stilistica, emergono affinità sotterranee che fanno pensare ad un filo comune, sottile ma resistente, teso attraverso la storia del jazz. Bix Beiderbecke, figura-icona del jazz anni Venti, incarnava un lirismo modernista, intimamente legato alla melodia e ad un senso di purezza timbrica che si sottraeva tanto al virtuosismo funambolico di un Louis Armstrong quanto alla routine orchestrale di molta musica da ballo dell’epoca. Il suo fraseggio, pieno di spazi e di sospensioni, era l’equivalente sonoro di certe tele impressioniste, dove l’oggetto non è mai rappresentato con i contorni netti, ma suggerito con bagliori, dissolvenze, cromie morbide. Cherry, pur muovendosi in un’epoca segnata dall’esplosione del free jazz e dall’apertura multiculturale, ha mantenuto un analogo disinteresse per la brillantezza virtuosistica fine a sé stessa, scegliendo di fare della propria voce strumentale un canale emotivo diretto, a volte volutamente fragile, altre volte icasticamente ruvida. La loro comune eresia consiste nel mettere al centro dell’improvvisazione non la costruzione armonica serrata o la perfezione tecnica, ma il respiro del suono, l’irregolarità viva della frase, l’imprevisto come valore. In entrambi, il silenzio è parte integrante del discorso: Bix lo usava come prolungamento del colore armonico; Cherry come tensione sospesa o quale spazio rituale. Tuttavia, le differenze sono altrettanto decisive. Beiderbecke rimase saldamente ancorato a un contesto tonale ed a forme canoniche (chorus di 32 battute, blues), mentre Cherry smantellò sistematicamente la funzione armonica ed i vincoli formali, spingendosi verso la modulazione modale aperta e il nomadismo timbrico. Bix fu un poeta della città degli anni ruggenti, Don un viandante planetario. A unirli, più che lo stile, esiste una disposizione d’animo, poiché entrambi sembrano suonare come se fossero sempre alla ricerca di un luogo altro: Beiderbecke di un Eden melodico che la modernità stava già erodendo e Cherry di una terra ritrovata, capace di accogliere tutte le culture in un unico orizzonte sonoro. Se il primo è la voce malinconica di un sogno americano ancora giovane, il secondo rappresenta la coscienza utopica di un mondo che sa di non poter più credere nelle frontiere, ma continua ostinatamente a cercare un canto che le dissolva.

Negli anni trascorsi in Svezia, Cherry s’inserì in un crocevia culturale animato da musicisti provenienti da Turchia, Sudafrica, Scandinavia e Asia, partecipando alla creazione di un laboratorio cosmopolita in cui i confini musicali si facevano porosi. In quelle comuni immerse nella natura, dove la cultura politica di Olof Palme favoriva una vitalità artistica diffusa, il cornettista affinò la sua idea di jazz come forza primaria di coesione sociale, una liturgia pan-tribale capace di annullare la distanza tra il locale e l’universale. Il suo strumentario, scelto più per affinità emotiva che per ortodossia tecnica, comprendeva oltre alla tromba tascabile strumenti a corda africani, flauti, percussioni, melodiche, tutti piegati a un uso non convenzionale. La sua arte, pervasivamente spirituale, non derivava soltanto da una tensione contemplativa, ma incorporava il tumulto, la frattura e la giocosità infantile, oscillando tra caos ed armonia in un equilibrio instabile ma vitale. In questo senso, la sua «musica organica» si può leggere come un commento sonoro alle teorie di Hazrat Inayat Khan sul carattere divino della musica, unica fra le arti a non dipendere da forme visive o oggettuali. Cherry costruiva ponti tra epoche e luoghi con la stessa naturalezza con cui improvvisava, facendo convivere nella stessa costellazione nomi e sensibilità apparentemente inconciliabili come Thelonious Monk e Terry Riley, Ornette Coleman e Dollar Brand, Thomas Mapfumo e Rolando Alphonso. In ogni sua esibizione – sia che si svolgesse in un club scandinavo, in un parco cittadino o in una sala della RAI allestita con arazzi tibetani – riaffiorava quell’anelito a varcare il punto estremo e spostare l’orizzonte che ne definì l’operato.
La linea formale dei concerti e delle incisioni del cornettista non obbediva a mappature armoniche preordinate ma a un principio di giustapposizione e trasformazione. Centri modali, droni e ostinati costituivano campi di gravità attorno ai quali le frasi prendevano corpo e si disfacevano, mentre l’improvvisazione prendeva la forma di dialogo plurale: non concorrenza virtuosa tra solista e accompagnamento, bensì tessitura dialogica in cui l’intensità timbrica e la qualità dell’atto sonoro decidevano il passaggio successivo. In tale orizzonte la poliritmia non era mera sovrapposizione metrico-ritmica ma elemento di stratificazione temporale, capace di produrre tensioni e risoluzioni senza ricorrere alla funzione armonica tradizionale; il risultato si presentava come una narrazione polifonica, in cui episodi diversi si concatenavano per affinità tematiche e immaginative più che per concatenazioni modali rigide. L’estetica che anima l’opera di Cherry si connota per una spiritualità laica e partecipativa, concepita come pratica comunitaria e rito condiviso. La sua musica non pretendeva di separare il sacro dal quotidiano: il concerto poteva farsi cerimonia domestica, la scena un villaggio in cui si intrecciano gesti, parole e danze — come accadeva nelle incarnazioni dell’“Organic Music Theatre” o nelle performance ricordate nel disco «Om Shanti Om». Tale visione implica una politica dell’ascolto che sostituisce la gerarchia dell’autore con la responsabilità collettiva dell’esperienza sonora; perciò l’eredità di Cherry non si limita a una serie di innovazioni tecniche, ma si espande in un modello di pratica musicale capace di ridefinire il rapporto tra identità culturale e orizzonte universale, tra memoria ancestrale e progetto utopico del presente.
Fra la vasta costellazione discografica di Don Cherry, alcuni titoli assumono il peso di veri e propri nodi cardinali, dove l’itinerario estetico ed emotivo del trombettista si manifesta con chiarezza quasi epifanica e la scrittura, pur nella sua natura aperta, rivela un’intima architettura pentagrammatica. In «Complete Communion» (1966), inciso per la Blue Note con Gato Barbieri, Henry Grimes ed Edward Blackwell, si assiste a un ribaltamento dei modelli formali del jazz post-bop. Le quattro suite che compongono l’album si susseguono senza interruzione, saldandosi per affinità tematica e transizioni improvvisate. Il materiale melodico, spesso fondato su cellule intervallari minime (seconda minore, quarta giusta, quinta diminuita), diventa germe per sviluppi collettivi più che per assoli isolati. L’accordalità non si struttura su una progressione funzionale, bensì su pedali modali, talora in area dorica o misolidia, che fungono da terreno elastico, consentendo alle linee di espandersi e ritirarsi secondo la dinamica emotiva del momento. L’ascolto è quello di un flusso narrativo ininterrotto, dove la tensione cresce e si dissolve come in una partitura sinfonica, ma scritta all’istante. «Symphony for Improvisers» (1966), con formazione allargata (Gato Barbieri, Pharoah Sanders, Karl Berger, Henry Grimes, Jean-François Jenny-Clark, Ed Blackwell) prosegue e amplifica quel modello, in cui le sezioni si susseguono come quadri di un’unica galleria, legati da moduli ritmici e armonici che mutano d’aspetto senza mai disperdere l’unità. Qui Cherry introduce passaggi accordali più marcati, ossia quarti empilati e bicordi sospesi che evocano un’armonia quartale affine a certi esperimenti di McCoy Tyner, ma liberata dal vincolo di un centro tonale fisso. Il tessuto orchestrale si dilata, mentre il dialogo tra gli strumenti assume un carattere quasi cameristico, senza mai perdere il senso di trance collettiva.
«Eternal Rhythm» (1968), registrato dal vivo a Berlino, rappresenta un vero ponte verso la dimensione multiculturale. Strutturalmente, il concept si fonda su due grandi blocchi, ciascuno organizzato attorno a droni e bordoni (in particolare su fondamentali come Re o La) che fungono da poli gravitazionali. L’uso di scale pentatoniche asiatiche, misolidie e frammenti di raga hindustani si mescola a figurazioni ritmiche ternarie di matrice africana, mentre strumenti non occidentali , come tambura, gong, xilofoni, ampliano la tavolozza timbrica. L’effetto emotivo risulta non dissimile ad un cerimoniale laico o un viaggio iniziatico, in cui ogni ingresso strumentale sembra un’apparizione. La struttura, pur aperta, rivela una sapiente alternanza di densità e rarefazione, quasi un respiro cosmico. Con «Organic Music Society» (1972), inciso in Svezia, Cherry radicalizza la visione comunitaria. L’album è una raccolta di momenti musicali che alternano canti corali, improvvisazioni modali e motivi fondati su semplici giri armonici, spesso oscillazioni tra due accordi, come I–♭VII in ambito misolidio, o I–IV di sapore folk. La scrittura pentagrammatica è minima, spesso ridotta a linee-guida melodiche, lasciando che l’elaborazione nasca dall’interazione diretta. La dimensione emozionale sembra quella di un raduno intorno al fuoco, dove la voce strumentale di Cherry si mescola a quella di Moki, Nana Vasconcelos e degli ospiti, dissolvendo la distinzione fra palco e platea. Infine, «Brown Rice» (1975) condensa in forma quasi popolareggiante la sintesi di linguaggi perseguita per un decennio. Il brano eponimo si fonda su un giro ipnotico di quattro accordi (I – ♭VII – IV – I in Re minore dorico) sostenuto da un ostinato di basso elettrico e da pattern percussivi afro-latini. La melodia, costruita su intervalli di quarta e quinte perfette, si muove come un canto rituale, mentre le sovrapposizioni strumentali creano un senso di trance urbana. Qui la scrittura armonica è volutamente elementare per consentire una libertà massima di fraseggio e di ricchezza timbrica; il risultato emotivo è quello di una celebrazione collettiva in cui la modernità elettrica incontra la ritualità arcaica.
Questi dischi, pur diversi per organico, luogo e intenti, condividono un nucleo di poetica riconoscibile, ossia la rinuncia alla gerarchia solista–accompagnamento, la predilezione per modelli armonici statici o ciclici, la costruzione del discorso attraverso la variazione timbrica e la stratificazione ritmica, e soprattutto la convinzione che la forma musicale possa nascere e trasformarsi nell’atto stesso dell’esecuzione, rimanendo permeabile all’imprevisto. In tal senso, ciascun album di Cherry è insieme partitura e diario di viaggio, architettura e rito, documento di un’arte che ha fatto dell’improvvisazione una forma di pensiero compiuto. Il lascito di Don Cherry risiede non soltanto nelle registrazioni – molte delle quali continuano a riemergere da archivi e collezioni private – ma in una modalità di intendere la musica come gesto esistenziale, atto comunitario e ricerca incessante di un linguaggio che fosse, al tempo stesso, arcaico ed inedito. La sua figura resta quella di un eterno fanciullo incendiato dall’ansia dell’assoluto, capace di tradurre in suono il carpe diem oraziano e di trasmettere, sia pure con un semplice soffio nella melodica, l’eco di un mondo in cui arte e vita, memoria e invenzione, sono inseparabili.
Le caratteristiche della musica di Don Cherry si possono delineare su più piani, vale a dire tecnico, formale, estetico e strutturale, poiché il suo linguaggio si sostanzia come il risultato di una stratificazione di esperienze che vanno dal bebop alla sperimentazione radicale, dall’armolodia al sincretismo transculturale. Il suo modulo espressivo guadagna senso soltanto se lo si affronta come un unico gesto compositivo e performativo, dove tecnica, forma, estetica e struttura si compenetrano fino a risultare indistinguibili. Come sottolineato, al centro di quella pratica c’era una scelta timbrica, la quale più che un vezzo strumentale costituiva un principio espressivo: la pocket trumpet, usata con intonazioni volutamente imperfette, serviva a veicolare una voce affettiva, minuta e insieme autoritaria, che rifiutava la nitidezza canonicamente richiesta dal virtuosismo per favorire la parola musicata, l’esclamazione e la piega microtonale. Accanto ad essa conviveva – come descritto – un apparato strumentale eterogeneo: percussioni rituali, cordofoni africani, melodica, flauti. Tali strumenti non vanno intesi quale ornamento esotico, ma come estensione organica del linguaggio; la scelta degli oggetti sonori procedeva per affinità di colore e funzione narrativa piuttosto che per adesione a una tradizione codificata.
1. Aspetti tecnici
Timbro e strumentazione: predilezione per la pocket trumpet, strumento di dimensioni ridotte e suono penetrante, con una gamma di sfumature intonative volutamente lasciate impure per accentuare l’espressività. Uso frequente di strumenti non convenzionali (melodica, percussioni etniche, strumenti a corda africani e asiatici). Tecnica estesa: impiego di frasi spezzate, intervalli ampi e improvvisi, microtoni e inflessioni vicine al parlato. Capacità di passare da un registro lirico e sospeso a esplosioni ritmiche e vocali. Interazione: concezione della parte solistica come dialogo aperto con l’ensemble, senza la gerarchia tipica del jazz tradizionale tra solista e accompagnamento.
2. Aspetti formali
Apertura modale: uso di centri tonali e modi statici più che di progressioni armoniche complesse, influenzato da esperienze modali (Bill Evans, musica indiana, tradizioni arabe e africane). Forme fluide: rifiuto di strutture chiuse in favore di schemi “per accumulo” o “per episodi”, nei quali i segmenti musicali sono giustapposti in sequenze non lineari. Improvisazione collettiva: centralità dell’interazione simultanea, ereditata dal free jazz e dall’armolodia di Ornette Coleman.
3. Aspetti estetici
Nomadismo sonoro: integrazione di idiomi provenienti da Asia, Africa, Americhe e tradizioni popolari europee, in un’ottica di neo-folkore universale. Semplicità come veicolo di complessità: temi spesso basati su cellule melodiche elementari, ripetute e variate, che diventano base per un intreccio improvvisativo sofisticato. Spiritualità e ritualità: concezione della performance come esperienza comunitaria e quasi cerimoniale, in cui il confine tra musicista e pubblico si assottiglia.
4. Aspetti strutturali
Poliritmia e stratificazione temporale: sovrapposizione di cicli ritmici differenti, derivati da tradizioni africane, indiane e latinoamericane. Multifonia narrativa: costruzione di brani come “racconti” sonori composti da quadri successivi, spesso con cambi repentini di tempo, metrica e colore timbrico. Interculturalità integrata: non semplice aggiunta di elementi esotici, ma loro assimilazione nel vocabolario compositivo e improvvisativo.