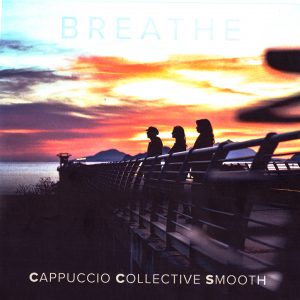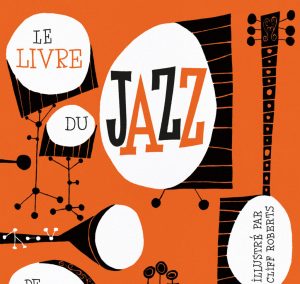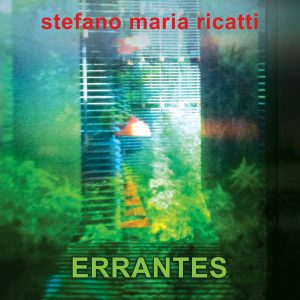«La sostanza policroma del suono»: Stefano Ottogalli con «Colors» (Caligola Records, 2025)
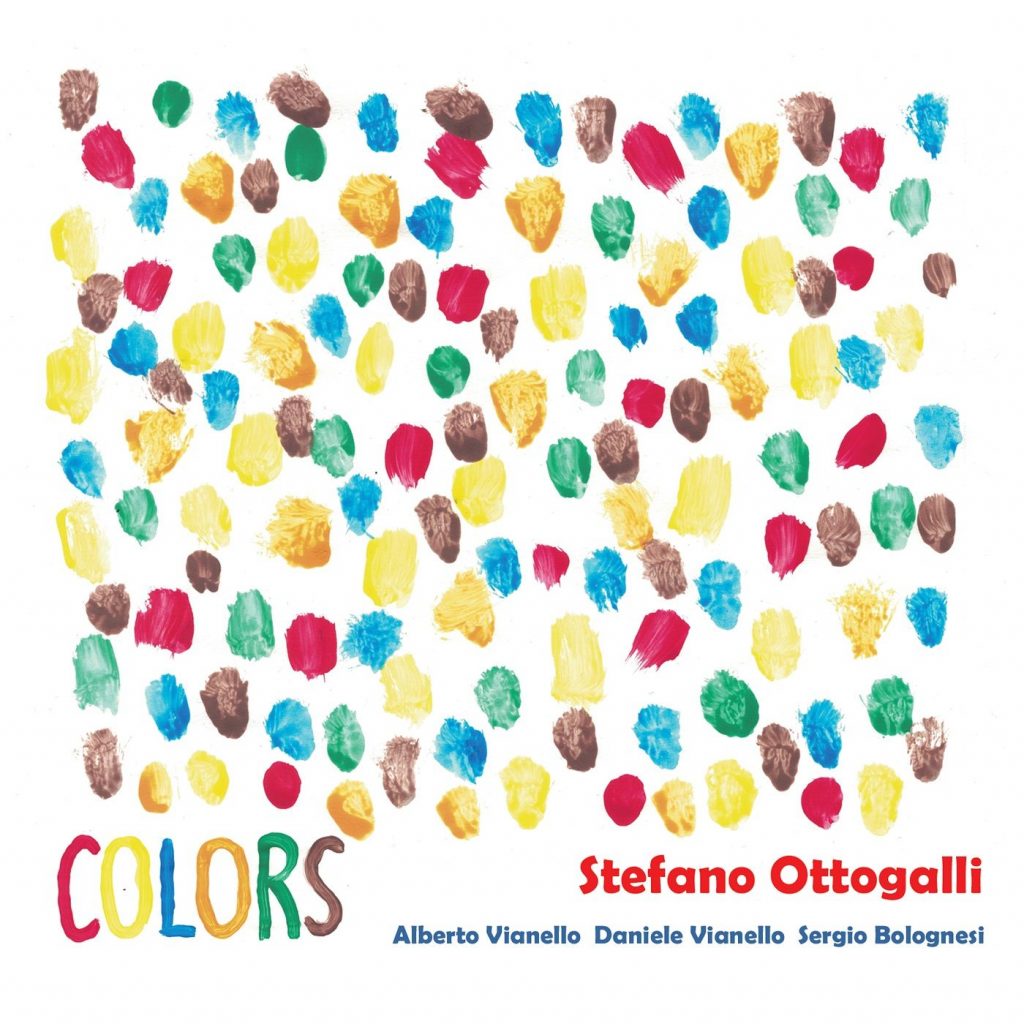
…il legame con la prassi afroamericana, non come rievocazione museale ma come linfa vitale da cui trarre vigore e significato. Ottogalli non propone un compendio jazzistico, bensì un percorso gnoseologico, in cui il suono diviene strumento di indagine…
// di Francesco Cataldo Verrina //
Nel tessuto cangiante della contemporaneità musicale, «Colors», edito da Caligola Records, assume le sembianze di un caleidoscopio sonoro, la cui architettura riflette non solo una maturazione stilistica ma un autentico pensiero musicale. Stefano Ottogalli, artigiano delle sei corde e cultore delle tradizioni afro-americane, rifiuta l’effimero per abbracciare una progettualità sedimentata, in cui ogni nota sembra scolpita non solo suonata. Nasce così un progetto che trascende l’esordio discografico, attestandosi piuttosto come una dichiarazione d’identità estetica.
L’album si srotola come una suite in otto movimenti, ciascuno portatore di un microcosmo espressivo. Le influenze letterarie non fungono da ornamento, bensì come strutture portanti: «Barlumi» si nutre della visione poetica pasoliniana, «Sereno» si affida alla misura spezzata dell’ermetismo ungarettiano, mentre «Shakespeare» dialoga con la ritmica segreta del Sonetto VIII, in una sospensione che pare sfiorare l’ineffabile. «My Shadow», contrafact meticoloso di Porter, s’immerge nel lirismo stevensoniano, dando vita a una composizione che pulsa di un’intelligenza compositiva rara. La compagine che affianca Ottogalli non recita un ruolo accessorio, bensì partecipa attivamente alla costruzione di una drammaturgia musicale articolata. Alberto Vianello al sax tenore attraversa i brani come un narratore obliquo, mentre il contrabbasso di Daniele Vianello e la batteria di Sergio Bolognesi sorreggono e sospingono la narrazione, talora con discrezione cameristica, talaltra con risolutezza jazzistica. L’assenza del sax in «Viaggio» non è una mancanza, bensì una scelta, che restituisce al trio uno spazio contemplativo, quasi liturgico.
«Colors» si apre con la traccia eponima, che non si limita a fungere da biglietto da visita del progetto, ma ne rappresenta la grammatica originaria. La pulsazione flamenca, lungi dall’essere un prestito esotico, rappresenta il punto di partenza per una sintassi in cui la chitarra di Ottogalli modula i colori del timbro e del fraseggio. Un abbrivio teso ad esporre le intenzioni: evocare, non dimostrare. Da lì, «Barlumi» pare condensare l’inafferrabile, attraverso un valzer jazz che sfuma in lirismo puro. La poesia di Pasolini si rifrange nelle pieghe della melodia, e la struttura si compone come un affresco che resta sospeso fra malinconia e svelamento. In «Sereno», il groove dispari destabilizza e avvolge, come se la misura irregolare fosse una metafora dell’interiorità. L’influenza di Ungaretti non appare calligrafica, ma intimamente metabolizzata. «Shakespeare» segue con grazia meditativa, cucendo intarsi armonici in filigrana. Il riferimento al Sonetto VIII si traduce in un moto sonoro che non cerca il declamato, ma il sottinteso. Poi «Viaggio» – affidato al trio privo del sassofono – emerge come momento di raccoglimento. Non c’è sottrazione, bensì purificazione: un cammino che si fa esodo, una pausa che diviene respiro e pensiero. Con «R.I. Blues» ci si confronta col linguaggio blues non per aderirvi, ma per trasfigurarlo. La componente afroamericana si declina in gesto consapevole, lontano da ogni retorica. «Scrappy», di contro, gioca sul nervosismo ritmico e sulla densità espressiva, senza mai cedere alla frammentarietà. Il costrutto è compatto, ma mai costretto. Chiude «My Shadow», che prende le mosse da Porter per affondare nel lirismo di Stevenson, individuando il punto in cui la tecnica incontra la memoria, dove il jazz non rappresenta uno stilema ma metodo di pensiero.
«Colors» non smania per l’originalità come postura, ma piuttosto ambisce alla coerenza come valore. La flamencata presente nell’apertura del titolo omonimo non indulge nel folklore, ma lo trasforma in sintassi personale. «R.I. Blues» e »Scrappy, ad esempio, ribadiscono il legame con la prassi afroamericana, non come rievocazione museale ma come linfa vitale da cui trarre vigore e significato. Ottogalli non propone un compendio jazzistico, bensì un percorso gnoseologico, in cui il suono diviene strumento di indagine, la composizione spazio simbolico e l’interplay veicolo di memoria e desiderio.