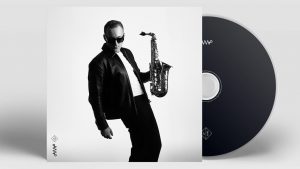Miles Davis, tra silenzio e dissonanza: l’estetica della transizione in «We Want Miles»

L’album, lungi dal proporsi come una rassicurante ripresa delle forme canoniche del jazz, si presenta invece come un laboratorio sonoro in cui Davis riformula la propria estetica attraverso un lessico ritmico e timbrico che attinge a idiomi allora considerati estranei, se non addirittura ostili, alla tradizione afro-americana più ortodossa.
// di Francesco Cataldo Verrina //
All’inizio degli anni Ottanta, il linguaggio del jazz si trovava in una fase di profonda rinegoziazione identitaria. Dopo le vertiginose esplorazioni dell’epoca free e le contaminazioni elettriche degli anni Settanta, il decennio successivo si apriva sotto il segno di una duplice tensione: da un lato, i desiderio di recuperare una presunta purezza idiomatica, incarnata da movimenti come il neo-bop e da figure come Wynton Marsalis; dall’altro, la spinta centrifuga verso una ibridazione sempre più marcata con i linguaggi della popular music, della musica elettronica e delle culture urbane emergenti. In questo scenario, la figura di Miles Davis si staglia con la consueta ambiguità: né apostata né ortodosso, il trombettista si muove con disinvoltura tra le faglie di un sistema in trasformazione, rifiutando ogni forma di nostalgia e abbracciando, ancora una volta, il rischio dell’inattualità.
La cosiddetta «svolta elettrica» di Davis, avviata già alla fine degli anni Sessanta con «In a Silent Way» e portata alle estreme conseguenze in «Bitches Brew», non rappresentava un semplice cambio di strumentazione, ma una vera e propria mutazione epistemologica del fare jazz. L’elettricità, in questo contesto, non era un orpello timbrico, bensì un dispositivo concettuale che consentiva di destrutturare le forme tradizionali dell’improvvisazione, di dilatare il tempo musicale e di riconfigurare le gerarchie interne all’ensemble. Dopo un quinquennio di silenzio, segnato da problemi di salute e da un crescente disincanto nei confronti dell’industria discografica, Davis tornò sulle scene con «The Man with the Horn» (1981), un lavoro interlocutorio che lasciava intravedere, tra esitazioni e concessioni al gusto commerciale, la volontà di riattivare il proprio laboratorio creativo. È in questo contesto che si colloca «We Want Miles», registrazione dal vivo che documenta le prime esibizioni del nuovo line-up e che, più di ogni altra testimonianza coeva, restituisce la complessità del momento. Lontano dall’essere un semplice ritorno, l’album si sostanzia come un atto di rifondazione: l’inquieto trombettista non riprende da dove aveva interrotto, ma inaugura un inedito percorso, in cui la memoria del passato s’interseca con una tensione costante verso l’ignoto. La scelta dei collaboratori, l’assetto timbrico dell’ensemble, la natura dei materiali eseguiti: tutto concorre a delineare un’estetica della transizione, in cui l’instabilità diventa principio generativo
Nel corpus discografico di Miles Davis, «We Want Miles» occupa una posizione liminale e, per certi versi, provocatoria. Registrato dal vivo nel 1981 e pubblicato l’anno successivo, questo lavoro segna il ritorno sulle scene del trombettista, interrotto da problemi di salute e da un progressivo disincanto nei confronti dell’industria musicale. L’album, lungi dal proporsi come una rassicurante ripresa delle forme canoniche del jazz, si presenta invece come un laboratorio sonoro in cui Davis riformula la propria estetica attraverso un lessico ritmico e timbrico che attinge a idiomi allora considerati estranei, se non addirittura ostili, alla tradizione afro-americana più ortodossa. L’organico scelto da Davis per questa nuova fase è emblematico della sua volontà di disarticolare le consuetudini: una formazione elettrificata, dominata dalla chitarra di Mike Stern, dal basso di Marcus Miller e dalla percussività diafana di Mino Cinelu. Lungi dall’essere un semplice tentativo di aggiornamento stilistico, questa scelta rivela una precisa intenzione dialettica: confrontarsi con linguaggi come il funk, il rock e il reggae non per assimilarli passivamente, ma per piegarli alle esigenze di un’improvvisazione modale che, pur mantenendo un nucleo espressivo coerente, si apre ad inusuali possibilità metriche e timbriche.
L’opener, «Jean-Pierre», è paradigmatico, attestandosi come il manifesto sonoro dell’intero album. La linea di basso, reiterata con ostinazione ipnotica, funge da fondamento per un’esplorazione collettiva che si sviluppa per accumulazione e rarefazione. Marcus Miller funge da tela ritmica, su cui s’innestano gli interventi solistici. La chitarra di Mike Stern, fortemente saturata e con un uso marcato del bending, s’impone con un atteggiamento blueseggiante che richiama più il rock psichedelico che il jazz tradizionale. Lo stesso Davis, sorprendentemente defilato, lascia spazio a Stern, il cui fraseggio, spesso liquidato con l’etichetta riduttiva di rock-hero, si rivela invece intriso di una sofisticata tensione armonica, capace di insinuare dissonanze effimere in strutture scalari di notevole fluidità. Il chitarrista si muove con disinvoltura in territori che evocano l’outside playing, senza mai perdere il controllo della forma. Miles, alquanto reticente ed appartato, in questa prima versione, lascia che la band costruisca un climax collettivo, quasi a voler testare la tenuta dei suoi sodali. La seconda take, più breve e compatta, presenta un missaggio più nitido ed una maggiore evidenza della tromba, la quale s’insinua con frasi contenute e pungenti.
In «Back Seat Betty», registrato a New York, Miles torna al centro della scena con un sound più corposo, benché ancora attraversato da una certa esitazione. Il suo timbro, più che mai crepuscolare, si erge su un tessuto ritmico denso e irregolare, in cui la chitarra e la batteria si rincorrono in un dialogo serrato. Il tema si apre con un groove funkeggiante, sostenuto dalla batteria di Al Foster e dalle percussioni di Mino Cinelu, che creano un substrato nevrotico ma coeso. La tromba si muove con frasi spezzate, quasi interrogative, mentre Stern lavora per contrasto, con un fraseggio più fluido e lineare. L’interazione tra i due genera una tensione costante, che non si risolve mai in un climax definitivo, ma si mantiene in equilibrio instabile. È un Davis che sembra ancora in cerca di un equilibrio, ma che proprio in questa tensione trova una nuova urgenza espressiva. «Fast Track» ha un titolo programmatico, sostanziandosi come una corsa a perdifiato, in cui l’ensemble si muove con un affiatamento sorprendente. La sezione ritmica è al massimo della sua tenuta atletica: Miller e Foster costruiscono un groove serrato, mentre Cinelu aggiunge dettagli timbrici che arricchiscono la trama sonora. Il solo di Stern, lungo d articolato, costituisce un esempio di come la chitarra elettrica potesse assumere un ruolo primattorale nel jazz di quegli anni. Il trombettista-leader interviene dopo circa sette minuti con un assolo che, pur nella sua economia di mezzi, riesce ad imporsi per assertività e controllo formale.
«My Man’s Gone Now», registrato a Boston, rappresenta il vertice emotivo dell’album, dove la malinconia del titolo si traduce in un’atmosfera sospesa, quasi elegiaca. La linea di basso è grave e meditativa, la chitarra si muove con lentezza, quasi in punta di piedi. Il trombettista si riappropria della centrale di comando, guidando l’ensemble con un fraseggio che alterna perlustrazione e veemenza: ogni nota è pesata, ogni pausa è carica di significato. Il soprano di Bill Evans, finora rimasto in secondo piano, emerge con una voce tersa e controllata, capace di dialogare con la tromba senza mai sovrastarla: il suo è un piccolo capolavoro di equilibrio e misura, mentre Cinelu costruisce un paesaggio percussivo che evoca atmosfere rituali. La sezione ritmica, lungi dall’essere un semplice supporto, costruisce un paesaggio sonoro mobile e stratificato, in cui ogni accento sembra rispondere ad un impulso interno, più che a una griglia prestabilita. È in questo passaggio che l’ensemble raggiunge la massima simbiosi operativa. «Kix» introduce elementi ritmici di matrice reggae, rielaborati in chiave jazzistica. Il dialogo fra tromba e percussioni risulta particolarmente vivace, con Davis che si diverte a giocare con le dislocazioni ritmiche. Il sax di Evans aggiunge una nota di brillantezza, mentre Stern lavora per sottrazione, limitandosi a interventi puntuali ma perforanti.
Nella cosiddetta Bonus Track Version dell’album, rispetto al vinile originale, sono presenti altre tracce come «Ursula» che si distingue per un’atmosfera più rarefatta. Il tema viene esposto dalla tromba con sobrietà, mentre il resto dell’ensemble lavora per sottrazione, creando uno spazio sonoro sospeso. Il dialogo fra tromba e sax soprano appare particolarmente efficace, con Bill Evans che adotta un registro lirico e controllato, in contrasto con la cupezza della tromba di Miles. «Aida» e «Fat Time» chiudono idealmente il cerchio. «Aida» si distingue per il tema più strutturato, quasi cantabile, che Davis espone con una dolcezza inusuale. «Fat Time», invece, è un’esplosione di energia, alimentando uno dei momento di massima coesione del gruppo. La velocità non è un mero esercizio di virtuosismo, ma una condizione necessaria per l’emergere di una forma collettiva, in cui ogni intervento solistico s’impianta con naturalezza nel flusso generale. La chitarra di Stern diventa protagonista assoluta, con un assolo che sfiora il parossismo, mentre la sezione ritmica si lancia in un groove incalzante e irregolare. L’assolo di tromba, che irrompe dopo sette minuti di tensione crescente, è un esempio di come la reticenza possa trasformarsi in affermazione: poche note, ma cariche di un’intensità che non ha bisogno di spiegazioni. Miles interviene con frasi brevi, taglienti, come fendenti che attraversano la massa sonora.
Se «We Want Miles» non può essere considerato un’opera compiuta nel senso classico del termine, trova proprio nella sua natura frammentaria e discontinua il suo valore. Non si tratta di un ritorno trionfale, né di un tentativo di riconciliazione con il passato, ma di un gesto di rottura consapevole, che apre la strada a quella stagione finale della carriera di Davis in cui l’ibridazione dei linguaggi diventerà cifra stilistica dominante; non è un album che si lascia ascoltare con distrazione; esige attenzione, disponibilità all’ambiguità, e soprattutto la volontà di abbandonare ogni pregiudizio di genere. Siamo alle prese con un documento prezioso, non tanto per ciò che dice del jazz, quanto per ciò che rivela di un artista che ha sempre rifiutato di essere definito da una sola parola. Come accennato, negli anni Ottanta, Miles Davis attraversò una fase di profonda trasformazione stilistica, decretando l’ultima memorabile stagione creativa della sua carriera. Il suo ritorno non avvenne nel segno della continuità, bensì attraverso una radicale rifondazione del proprio linguaggio musicale. Già a partire dalla fine degli anni Sessanta, Miles aveva introdotto strumenti elettrici nel proprio ensemble, ma negli anni Ottanta questa scelta si consolidò e si espanse. L’elettricità non era più un semplice elemento timbrico, ma divenne l’asse portante di un’impraticata grammatica musicale. Tastiere, basso elettrico, chitarre distorte e percussioni ibride costituirono l’ossatura di un suono che si allontanava definitivamente dalle forme canoniche del jazz acustico. Il ritorno sulle scene con «The Man with the Horn» (1981) e, soprattutto, con «We Want Miles» (1982), sancì l’inizio di una nuova era, in cui Davis si confronta apertamente con idiomi provenienti dal rock, dal funk e dalla musica popolare urbana. L’ingresso di musicisti come Mike Stern e Marcus Miller imprimeva una direzione precisa: il fraseggio chitarristico si fece più aggressivo, il basso assunse un ruolo melodico e propulsivo, mentre la struttura dei brani si apriva a forme più libere e meno vincolate alla logica del chorus. In un’epoca in cui il jazz sembrava dividersi tra il recupero filologico del passato (il cosiddetto neo-bop) e l’inerzia di una fusion ormai esausta, il trombettista scelse una terza via: quella dell’inquietudine.
Il costrutto sonoro davisiano di quella decade appare spesso irregolare, discontinuo, a tratti persino sgraziato, ma proprio in questa imperfezione risiede la sua forza. Non c’è alcuna volontà di rassicurare l’ascoltatore: Davis sembra piuttosto volerlo disorientare, costringerlo a ripensare le categorie stesse con cui si definisce il jazz. Il gruppo non è più un collettivo paritario, né un semplice veicolo per l’improvvisazione solistica, ma un organismo cangiante, in cui ogni musicista contribuisce alla costruzione di un paesaggio sonoro stratificato. Davis, pur mantenendo un ruolo centrale, si ritrae spesso nell’ombra, lasciando spazio agli altri, orchestrando silenzi, accensioni improvvise, fratture ritmiche. La sua tromba, più che protagonista, diventa catalizzatrice di tensioni. Va da sé che il cambiamento stilistico di Miles Davis negli anni Ottanta non fu un ritorno, ma una nuova partenza, assecondando il gesto di un artista che, giunto all’ultimo step della propria parabola espressiva, rifiutava ogni forma di compiacimento, continuando ad interrogare il presente con lo sguardo inquieto di colui che non aveva ancora smesso di cercare.