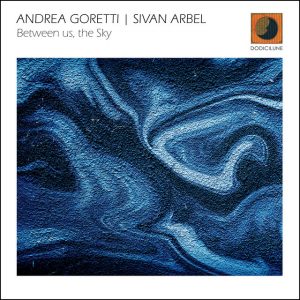Tony Fruscella Feat. Chick Maures con «Debut», un documento storico che ci restituisce il mood di un’epoca e di un luogo

Quella sera Tony strinse la tromba con forza, mentre il vento di East Harlem portava con sé l’odore della pasta al sugo che proveniva dai vicoli affollati. Dal quinto piano di un vecchio edificio, Chick regolava il suo sax, concentrato sulla partitura. La stanza era quasi vuota, a parte un materasso e un giradischi malandato che gracchiava l’ultimo successo di Bird. «Questa volta sarà diverso», disse Chick. «Ci stiamo facendo un nome».
// di Francesco Cataldo Verrina //
Registrato il 10 dicembre del 1948, al Vocarium Studio di New York, ma pubblicato solo nel 1981, questo disco raccoglie le sonorità delicate e sognanti di Fruscella, esecutore dal tono lirico e raffinato. La sezione ritmica, con Bill Triglia al piano, Red Mitchell al basso e Dave Troy alla batteria garantisce un solido supporto, mentre Tony, con la complicità dell’amico Chick Maures al contralto, scolpisce melodie eteree ed immortali. Prima di essere pubblicato, l’album venne ampliato con una seconda sessione registrata da Fruscella in quartetto all’Open Door Studio di New York, probabilmente nel giugno del 1953, con Bill Triglia al pianoforte, Teddy Kotick al contrabbasso ed Art Mardigan alla batteria. Il racconto del mancato riconoscimento del trombettista e dell’influenza di maestri dimenticati come Don Joseph ci fa riflettere sulla volatilità della fama nel mondo del jazz. «Debut» diventa dunque, ex-post, un ponte tra le generazioni, recuperando registrazioni che altrimenti sarebbero rimaste nell’ombra. Si sperava che questo disco, uscito inizialmente in Gran Bretagna e portato in America da un entusiasta Tony Williams, potesse essere una svolta per Tony Fruscella, ma non ha mai ottenuto il riconoscimento che meritava. Chick Maures finì addirittura nel dimenticatoio, pur essendo un musicista colto con tanto di laurea alla Manhattan School of Music.
Tony Fruscella era un talento non comune, anche se non ha mai avuto la possibilità di emergere e raggiungere un’equa notorietà. «Un italiano di colore», per usare un’espressione molto cara alle autorità USA negli anni ’30 e ’40. Cresciuto in un orfanotrofio, aveva preso lezioni di tromba e di armonia, privatamente, da Carmine Caruso e Don Joseph, ma la sua abilità ed il suo timbro lo fecero apprezzare presto nel ristretto ambiente di East Harlem. Tony fu subito attratto dal bebop, grazie alla contiguità con molti musicisti afro-americani. Per paradosso, il giovane Fruscella risultava troppo scuro (musicalmente) per essere apprezzato e favorito dai produttori discografici bianchi, ma troppo chiaro per essere riconosciuto dalla comunità afro-americana. La sua musica era nera, come il bebop, ma il suo tono soffuso e spaziato (successivamente imitato da Miles Davis) lo portò a codificare una sorta di cool-jazz ante-litteram. Come egli stesso ebbe modo di dire: «Seguivamo molto ciò che facevano i musicisti neri e frequentavamo West Harlem e l’Apollo Theater». Questo destino – come leggerete nel racconto che sto per farvi – accomunava tanti giovani musicisti italo-americani che si trovavano in una sorta di limbo o come avrebbe detto il poeta: «tra color che son sospesi».
Quella sera Tony strinse la tromba con forza, mentre il vento di East Harlem portava con sé l’odore della pasta al sugo che proveniva dai vicoli affollati. Dal quinto piano di un vecchio edificio, Chick regolava il suo sax, concentrato sulla partitura. La stanza era quasi vuota, ad eccezione di un materasso e di un giradischi malandato che gracchiava l’ultimo successo di Bird. «Questa volta sarà diverso», disse Chick. «Ci stiamo facendo un nome». Tony sorrise, lasciando che il fiato si mescolasse con la nostalgia del momento. Doveva essere vero. Doveva essere la volta buona. La porta si aprì di colpo. Sonny Tullamello entrò con una bottiglia sotto braccio, ridendo. «Ragazzi, questa notte bopperemo come mai prima d’ora!» E così fu. Nel cuore della notte, in quell’appartamento soffocante, quei giovani musicisti suonarono con un’intensità che sfidava il tempo e il destino.
Nel dopoguerra, East Harlem era un crocevia culturale in cui l’influenza della comunità italo-americana si intrecciava con le sonorità afro-americane. Musicisti come Chick Maures, Tony Fruscella, Don Joseph e Sonny Tullamello tentavano di dare un contributo al jazz attraverso una rilettura molto personale, fondata sull’eleganza melodica e la ricerca armonica. La loro esperienza era radicata in una tradizione popolare che affondava le radici anche nei caffè italiani e nei locali da ballo. Erano tutti appassionati di bop e di suoni cool, i «giovani turchi» dell’epoca, che diffondevano il verbo di Bird, Dizzy, e dei tanti dirimpettai di colore che vivevano a West Harlem, con l’ambizione di conquistare il mondo del jazz e tentare una svolta sul piano economico e sociale. La storia di questi artisti era spesso segnata dalla lotta per emergere ed ottenere un minimo riconoscimento. Suonavano nei loft o negli appartamenti dei vecchi caseggiati sull’Ottava Avenue, tra la 47esima e la 48esima strada. Le stanze vuote venivano affittate per qualche ora e i musicisti e i «gatti», che accorrevano solo per ascoltarli, contribuivano per pagare l’affitto con quello che potevano permettersi in quel momento. Brew Moore, Chuck Wayne ed altri jazzisti già famosi cercavano di sostenerli. Molti musicisti di passaggio in città con le big band, che si esibivano nei teatri di Broadway, si univano spesso alla compagnia e, quando veniva indetta una jam session all’ultima nota, Tony e Chick davano loro del filo da torcere. Erano tanti i «fratelli d’Italia» che si alternavano in quelle session: Don Joseph, che in seguito eseguirà alcuni assoli in «The Arranger» di Gerry Mulligan, nonché in un raro album di Chuck Wayne, “«String Fever», possedeva lo stesso suono morbido e sussurrato di Tony Fruscella, basato su una struttura armonica fortemente lirica; Charles «Sonny» Tullamello, un flauto tenore di rara bellezza melodica ed il sassofonista tenore Don Turso, il quale aveva lo stesso modo rilassato di suonare di Lester Young, ma con un timbro potente alla Coleman Hawkins e un tocco un po’ più duro.
Tony Fruscella aveva tutte le qualità di un trombettista di rango e con una dotazione non comune, ma il destino e le dinamiche dello show-biz non gli permisero mai di ottenere quanto avrebbe meritato. Allo stesso modo, Chick Maures era una figura raffinata, profondamente dedita alla musica, ma poco conosciuta al di fuori di New York. East Harlem non era solo il loro luogo di origine, ma anche un punto di incontro musicale. Come detto, i loft e i piccoli appartamenti diventavano sale prove informali, dove si sperimentavano nuove idee e si affinava il linguaggio del bebop: sessioni interminabili, speranze giovanili e la tensione tra il desiderio di innovazione e la realtà di dover suonare musica commerciale per sopravvivere. Molti di essi sbarcavano il lunario esibendosi ai matrimoni, da cui spesso, presi dalla tentazione di eseguire qualche standard bebop, venivano cacciati in malo modo.
Nel cuore pulsante di East Harlem, tra il rumore dei tram e le voci dei venditori ambulanti, il giovane Tony Fruscella stringeva la tromba con la naturalezza di chi era nato per suonarla. Gli appartamenti erano stretti, le pareti sottili, ma ciò che si propagava nell’aria era pura magia: la musica, quella che faceva fermare la gente per strada e spingere gli amici a riunirsi attorno a una bottiglia di liquore scadente, discutendo delle nuove armonie del bebop. Chick Maures entrò nella stanza, il suo corpo esile era avvolto nella penombra della sera. Tony soffiò nella sua tromba, lasciando vibrare una nota lunga e melanconica. Chick gli fece cenno di smettere. «Domani, abbiamo una recording date, Tony. È la nostra occasione». Tony sorrise appena, il ciglio basso, come se non volesse tradire l’emozione che montava dentro di lui. «Vedremo», disse, cercando di non lasciarsi prendere troppo dall’euforia del momento. Ma quello non era solo un giorno come gli altri. La musica che avrebbero registrato sarebbe rimasta lì, sospesa nel tempo. Il suono della tromba di Fruscella avrebbe continuato a echeggiare, anni dopo, nelle orecchie di chi, scavando nei meandri della storia del jazz, avrebbe ritrovato la sua voce.
La storia della scena jazz di East Harlem è anche una storia di talento, lotta e, purtroppo, di destini spezzati troppo presto: la prematura scomparsa di Chick Maures, avvenuta il 20 luglio 1954 a soli 29 anni a causa di un’overdose. La sua morte non fu del tutto inaspettata per chi lo conosceva, ma rappresentò comunque una perdita devastante. Un musicista raffinato e appassionato, che aveva dedicato la sua breve vita alla ricerca della perfezione musicale, ma che purtroppo non riuscì mai ad ottenere il riconoscimento che meritava. Anche il maestro Carmine Caruso, figura di riferimento per tanti musicisti con problemi di tecnica e di respirazione, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del jazz e di East Harlem. Caruso, anche lui figlio della grande diaspora italiana di fine Ottocento, era più di un insegnante: era un mentore che dedicava il suo tempo e la sua conoscenza ai giovani talenti, sacrificando persino i suoi pomeriggi liberi per seguire i suoi studenti. Come diceva Chick: «Siamo tutti suoi figli».
Quel pomeriggio, Tony camminava per le strade di East Harlem, il caldo dell’asfalto gli stringeva il petto. Entrò in un locale poco illuminato, dove il suono del sax di Chick ancora riecheggiava nella memoria di chi lo aveva conosciuto. Un vecchio amico gli si avvicinò, il volto segnato dal tempo, dalle illusioni e dalle notti insonni. «Hai sentito? Chick se n’è andato…». Tony annuì, sentendo il peso della notizia. Le melodie che avevano creato insieme non sarebbero mai morte, ma il loro amico sì. Una generazione di musicisti se ne andava, pezzo dopo pezzo, mentre le luci di Harlem continuavano a brillare nel buio. Stringendo la tromba, Tony si sedette vicino al palco. «Suoneremo per lui, stanotte». E mentre l’ultimo accordo svaniva nell’aria, East Harlem salutava uno dei suoi figli.
Fruscella registrò dal 1948 al 1955, quando l’abuso di droghe ed alcool lo raggiunse, minando il suo talento ed il suo matrimonio con la cantante Morgana King, con cui fu sposato dal 1947 al 1956. Non si comprende il perché Fruscella abbia ceduto alla dipendenza. Si può solo supporre che l’utilizzo di stupefacenti fosse una sorta di automedicazione per qualche tipo di malattia fisica o ansia, Nondimeno si ritiene che possa essere stata una stupida emulazione, dilagante tra molti giovani musicisti jazz dell’epoca, in soggezione davanti a Charlie Parker e desiderosi di rimanere artisti underground anche nel modo di vivere. Ad ogni buon conto, Tony Fruscella resta uno dei trombettisti più dotati, ma meno conosciuti del movimento bop-pre-cool. Il suo tono asciutto si colloca in una scala mobile tra Miles Davis e Chet Baker, con tocchi di Art Farmer. Eppure il suono del trombettista italo-americano era distintivo: non c’erano note acute o stonate, né un romanticismo carnoso, eccessivamente reiterato alla Baker. Era sobrio, sensibile e puro, con linee più simili a uno schizzo che a un’illustrazione completa. Le progressioni improvvisate risultavano altamente melodiche, ma il suo tono era perlustrativo ed asciutto come sabbia fine. Il suo strumento esprimeva un’introspezione notturna priva di ostentazione o esibizionismo.