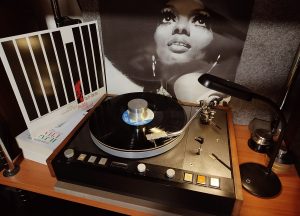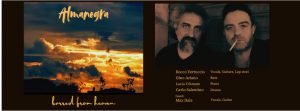Andrea Mannucci: «Facciamo musica. Chiamiamola come vogliamo, purché sia viva, sincera, necessaria!»

Andrea Mannucci
// di Guido Michelone//
Andrea Mannucci è una figura centrale nel panorama italiana della musica colta che assieme alla popular music e al nostro jazz viene a comporre la triade delle cosiddette sonorità contemporanee che attengono alla sfera artistica e creativa. Da oltre mezzo secolo, anche in Italia, il jazz viene sempre più ritenuto un’esperienza dotta, lontana dalle logiche commerciale (benché negli Stati Uniti non sia proprio così), ragion per cui pare doveroso, anche su DOPPIO JAZZ, presentare questo colloquio inedito con un compositore e didatta e ora Presidente della SIMC – Società Italiana di Musica Contemporanea – onde favorire maggiormente il dialogo fra tutti quelli che si occupano del mondo dei suoni,
D Così, a bruciapelo chi è Andrea Mannucci?
R Un uomo che ha vissuto per la ricerca del bello: nella vita privata, nell’ambiente familiare, nella musica. Ho cercato il senso delle cose nell’armonia, nell’intensità dei legami, nella profondità dei gesti. Ho attraversato le diverse stagioni dell’esistenza con consapevolezza e con una certa inquietudine creativa, sempre in movimento, senza fermarmi, senza voltarmi troppo indietro, senza rimpianti. Ho scelto di spendere la mia vita attivamente, nella convinzione che ogni azione, ogni incontro, ogni suono potesse essere un tassello di un disegno più ampio, non sempre chiaro, ma necessario.
D In quale ruolo si sente meglio: compositore, direttore artistico, didatta o altro ancora?
R Mi sento più pienamente me stesso quando creo, quando costruisco un’idea, un suono, una visione. Compositore, quindi — nel senso più ampio del termine, ma anche docente, perché insegnare per me è un’estensione naturale del pensiero creativo. Insegno Composizione al Conservatorio di Verona dal 1994, una vita fa. Da allora sono passati da me decine di allievi: alcuni sono oggi docenti a loro volta, compositori affermati, collaboratori e amici con cui continuo a condividere progetti e riflessioni. Le generazioni sono cambiate: i primi forse più seri, più ligi al dovere; oggi sono più liberi, meno strutturati. Eppure, in chi decide davvero di fare composizione, ritrovo sempre quella scintilla: la voglia di scrivere, di sperimentare, di trovare un senso autentico alla propria voce. Quest’anno, ad esempio, abbiamo realizzato il saggio di fine anno con 16 nuove composizioni, tutte in prima esecuzione assoluta: un risultato che parla da sé.
D Le sue attività sono comunque molteplici…
R Non posso dimenticare però che sono nato pianista. Fino ai vent’anni immaginavo per me un futuro da virtuoso. In qualche occasione l’ho anche toccato: ho vinto alcuni concorsi e ho affrontato recital pianistici molto impegnativi. Poi ho capito con chiarezza che il salto verso l’eccellenza assoluta era troppo distante. Intanto, lo studio dei classici e la scoperta della musica contemporanea mi avevano già catturato. Così ho fatto una scelta drastica: lasciare il pianoforte. Ma lui è rimasto con me, come un amico silenzioso e fedele. L’ho ripreso più volte: in duo, come solista, soprattutto per presentare nuove musiche, spesso in prima assoluta. Ho anche diretto, in alcune occasioni importanti, ricordo la Nona Sinfonia di Beethoven, diretta a memoria, ma l’ho fatto più per completare il mio percorso che per vocazione. Non ho mai sentito il richiamo della bacchetta come un destino. Quanto al ruolo di direttore artistico, non mi ci riconosco. Ho curato stagioni, festival, iniziative, ma la mia inclinazione alla pluralità, al dialogo tra voci diverse, mi rende poco selettivo in senso tradizionale. Non costruisco gerarchie, cerco piuttosto di mettere in luce ciò che ha forza, che è necessario. Più che direttore artistico, mi sento un mediatore tra mondi, un promotore di sensibilità.
D Ci racconta ora il primo ricordo che ha della musica?
R Avevo tre anni. Ricordo che mia madre mi regalò un pianofortino a coda, con tanto di sgabello: i tasti neri erano colorati, e il suono somigliava a quello di una piccola celesta. Nonostante fossi così piccolo, ho ancora un’immagine nitida di quel giocattolo e soprattutto del senso di meraviglia che mi dava. Mi sentivo un piccolo pianista, immerso in un mondo tutto mio fatto di suoni e intuizioni. Poi, a quasi sei anni, ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte. Da lì la mia vita ha cominciato ad assomigliare a una partitura: riga dopo riga, movimento dopo movimento, la musica è diventata la mia forma naturale di espressione, il mio modo di leggere e restituire il mondo.
D Quali sono i motivi che l’hanno spinta a occuparsi di musica o ancor meglio a vivere in pieno la musica?
R Non so se posso davvero rispondere con precisione a questa domanda. So solo che non avrei potuto fare nient’altro nella vita. La musica non è stata una scelta, è stata una necessità. Per lei ho sacrificato gran parte della mia giovinezza. Ero un ragazzo solitario, spesso isolato, soprattutto quando, a diciannove anni, mi iscrissi al Conservatorio di Parma per studiare direzione d’orchestra composizione con il M° Piero Guarino e il M° Camillo Togni. Ero completamente immerso in ciò che scoprivo giorno dopo giorno, dallo stupore per un intermezzo di Brahms alla folgorazione per la dodecafonia di Schoenberg. Non c’erano amici, non c’erano ragazze, solo uno studio instancabile e totalizzante, che mi ha consumato e insieme formato, fino ai ventiquattro anni, a Siena, durante un corso con Donatoni, ho incontrato una giovanissima clavicembalista. Con lei ho scoperto l’amore , quello vero, che dà forma e senso anche a tutto il resto. E sto con quella ragazza ancora oggi, da oltre quarant’anni.
D E in particolare cosa significa oggi essere compositore?
R Anche questa è una domanda difficile. Vuol dire tutto e niente. In un mondo dove i confini tra i linguaggi si sfaldano e la musica sembra spesso smaterializzarsi, essere compositore oggi per me significa, innanzitutto, esprimere il mio mondo interiore: le mie difficoltà, le mie tristezze, i miei dolori, ma anche la possibilità di riflettere sui grandi temi universali e, perché no, anche di sorridere, di giocare con i suoni, con l’ironia, con l’imprevisto. È un atto di resistenza e insieme un atto d’amore. Come docente, cerco di trasmettere questo senso profondo ai miei allievi: la consapevolezza che la musica è un’eredità viva, con cui possiamo e dobbiamo confrontarci. Ancora oggi, durante le lezioni, quando presento un corale di Bach, un preludio di Chopin, un lied di Brahms o un pezzo di Scriabin, mi commuovo. E vedo nei miei studenti, giovani compositori, un trasporto sincero, una condivisione che mi entusiasma e mi fa sperare. Essere compositore, in fondo, è continuare a cercare senso, bellezza, umanità anche nel disordine del presente.
D Accetta la definizione di ‘classica contemporanea’ o per la ‘musica del presente’ (non commerciale) servirebbero altri sostantivi, altri aggettivi, altri epiteti?
R Esiste una lunga diatriba su cosa significhi dire “musica contemporanea”, “musica d’oggi”, “musica del presente”… Personalmente, non mi interessa molto come la si chiami. Credo che ci sia un solo discrimine che conti davvero: se la musica è bella, se è interessante, se ha qualcosa da dire. Il resto sono etichette a volte utili, certo, ma spesso fuorvianti o riduttive. Facciamo musica. Chiamiamola come vogliamo, purché sia viva, sincera, necessaria.
D Quali sono le idee, i concetti o i sentimenti che associ al linguaggio musicale? È davvero un linguaggio asemantico? O, stando ad alcuni musicisti, non è proprio un linguaggio?
R La musica è un linguaggio che non dice, ma fa sentire. Non ha bisogno di parole, eppure comunica. Non racconta, ma colpisce. È come una lettera senza indirizzo né grammatica, ma scritta con urgenza: ti arriva addosso e ti smuove, anche se non sai spiegare perché. Per me comporre è questo: dare voce a ciò che non riesco a dire. Dolore, stupore, ironia, silenzi pieni di senso. Penso a Webern, che in pochi suoni condensa l’invisibile. A Mahler, che abbraccia il mondo con l’orchestra. A Scelsi, che scava nell’anima di un solo suono. A Bach, che ancora oggi mi commuove spiegando il mistero della bellezza con una fuga. La musica non ha bisogno di significare. Basta che accada. E quando accade davvero, ti cambia.
D Tra le sue composizione ce ne è una a cui è particolarmente affezionato? E per quali ragioni?
R È sempre difficile rispondere a questa domanda. Tendo ad amare l’ultima cosa che ho scritto, al punto che quando la faccio ascoltare alle mie figlie – Miranda, violinista, e Afra, violoncellista – il rito si conclude sempre con la mia frase: “Questo è il mio pezzo migliore…”. Se però devo scegliere, direi Il principio della malinconia, un concerto per violino, orchestra d’archi e timpani ispirato a un racconto struggente di Francesco Permunian. Un testo attraversato dal ricordo della moglie scomparsa troppo presto, e da quella malinconia che non si annuncia mai, ma arriva quando meno te lo aspetti: al cinema, al bar, in metropolitana. In quel brano ho cercato di restituire proprio questo: il peso dolce e crudele della memoria, che ti sfiora all’improvviso e ti inchioda.
D Quali sono stati i tuoi maestri nella musica, nella cultura, nella vita?
R La mia formazione musicale comincia con Raoul Martucci, pianista spezzino, allievo diretto del compositore Giuseppe Martucci — autore di due straordinari Notturni per pianoforte e figura cardine del tardo Ottocento italiano. È grazie a lui che ho mosso i primi passi, crescendo in un ambiente di grande rigore musicale. Dopo l’ottavo anno, ho proseguito gli studi con Rossana Bottai, docente al Boccherini di Lucca. Con lei è iniziata la mia vera maturazione: era una donna durissima, un’insegnante d’altri tempi. Se non arrivavi preparato alle lezioni, volavano spartiti, sedie, parole. Mi ha rivoltato come un calzino: ore e ore al pianoforte, ogni giorno, per perfezionare automatismi, ritmi, articolazioni. Anche a letto mi esercitavo, le dita contro il materasso, in cerca di una tecnica che sembrava sempre sfuggirmi. La ringrazierò sempre: è lei che mi ha insegnato che nella vita si può arrivare ovunque, se davvero lo si vuole. Il talento serve, ma senza disciplina, determinazione e fatica, non porta lontano. In due anni sono arrivato a suonare le ultime sonate di Beethoven, le Variazioni di Brahms, gli Studi Trascendentali di Ljapunov. Ma poi, con Debussy e Ravel, ho capito che non avrei mai fatto il salto di qualità che sognavo. È stato allora che ho cominciato a guardare oltre la tastiera — verso la scrittura, la composizione, il mio vero destino. Accanto ai maestri della musica, un ruolo fondamentale nella mia crescita culturale e umana lo ha avuto Renzo Cresti, musicologo, pensatore, grande esponente della musica dei giorni nostri e non solo. Con la sua intelligenza lucida, il suo spirito critico e la sua profonda umanità, è stato per me una figura importante, quasi un fratello maggiore. I suoi scritti e le nostre conversazioni mi hanno aiutato a vedere la musica in una prospettiva più ampia, filosofica, etica. A lui devo molto, anche nella capacità di dare un senso e una direzione al mio percorso artistico.
D E i compositori che l’hanno maggiormente influenzata?
R Devo tutto, nella mia formazione di compositore, a Camillo Togni: un maestro vero, un intellettuale finissimo, un germanista colto che mi ha fatto scoprire Trakl, Celan e molti altri poeti. Togni è stato tra i primi in Italia a praticare con rigore la dodecafonia pura, senza concessioni né compromessi. Era un vero pasionario: dedicava cinque, sei ore al giorno alla composizione, e spesso ne usciva con appena tre o quattro battute. Ogni nota era necessaria, ogni suono frutto di un pensiero profondo. Poi è arrivato Aldo Clementi, che ho seguito a lungo, con lezioni private a casa sua, a Roma. L’avevo scelto per la sua poetica complessa ma piena di luce: quella scrittura rigorosa e insieme sospesa, quel suono cristallino, quella bellezza raggiunta attraverso la tecnica severa del canone. Oggi i miei maestri sono i classici: Bach, Beethoven, Schumann, Brahms, Prokofiev, Scriabin, Berg. In loro trovo tutto ciò che mi serve per scrivere musica oggi. Non ho bisogno d’altro: sono lì, sempre presenti, come stelle fisse.
D Ci sono musicisti con i quali ama lavorare, collaborare, organizzare iniziative?
R Ho sempre amato collaborare con scrittori e poeti. Per me la parola scritta è una miccia creativa: la forma, il carattere e persino la sonorità di un mio brano possono nascere dal testo con cui entro in contatto. In questo senso, certi incontri sono stati fondamentali. Penso a Francesco Permunian, scrittore dalla voce intensa e visionaria, o alla poetessa Ida Travi, con la sua parola sognante e intima. E poi Marco Ongaro, con cui ho condiviso un lungo e sorprendente cammino artistico: io più riservato e rigoroso, lui istrionico e affabulatore, un amabile seduttore della parola. Insieme abbiamo scritto di tutto: Kiki de Montparnasse (commedia in un atto) Moro (tragedia in un atto), Il cuoco fellone (una farsa in due atti), l’opera Il Computer — un trittico che riflette sulle derive tecnologiche — e molti lavori strumentali su suoi testi immaginari. È stato (ed è) il mio perfetto contrappunto. Tra i musicisti con cui ho costruito collaborazioni importanti, cito con affetto la Maestra Paola Fornasari Patti, mezzosoprano e presidente dell’Accademia Lirica di Verona. Con lei e con interpreti come Carlotta Bellotto e Nadina Calistru, ho potuto dare vita a molte delle mie opere vocali più significative. Insieme a Paola, abbiamo fondato il Festival delle Arti Contemporanee di Verona, un progetto che cerca di unire le diverse forme d’arte, per aprire nuovi spazi espressivi e nuove visioni.
D Parliamo ora della SIMC, di cui è da pochi mesi Presidente. Se dovesse spiegarla al popolo in poche parole, cosa direbbe?
R La SIMC – Società Italiana di Musica Contemporanea – è nata grazie alla visione di grandi compositori del passato come Casella, Respighi, Malipiero e Pizzetti, che sentirono l’urgenza di unire le forze per contrastare una deriva poetica della musica italiana che la voleva confinata quasi esclusivamente all’opera lirica. Fin dall’inizio, la SIMC ha promosso la produzione strumentale, cameristica, sinfonica e vocale, sostenendo la nuova musica in Italia e all’estero e costruendo una vera e propria corporazione al servizio della creatività. Oggi, da Presidente, sento la responsabilità di raccogliere questa eredità e trasformarla in azioni concrete: creare spazi e occasioni per la musica del presente attraverso festival, concerti, rassegne, progetti interdisciplinari. Il nostro compito è dare voce a chi scrive oggi, favorendo l’incontro tra compositori, interpreti e pubblico.
D Prospettive presenti e future della SIMC?
R Le prospettive presenti e future della SIMC sono fortemente orientate all’apertura, al sostegno della nuova musica e alla valorizzazione dei giovani compositori. Dopo un’importante riorganizzazione interna, abbiamo intrapreso un percorso concreto per ridare centralità alla musica d’oggi, anche attraverso una più incisiva presenza sul territorio nazionale. Abbiamo avviato collaborazioni strategiche con alcune delle più importanti istituzioni culturali italiane: l’Accademia Chigiana di Siena, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con cui condividiamo l’obiettivo di favorire la produzione e la diffusione della musica dei giovani, e il CIDIM, con il quale abbiamo sottoscritto un accordo triennale (2025-2027) che ci garantirà un prezioso sostegno economico e promozionale. La SIMC vuole diventare un punto di riferimento dinamico, inclusivo e autorevole per la musica contemporanea, creando reti, stimolando la creatività, facilitando il confronto e costruendo occasioni reali per ascoltare ciò che i compositori italiani stanno scrivendo oggi.
D Quale atteggiamento ha la SIMC verso il jazz e le musiche improvvisate, istantanee, improvvisate audiotattili?
R Pur non essendo un cultore dell’improvvisazione, ho sempre guardato con interesse a chi esplora questo ambito con rigore e consapevolezza. In SIMC c’è spazio anche per le pratiche musicali non scritte, le performance istantanee e le forme audiotattili, soprattutto quando sono frutto di una ricerca autentica. Un esempio significativo è Alessandro Sbordoni, nostro socio, compositore raffinato e profondo conoscitore del mondo improvvisativo, che ha recentemente fondato il gruppo AleaNova, dedicato proprio all’esplorazione della musica aleatoria e dell’improvvisazione. Con lui stiamo organizzando un incontro online a settembre, nell’ambito della rassegna I lunedì della SIMC, per riflettere su queste pratiche e sul loro posto nella musica contemporanea. La SIMC, del resto, vuole essere sempre più una casa accogliente per poetiche anche diverse tra loro, purché animate da una tensione vera verso il senso del fare musica oggi.
D Lei personalmente che rapporto ha con il jazz? Lo ascolta? Quali i periodi e i jazzmen preferiti?
R Devo ammettere con serenità che non ho mai avuto un rapporto profondo con il jazz. Non perché non lo apprezzi, ma semplicemente perché non l’ho coltivato fin da giovane: sono cresciuto immerso in altri linguaggi, e questo ha inevitabilmente influenzato i miei gusti e le mie competenze. Solo più tardi, da adulto, ho iniziato ad ascoltarlo con più attenzione e curiosità, scoprendo alcune figure che mi hanno colpito profondamente: Louis Armstrong, Glenn Miller, John Coltrane… E, tra gli italiani, Giorgio Gaslini, con cui ho anche avuto il piacere di collaborare in alcune occasioni, allestendo alcune sue composizioni. Gaslini mi ha affascinato per la sua capacità di tenere insieme mondi diversi: il jazz, la musica colta, l’improvvisazione e la scrittura rigorosa. Il jazz resta per me un universo in parte misterioso, ma proprio per questo affascinante, un linguaggio libero, generoso, capace di reinventarsi costantemente.
D Come vede la situazione della musica in Italia?
R La situazione della musica in Italia mi sta molto a cuore, ed è difficile non provare un po’ di amarezza pensando a quanto potenziale rimanga inespresso. La musica nuova, la creatività giovane spesso si scontrano con un muro di paura: paura di rischiare, paura di perdere il pubblico, paura di uscire dagli schemi collaudati. Questo provincialismo culturale soffoca l’audacia e rallenta il rinnovamento. Eppure, io credo profondamente nel valore della musica contemporanea, in quel linguaggio che racconta il presente, che parla con urgenza e sincerità. Vedere qualche segnale di apertura, come l’opera contemporanea alla Scala o i piccoli festival che si impegnano a far ascoltare voci nuove, mi riempie di speranza. Ma il vero cuore pulsante sono le piccole realtà, i teatri e le associazioni locali, quei luoghi dove i giovani artisti trovano spazio per esprimersi, per sbagliare, per crescere. Sono loro il futuro della musica italiana. Ed è lì che dobbiamo mettere risorse, attenzione, fiducia. Lo Stato deve capire che senza queste radici, senza questo terreno fertile, anche le grandi eccellenze rischiano di appassire.
D E più in generale della cultura in Italia?
R Parlare di cultura in Italia oggi mi pesa molto. Sento che stiamo attraversando un momento davvero difficile, quasi doloroso. La cultura di massa, quella che arriva a tutti, è spesso dominata da programmi televisivi, giornali e media che sembrano puntare solo a cose superficiali, a contenuti poveri e a personaggi costruiti a tavolino, senza alcuna sostanza. È frustrante vedere quanta poca attenzione venga data a ciò che davvero conta, a quello che può nutrire la mente e lo spirito. A volte mi chiedo come si possa restare lucidi in questo panorama, come non lasciarsi travolgere dalla banalità e dalla disillusione. Però dentro di me so che dobbiamo avere pazienza e continuare a credere. Credere che la vera cultura, quella autentica e profonda, possa ancora arrivare ai giovani e possa essere per loro una scintilla, un faro che li guida in un mondo spesso troppo confuso e superficiale. Mi fa male constatare quanta ignoranza e maleducazione ci circondino, e quante volte anche chi ci governa non riesca a dare un esempio degno di questo nome. Ma io non posso arrendermi a tutto questo. È un impegno che sento dentro: essere un punto di riferimento, una voce che prova a tenere alta la bandiera della cultura, soprattutto musicale, per chi desidera davvero vivere con passione e profondità. So che non è facile, ma è l’unica strada che voglio percorrere. La cultura non deve essere una parola vuota, ma qualcosa di vivo che ci sostiene e ci rende migliori.