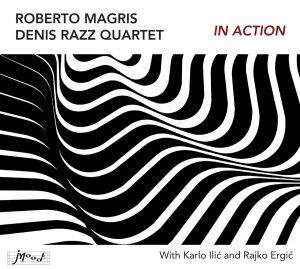Umbria Jazz: con Galliano e Capossela, una piccola arena senza gladiatori

// di Francesco Cataldo Verrina //
Adoro la fisarmonica, essendo nato in un paesino del Sud, in una Calabria fatta di tarantelle, tanghi e saltelli; sono cresciuto assorbendo le sonorità popolane e folkloriche dell’organetto – così lo chiamavano dalle mie parti – che mantengono inalterata nel tempo un’aura di festa nell’aia. Per questo, e per un’infinità di altri motivi, non sono mai riuscito a pensare a questo italico strumento come qualcosa di organico all’idioma jazzistico. Cosi Galliano, accerchiato da circa 4000 spettatori dichiarati, apre le «danze» di Umbria Jazz nella maniera più antitetica al jazz. Chi è venuto per il fisarmonicista, di certo, non si aspettava che suonasse post-bop, nonostante qualcuno si sia sperticato dicendo che Galliano è cosi bravo da trasformare la fisarmonica in un pianoforte a coda e che ha avuto relazioni e contatti con jazzisti dai nomi altisonanti. Non è raro che oggi, oltremodo, tanti musicisti jazz tentino commistioni e apparentamenti con bandoneisti e fisarmonicisti al fine di realizzare progetti borderline, ma soprattutto con l’intento di avvicinare il vernacolo jazzistico a certe musiche antiche, mediterranee o balcaniche.
Galliano, però, non fa nulla e non ha fatto niente di tutto questo: è un tanghero che suona la fisarmonica con il languido e decadente melodismo del valzer musette, facendo leva su quell’eurocentrismo popolare e non accademico, che considera la fisarmonica uno strumento non adatto al sinfonismo dotto ed elitario. Uno «organo minore» che, per quanto evocativo, struggente ed elegiaco, non ha mai trovato un salvacondotto per uno sdoganamento definitivo o per assurgere ai quartieri alti della musica eurocolta. Puoi suonare tutti tanghi che vuoi, le romanze, i valzer, anche le arie d’opera, la musica sacra, ti resta sempre addosso quella genuino profumo di campagna a metà strada tra un bordello del barrio, una festa di paese e la ca’ del liscio. Ciò che la fisarmonica produce è antitetico sia alla musica classica che al jazz, con cui condivide un’origine popolare, un low profile accattivante e popolaresco, di cui il jazz si è scrollato di dosso molto presto, non per «spocchia» culturale, ma per complessità compositiva che resta ben lontana dal saltello fischiettabile sotto la doccia.
Galliano è un musicista di fama mondiale, ha inciso una cinquantina di album, ha venduto milioni di dischi, un virtuoso con una visone orchestrale della musica, ha vinto premi, ma non so perché, a me, all’arena senza leoni del jazz, ha fatto pensare più all’orchestra spettacolo Castellina-Pasi che non ad Astor Piazzolla insieme a Gerry Mulligan di “Tango Nuevo” del 1974 o all’Orchestra di Duke Ellington, tanto per offrire qualche suggestione. Si potrebbe confutare, dicendo: ma Galliano non ha mai pensato a nulla del genere! Il guaio che siano altri a pensarlo, ne sono convinti, magari ritengono che il futuro del jazz o degli eventi para-jazz o finto-jazz, sia la fisarmonica e che il jazz di per sé non esita più e che sia solo una perifrastica attiva in continua evoluzione. Il povero (si fa per dire) Galliano da parte sua ha sempre messo le cose in chiaro, come dire non sono Gorni Kramer o Gianni Coscia: il progetto che porta in giro per le contee e le contrade si chiama «New York Tango Trio», ossia Richard Galliano, fisarmonica, Adrien Moignard, chitarra e Diego Imbert, contrabbasso. A parte il capo, i due subalterni hanno mostrano una tempra musicale ed esecutiva impeccabile.
Certo che da Buenos Aires a New York il passo non è breve: e noi, poveri ingenui, a pensare che nella Grande Mela ci fossero solo locali in cui si tengono furenti jam session colpi di post-bop. Così mentre Galliano e i suoi pards svuotano il mantice con melodie a presa rapida, ardimentosi ghirigori virtuosistici ed arcane suggestioni ottocentesche, cerco di fissare i miei rovelli mentali, facendo finta di essere nel mood. Contestualmente, cerco di castigare qualche sbadiglio, essendo per mia natura un afro-centrico, un cacciatore di groove, un amante delle poliritmie, ma senza la batteria non si batte chiodo. Per quanto, se il trio avesse fatto una sua versione musette di «Calabrisella», mi sarei rinfocolato. Invece mi accorgo che non distante da me c’è un gruppo che borbotta qualcosa e che non vede l’ora che il trio di tangheri smetta di suonare, ignari del fatto che Vinicio avrebbe invitato il fisarmonicista sul palco. Questi signori non hanno nulla contro Galliano – e neppure io – ma loro non si arrovellano tutti i giorni le meningi con questioni legate all’involuzione del jazz nell’epoca del web 4.0 o ai voli pindarici degli organizzatori di spettacoli di arte varia. Questi signori sono venuti per vedere Vinicio Capossela, cantautore ironico, ibrido, accompagnato da una band di tutto rispetto. Vinicio Capossela il più grande esponente del swing da cantina, capace di travasare stille di jazz liofilizzato in una sorta di sorgiva ed istintiva scrittura cantautorale dal testo improvvido e non sempre intellegibile, piacevole come un Paolo Conte su di giri, vestito con abiti cajun non distanti dal guardaroba di Zucchero Fornaciari. E lui stesso, il Vinicio, sempre sul filo dell’alcool-test, che si descrive più o meno così in una sua celebre canzone del 1990: «E ci siam poi noi musicisti un po’ beoni, un poco artisti, compagnoni e nati tristi, sempre afflitti dal denaro perché la roba costa caro, ma l’arte è cosa sacra e seria da salvar, per cento sacchi alla serata, facciamo una vita sregolata…», insomma una sorta di veni, didi, Vinicius. Intanto una signora mi strizza l’occhio e dice: Vinicio, lui sì che fa jazz, vero? Certamente, obbedisco, intanto vado di là a mangiare qualcosa, e torno all’una e trentacinque circa (non so quanti capiranno la battuta)! Così dicendo, mi defilo ballando e cantando: «Chimay, Bacardi Jamaican Rhum, White Lady, Beck’s Bier, Tequila Bum Bum, Dry gin, Charrington, Four Roses Bourbon…», ma la notte è ancora giovane, così a stomaco pieno, dopo l’uscita dall’arena senza gladiatori, fermo la macchina prendo il tablet e fisso i mie pensieri ad imperitura memoria. Così è scritto, così sia fatto!