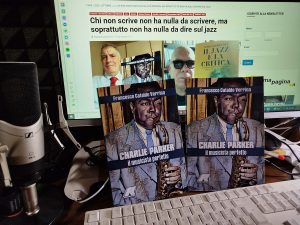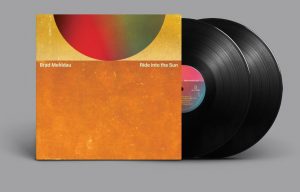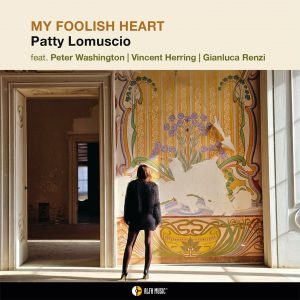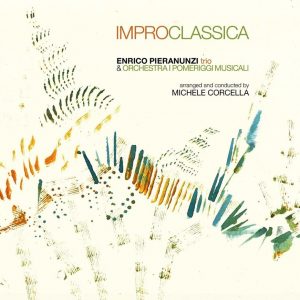Giuseppe Rossi: “Il jazz è la musica dell’attimo”

Giuseppe Rossi
di Guido Michelone
Torinese, attivo come avvocato e docente universitario a Milano, Giuseppe Rossi ha però il cuore a Roccella Jonica, la città calabrese, che, oltre il mare e la natura, egli vive soprattutto come ‘Rumori Mediterranei’ nell’ormai ventennale amicizia con il professor Vincenzo Staiano che del celeberrimo festival jazz è l’ideatore e da tempo colui che dirige, organizza, gestisce un’iniziativa unica nel suo genere del panorama musicale italiano. A livello di riscontro personale da circa un lustro in qua è bello ricordare le piacevoli serate di fine agosto all’anfiteatro (che ospita i concerti maggiori) quando i ruoli intervistato/intervistatore sono ribaltati e prima dei suoni il jazz viene vissuto e discusso a parole, attraverso le pagine dei tanti libri che sull’argomento si scrivono e si leggono.
D Così, a bruciapelo chi è Giuseppe Rossi ?
R Un ascoltatore, lettore e osservatore curioso
D Mi racconti ora il primo ricordo che hai del jazz da bambino o ragazzo?
R Intorno ai quattordici o quindici anni, curiosando tra i dischi dei miei, ho trovato antologie di Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman, di quelle con le note di copertina in italiano, che si vendevano in edicola. Ovviamente, a quel tempo ascoltavo il rock, Deep Purple, Led Zeppelin, etc. Quel modo di suonare diverso mi ha incuriosito.
D Che studi hai fatto e quali sono stati i tuoi ambiti professionali?
R Sono professore di diritto privato comparato alla IULM di Milano e avvocato, in materia di diritto commerciale. Mi sono laureato in giurisprudenza a Torino e ho fatto il dottorato di ricerca a Palermo.
D Quali sono i motivi che ti hanno spinto a occuparti di jazz? E in che modo?
R Curiosità prima, passione poi. Soprattutto da ascoltatore, di dischi e di concerti, e da suonatore amatoriale di pianoforte. Da qualche anno collaboro con il Roccella Jazz Festival, come suggeritore musicale e dando qualche consiglio legale, quando serve.
D E in particolare come ti definiresti o collocheresti nel jazz?
R Riprendo una tua tassonomia: a metà tra jazzofilo e jazzologo, anche un po’ jazzomane …
D Ma cos’è per te il jazz?
R Un approccio alla vita, che si basa sulla consapevolezza dell’estemporaneità e dell’imprevedibilità, viste però in modo positivo, come fonte di sorpresa e occasioni di scoperta. Il jazz è fatto di provvisorietà e di dubbio. Come diceva Ornette Coleman, nel jazz ogni nota può essere suonata ogni sera in modo diverso, perché ogni sera è diversa, ma anche perché tu sei un po’ diverso, ogni volta che la suoni. Forse, se c’è qualcosa che accomuna molti, se non tutti i grandi jazzisti, è che erano persone senza troppe sicurezze: economiche, sociali, culturali. Questo li ha resi capaci come pochi altri di cogliere, orazianamente, l’attimo. Ecco, secondo me il jazz è la musica dell’attimo.
D Quali sono le idee, i concetti o i sentimenti che associ a una musica come il jazz?
R Il jazz è ricco e complesso come la vita, proprio perché non tenta di negarne o ridurne la complessità, mediante il ricorso a schemi rigidi (cominciando da quelli formali: ritmici e tonali), concettualismi (come certa musica “colta”), o semplificazioni superficiali (come certo rock-pop). Al tempo stesso, però, non cade nella non comunicabilità che nasce dall’eccesso di complessità (fatte le debite eccezioni, ovviamente). Naturalmente questa è una semplificazione, che assume che si possa definire il jazz, e distinguerlo in modo nitido da altri generi di musica. Dal punto di vista del jazz, però, queste operazioni sono prive di senso. Il jazz ascolta tutto e, potenzialmente, suona tutto. Può essere decostruzionista, ma anche logico-formale, se questo serve per il suo fine espressivo, in quel luogo e in quel momento. Pensa a musicisti diversi come Duke Ellington, Thelonious Monk, Cecil Taylor, Anthony Braxton. Questo vale non solo per diversi musicisti, ma anche per lo stesso musicista, in momenti diversi. Pensa ancora a Ellington, o a Coleman. L’enfasi sull’elemento decostruzionista, che spesso si ritrova nei discorsi sul jazz (soprattutto in quelli di non musicisti) si spiega per il fatto che il jazz sa di non poter scegliere né il fine, né il luogo, né il momento. Questi sono dati. Pensa al blues. Non lo si sceglie, lo si ha e basta. Spesso non si scelgono il luogo e il momento in cui si suona, lo strumento che si usa, a volte neppure le persone con cui si suona. Questo, però, non significa inerzia, accettazione passiva del fatto. Al contrario, il fatto dato, il vissuto passato e presente, attraverso il jazz, diventano materia duttile, si trasformano in fatto musicale, e quindi in messaggio, mediante meccanismi che sono codificabili, ma non proprio del tutto. Questo succede quando il jazz funziona; quando, come si dice, “suona bene”. La famosa conversazione tra Derrida e Coleman, secondo me, è un dialogo tra sordi. Derrida cerca in Coleman conferme al suo approccio, ma a Ornette non interessa “decostruire”, come mera operazione concettuale, ma esprimere qualcosa, in quel momento, dati quei fatti, attraverso la musica. Costruisce o decostruisce a seconda di ciò che è necessario a per raggiungere questo fine.
D E cosa significa improvvisare?
R Direi cercare di raggiungere un certo risultato, ad esempio comunicativo (trasmettere un significato, o un’emozione, a qualcuno), in circostanze date e in limiti di tempo molto stringenti. Il concetto di improvvisazione viene spesso usato in un’accezione negativa, di cosa raffazzonata, frutto di incompetenza, caotica. Di nuovo l’enfasi sull’elemento decostruttivo, qui però decisamente peggiorativa. Io credo che, in realtà, l’improvvisazione sia tanto complessa quanto necessaria, nell’arte e, forse, nell’esistenza. Permettimi una metafora. Qualcuno che cammina, scegliendo a ogni incrocio la strada da prendere, a seconda delle sue curiosità, del tempo che ha e delle condizioni di ogni percorso, non avrà mai la velocità e la certezza di chi viaggia su un treno, seguendo i binari, verso una destinazione nota e immutabile. Questo non significa, però, che il suo viaggiare sia più semplice (al contrario), o abbia un valore, emotivo e conoscitivo, inferiore. Improvvisare significa svolgere un continuo lavoro di osservazione e di ascolto, di se stessi e del mondo, riducendo al minimo gli schemi interpretativi precostituiti (anche quelli che noi stessi creiamo). Richiede la rinuncia alle certezze, e la ricerca di qualcosa che ha la stessa evanescenza di una nota, che suona, si spegne e non risuonerà mai allo stesso modo. L’improvvisatore sa che la stessa strada potrà essere percorsa più e più volte, ma ogni volta ci sarà qualcosa di diverso, in lui e nella strada.
D Quanto conta l’improvvisazione nel fare jazz?
R Si può fare jazz senza improvvisazione, o viceversa. Molto grande jazz è scritto, compresi vari assoli. D’altra parte, l’improvvisazione, anche musicale, preesiste al jazz e si manifesta, tuttora, anche in ambiti non jazzistici (incluse forme molto alla moda di musica pop). Resta il fatto che il jazz è un terreno preferenziale per l’improvvisazione, anche “radicale”, e questo non stupisce, alla luce di quanto detto finora. Credo ci siano almeno due considerazioni da fare, a questo proposito. La prima: il jazz, anche quando non pone l’improvvisazione in primo piano, non cerca (quasi) mai l’asetticità, la sospensione del mondo propria della sala da concerto. Sta sempre nel mondo, anche se si tratta, magari, di una grande orchestra che esegue una partitura in una sala da ballo, come negli anni d’oro delle big band. Così, la musica è sempre parte del mondo, e viceversa, senza diventare mera forma proposizionale, anche quando è scritta. La seconda: il jazz non ha paura dell’errore, perché, anche quando la musica è scritta, il jazz tende a non riconoscere alla proposizione (partitura) una normatività “forte”, capace di sconfinare sul piano dell’espressività, come accade invece quando si segue un’idea filologica della partitura nella musica “colta”. Certo, anche nel jazz la melodia è quella scritta, ma può “suonare bene” in molti modi, nessuno dei quali è giusto a priori. Non a caso, il più significativo elogio dell’errore, nel jazz, è venuto da un grande compositore, come Thelonious Monk, munito di una conoscenza straordinaria dell’armonia. Non-rimozione del fatto (o addirittura immersione nel fatto) e consapevolezza della valenza positiva dell’errore rievocano qualcosa di improvvisativo, anche quando ci sono partiture.
D Tra i dischi che hai ascoltato ce ne è uno a cui sei particolarmente affezionato? E quali dischi (2-3) porteresti sull’isola deserta?
R “Workin’ with the Miles Davis Quintet”, il primo disco di jazz che ricordo di aver comprato. Cinque personalità diversissime che danno vita a suoni straordinari. Tre musicisti da isola deserta: Duke Ellington, Thelonious Monk, Muhal Richard Abrams. Sono tutti pianisti… Aggiungo un sassofonista: Lester Young.
D Quali sono stati i tuoi maestri (o riferimenti) nella musica, nella cultura, nella vita?
R Musicalmente sono un autodidatta, con tutti i limiti del caso. Nella mia vita accademica e professionale ho incontrato grandi maestri, che non si consideravano tali. Questa è stata la mia più grande fortuna. La mia ambizione è continuare ad essere studente, prima che studioso, o addirittura professore. Purtroppo temo di non riuscirci sempre.
D Parliamo ora di Rumori Mediterranei, la creatura di Vincenzo Staiano (e anche un po’ la tua), altrimenti nota come Roccella Jazz Festival Internazional.
R Ho scoperto Rumori Mediterranei da un annuncio su “Musica Jazz”, poteva essere il 1990, o giù di lì. Fui colpito dal programma, che dava molto spazio al jazz più innovativo, con grandi nomi americani ed europei affiancati a musicisti italiani, di primo piano o meno, e attenzione agli incontri tra jazz e altre forme d’arte. Nel 1994 sono stato a Roccella per la prima volta, nel 2009 ci ho comprato casa, ora passo là più tempo che posso, con mia moglie e mia figlia. La cosa più straordinaria del Roccella Jazz Festival è che si svolge, ininterrottamente da quarantun anni, a Roccella, un paese di settemila abitanti sulla costa jonica reggina, dove è difficile anche arrivare. Eppure ci sono arrivati tutti i più grandi musicisti del jazz dagli anni Ottanta a oggi. Però quando conosci Roccella, ti rendi conto che questo poteva capitare solo là. È un luogo che ha poteri magici.
D Aneddoti o esclusive sulla storia di questo festival?
R A ogni chiusura di festival, c’è la sensazione di una sorta di miracolo compiuto, grazie alla tenacia del direttore artistico, Vincenzo Staiano, che è cuore, mente creativa e anima del festival, all’impegno dell’amministrazione comunale e alla disponibilità entusiasta di molti volontari. Questa capacità di raggiungere ogni volta un risultato importante, in un contesto di perenne incertezza sulle risorse (innanzitutto finanziarie, intendo) ha anch’essa un qualcosa di improvvisativo, nel senso del termine di cui abbiamo discusso. Un’esclusiva: il principale sostenitore del festival, il compianto senatore Sisinio Zito, non era affatto un appassionato di jazz. Amava la musica classica. Nonostante questo, ha profuso grandissime risorse, morali e materiali, nel festival, perché credeva che il jazz, musica di minoranze, di persone senza paura dell’incertezza, potesse simboleggiare un territorio come la Calabria, difficile e meraviglioso, spesso oggetto di pregiudizio e rappresentazioni parziali. Un aneddoto: presentazione di un concerto rievocativo del festival di Woodstock. Il presentatore: “tra poco rivivremo quel memorabile evento orgiastico …”. Nessuno del pubblico si è mosso o ha accennato ad andarsene. Bè, i memorabili eventi orgiastici non capitano tutti i giorni.
D Ci sono jazzisti che a Roccella ti hanno lasciato qualcosa dopo averli ascoltati o incontrati?
R Roscoe Mitchell che racconta i suoi incontri con Sun Ra, mangiando pesce sulla spiaggia, o Dave Holland che racconta le session con Miles, sempre a tavola. Questa è una delle cose belle di Roccella. È facile creare un’atmosfera conviviale, che secondo me giova anche alla qualità della musica. Penso che si suoni meglio, se si sta bene. Di concerti ne ricordo tanti: Michel Petrucciani, Charles Lloyd con Geri Allen al piano, ancora Roscoe Mitchell, Famoudou Don Moye.
D Qual è per te il momento più bello nella storia di Rumori Mediterranei?
R Il concerto simbolo del Festival è quello in cui George Russell esegui la sua versione della Follia, col sottotitolo Roccella Variations. Peccato che su disco sia disponibile soltanto la versione di un concerto londinese, in cui Russell eseguì nuovamente il brano, che aveva arrangiato per il festival di Roccella. Quel concerto roccellese appartiene alla storia del jazz, in Italia e non solo. Quell’anno, però, non c’ero, quindi parlo de relato … Il momento più bello che ricordo personalmente, invece, è l’esecuzione di SiSong, la suite di Claudio Cojaniz in memoria di Sisinio Zito, poco dopo la sua scomparsa.
D Come vedi la situazione della musica (e del jazz in primis) in Italia?
R Il principale problema, a mio avviso, è che si suona (e si canta) poco. A scuola, cominciando dalle elementari, la musica quasi non c’è (ovviamente con le eccezioni del caso, dovute spesso all’impegno personale di singoli insegnanti). Se non si proviene da famiglie in cui si suona, o si ascolta musica non strettamente “di consumo”, mancano le occasioni per incontrare generi musicali diversi da quelli più diffusi alla radio o su internet, o per praticare uno strumento (anche qui con lodevoli eccezioni, come, ad esempio, bande, cori o associazioni musicali, ancora abbastanza diffusi, soprattutto in provincia). Viva, naturalmente, i licei musicali e i conservatori, ma la musica non può stare soltanto lì (altrimenti il jazz non sarebbe mai esistito), deve avere un’origine sociale più vasta. Forse però questi processi di creazione diffusa di musica esistono, ma si svolgono in ambiti per me lontani, come rap, trap e simili. Sospendo il giudizio. Aggiungo un’ultima cosa: si suona poco dal vivo, soprattutto fuori dalle occasioni “ufficiali”, come festival e concerti “in sala”. Sono sempre meno i locali in cui si suona live, e questo fa venire meno una palestra, un luogo di pratica quotidiana, per i musicisti e per il pubblico. Spesso il jazz si fa tra sala d’incisione e concerti, e così finisce col risultare un po’ asettico, col perdere quella connessione col fatto di cui parlavo.
D E più in generale della cultura in Italia?
R Domanda difficile, anche perché ti confesso che credo di non sapere bene cosa sia la “cultura”. Spesso si usa questo termine per indicare le politiche pubbliche di promozione delle arti. Dubito, però, che il concetto di scelta politica, qualunque essa sia, possa risultare compatibile con la connaturale, imprescindibile esigenza di libertà che è propria di qualsiasi espressione di pensieri, riflessioni o sensazioni. Non posso evitare il sospetto che la “cultura” finanziata dal decisore istituzionale, di qualsiasi colore politico, non sia mai del tutto libera. Del resto, la libertà ha talvolta un prezzo altissimo, che sconfina nell’eroismo, e il jazz ci ha offerto molti esempi di grandi musicisti vissuti e morti in povertà e emarginazione, proprio per le loro scelte di libertà. Un solo nome, tra tanti possibili: Eric Dolphy. Però la tua domanda ha un possibile senso più ampio: quanta creatività c’è oggi in Italia, e quanta ricettività verso questa creatività? Non so dare una risposta. Dico solo che noi italiani siamo sempre stati, e siamo tuttora, un popolo creativo nonostante tutto, anche nei periodi più bui (e questo non lo è), o semplicemente più scialbi – vacui (e questo forse lo è) della vita pubblica e istituzionale. Siamo abituati all’incertezza, e questo ci rende buoni improvvisatori.
D Come avvocato e come cattedratico ti occupi molto anche del mondo del copyright nello spettacolo: c’è qualcosa in tal senso in cui il jazz è in debito o in credito?
R Molte melodie, soprattutto nel periodo del be-bop, sono state composte per utilizzare nell’improvvisazione giri armonici di brani preesistenti, senza dover pagare i diritti d’autore sulla loro melodia. La melodia è tutelata dal diritto d’autore, mentre l’armonia, che si presta ad un’infinità di possibili sviluppi melodici, proprio per questo non è appropriabile. In negativo, il diritto d’autore ha offerto a grandi improvvisatori, come Charlie Parker o Dizzy Gillespie, l’occasione per comprendere quanto ci si potesse allontanare, a livello ritmico e melodico, da una composizione, pur mantenendone riconoscibile l’armonia. Quanto ai crediti, il jazz ha offerto innumerevoli occasioni di campionamento, di suoni, frammenti di assoli, schemi ritmici, a generi successivi, come l’hip hop. In qualche caso ci sono stati anche contenziosi legali.
D Cosa stai progettando per l’immediato futuro?
R Sto scrivendo un libro sulla natura improvvisativa del diritto, che spero di terminare entro quest’anno. C’è un’idea radicata nel pensiero giuridico, che il diritto sia una composizione, che i consociati, ed il giudice, quando necessario, eseguono. Ne dubito fortemente. Sospetto, invece, che nessun legislatore abbia la libertà di un compositore, e che la regola di diritto sia un tentativo di instaurare un nesso di comunicazione, tra il legislatore ed i consociati, in circostanze di fatto date, ed entro limiti di tempo molto circoscritti. Insomma, qualcosa di abbastanza simile all’improvvisazione.