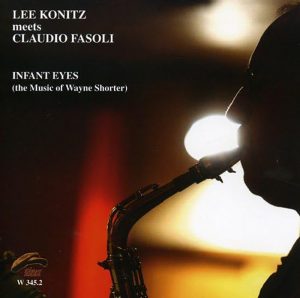Intervista inedita a McCoy Tyner: anno 2009

McCoy Tyner
La musica non esiste senza ascoltatori: ogni nota trova senso solo se incontra un orecchio e un cuore pronti ad accoglierla. In Italia ho sempre ho trovato un pubblico che sa ascoltare, e questo rappresenta il dono più grande.
// di Francesco Cataldo Verrina //
McCoy Tyner rappresenta una delle figure cardine del pianismo jazz del secondo Novecento: protagonista di una parabola artistica che ha attraversato epoche, linguaggi e contesti culturali senza mai perdere coerenza e identità. La sua scrittura quartale, la potenza del tocco e la capacità di coniugare rigore armonico e libertà espressiva lo hanno reso un interprete unico, capace di incidere profondamente sul corso della musica afro-americana. Dalla formazione giovanile a Filadelfia, nutrita dall’influenza di Bud Powell e dei grandi maestri della tradizione, fino alla consacrazione nel quartetto di John Coltrane, Tyner ha vissuto la propria carriera come un laboratorio continuo, in cui ogni fase discografica – Impulse! Records, Blue Note, Milestone, Columbia – ha segnato un diverso capitolo di ricerca e di affermazione. La sua opera, che conta oltre settanta titoli da leader, si colloca in un arco spazio-temporale ampio e diversificato, in cui il pianista ha saputo mantenere un linguaggio netto e distintivo, talvolta fedele al canone del bop, altre volte anticipatore di nuove istanze sonore. Album come «The Real McCoy», «Expansions», «Sahara», «Sama Layuca», «Together» e «Looking Out» testimoniano la sua capacità di reinventarsi, di dialogare con compagni di viaggio di altissimo livello e di confrontarsi con le trasformazioni del jazz e della musica popolare. Questa intervista realizzata nel 2009, anno dell’ultima apparizione di McCoy Tyner a Umbria Jazz, ripercorrere le tappe fondamentali della carriera del pianista di Filadelfia, un artista che ha saputo incorporare nella sua musica la tensione fra tradizione e modernità, spiritualità e disciplina, afrocentrismo ed aperture cosmopolite.
(Verrina): Hai più volte sottolineato come le diverse etichette discografiche abbiano rappresentato fasi distinte del tuo percorso creativo. Potresti illustrare come la Impulse! Records, la Blue Note e la Milestone abbiano contribuito, ciascuna a suo modo, alla definizione del tuo linguaggio pianistico?
(Tyner): Con la Impulse! mi sono confrontato soprattutto con repertori standard e con poche composizioni originali, affinando la mia capacità di interpretare e rielaborare materiali già sedimentati nella tradizione. La Blue Note mi ha offerto l’occasione di cercare un suono personale, di affermare una voce autonoma. Con la Milestone, infine, ho goduto di una libertà esplorativa che mi ha consentito di seguire le suggestioni del momento, senza vincoli precostituiti.
(Verrina): La tua scrittura armonica, fondata sulla quartalità, ha segnato un punto di svolta nella storia del pianismo jazz. Quali furono le matrici e le influenze che ti condussero verso questa scelta stilistica?
(Tyner): La quartalità mi ha permesso di costruire strutture sonore capaci di espandere lo spazio armonico, liberandolo dalla rigidità tonale. Fin da ragazzo, osservando Bud Powell e studiando i maestri afro-americani come Art Tatum, Duke Ellington ed Earl Hines, ho percepito la necessità di modernizzare le loro intuizioni. La quartalità è divenuta il mio strumento per proiettare quelle radici verso un linguaggio più aperto e propulsivo.
(Verrina): La tua vicinanza a Bud Powell, in età adolescenziale, sembra aver avuto un ruolo decisivo. In che modo quell’esperienza ha inciso sulla tua formazione?
(Tyner): Abitare a pochi isolati da Bud Powell significava avere un modello vivente da osservare e imitare. A tredici anni, stimolato da mia madre, iniziai a studiare il pianoforte con la consapevolezza che Powell incarnava una via di rigore e di libertà. Il suo esempio mi ha insegnato che la tecnica non è mai fine a sé stessa, ma deve sempre tradursi in espressione.
(Verrina): L’ingresso nel Jazztet di Benny Golson e Art Farmer, e subito dopo nel quartetto di John Coltrane, rappresentano due momenti fondativi. Quale fu la portata di queste esperienze?
(Tyner): Il Jazztet mi introdusse a un laboratorio di sperimentazione collettiva, dove la scrittura e l’improvvisazione s’intrecciavano. Con Coltrane, invece, si trattò di una vera e propria missione spirituale. Per cinque anni abbiamo condiviso un percorso che ha plasmato la storia del jazz. Album come «My Favorite Things» o «A Love Supreme» testimoniano quella connessione profonda, che io stesso ho definito come un motore unico, capace di muoversi all’unisono.
(Verrina): Il tuo distacco da Coltrane è stato spesso interpretato come una scelta di fedeltà alla regolarità armonica. Come hai vissuto quel momento?
(Tyner): Fu un divorzio doloroso, ma inevitabile. John si spingeva verso territori di dissonanza e atonalità che non sentivo miei. Io ho sempre creduto nella congruità dello sviluppo armonico, nell’uso regolamentato del modale e nei ritmi africani. Restare fedele a questa visione significava preservare la mia identità artistica, anche a costo di separarmi da un fratello spirituale.
(Verrina): Dopo il 1965, hai vissuto un periodo di sospensione, privo di contratto discografico. Come rivivi oggi, a distanza di anni, quella fase di transizione?
(Tyner): Fu un tempo di prova e di resilienza. Mi adattai a lavori umili, persino a fare il tassista. Ma proprio quella sospensione mi costrinse a riflettere ed a rinnovare la mia energia creativa. Quando tornai con «The Real McCoy», nel 1967, ero pronto a riaffermare la mia voce con maggiore maturità.
(Verrina): «The Real McCoy» viene considerato il manifesto programmatico del tuo nuovo corso. Quali elementi lo rendono così emblematico?
(Tyner): In quell’album tutto era mio: le composizioni, la direzione e la visione. Con Joe Henderson, Ron Carter ed Elvin Jones ho costruito un contesto in cui il pianoforte diventava il punto cardine, lasse portante. Brani come «Passion Dance» o «Blues On The Corner» condensano le mie esperienze precedenti e le proiettano in una prospettiva moderna, senza rinunciare al legame con la tradizione.
(Verrina): Con «Expansions», registrato nel 1968, hai utilizzato un ensemble più ampio e un linguaggio più articolato. Qual era la tua intenzione con quel progetto?
(Tyner): Volevo ampliare gli orizzonti, mettere in evidenza le mie doti di compositore e arrangiatore. Con Wayne Shorter, Woody Shaw, Gary Bartz e gli altri, ho costruito un tessuto sonoro espanso, dove il pianoforte dialogava con fiati e archi. Motivi come «Vision» o «Song Of Happiness» testimoniano la mia volontà di esplorare il modale in chiave propulsiva, ma anche di aprirmi a suggestioni afrocentriche e orientali.
(Verrina): La critica ha spesso sottovalutato «Expansions», forse per la sua uscita ravvicinata rispetto a «The Real McCoy». Come valuti questo atteggiamento da parte degli addetti ai lavori?
(Tyner): Credo che i media abbiano ragionato in termini di quantità, non di qualità. «Expansions» fu pubblicato troppo presto e non ebbe il tempo di essere compreso. Ma per me rappresenta un passo fondamentale: la dimostrazione che potevo esprimermi fuori dal cono d’ombra di John Coltrane, con uno stile chiaro e distintivo.
(Verrina): Gli anni ’70 hanno rappresentato per molti musicisti un terreno di tentazioni e deviazioni. Tu hai optato per un percorso di innovazione controllata. Quale fu la tua strategia per mantenere un equilibrio tra sperimentazione e coerenza stilistica?
(Tyner): Non ho mai voluto abbandonarmi a un’avanguardia priva di regole. Ho cercato sempre un metro di misura vigile, circoscritto. Con «Sahara» ho trovato un centro di gravità ideale: libertà sonora, ma senza debordare nella dissonanza. Era un modo per concedere spazio all’energia e al misticismo, senza perdere la rotta.
(Verrina): «Sahara» del 1972 viene considerato una delle tue opere più riuscite. Quali elementi lo rendono un punto culminante della tua carriera?
(Tyner): È un album che sintetizza la mia volontà di espandere la definizione di jazz. La title-track, lunga oltre ventitré minuti, diventa una narrazione che evoca Africa e deserto, con percussioni, flauto e vampate di ottoni. Ho voluto un panorama sonoro variegato, capace di sedurre senza atterrire. La mia energia era canalizzata con precisione, e i miei compagni, da Sonny Fortune ad Alphonse Mouzon, hanno contribuito a un risultato collettivo di grande forza.
(Verrina): In «Sahara» utilizzi anche strumenti non convenzionali, come il koto giapponese. Che cosa ti spinse in tale direzione?
(Tyner): Il koto mi ha permesso di tessere un arazzo impressionistico, delicato, che si intrecciava con il flauto di Sonny Fortune. Era un modo per aprire il mio linguaggio a suggestioni ecumeniche, per dimostrare che il jazz poteva dialogare con culture diverse senza cadere nell’esotismo superficiale.
(Verrina): Due anni dopo, con «Sama Layuca», ti sei misurato con un concept unitario, quasi sinfonico. Qual era, realmente, la tua intenzione con quel disco?
(Tyner): «Sama Layuca» fu un album concepito come un insieme di movimenti concatenati. Ho voluto creare una narrazione cinematografica, dispiegata con lirismo e poliritmi. Con Bobby Hutcherson, Gary Bartz, Azar Lawrence e gli altri, ho costruito un tessuto sonoro omogeneo, impregnato di sensualità e forza espressiva. Ritengo che sia stato un altro momento di eccellenza, una tappa vinta nella mia lunga corsa negli anni ’70.
(Verrina): Il periodo Milestone fu per te particolarmente prolifico. Che valore dai a quella fase della tua carriera?
(Tyner): La Milestone mi offrì libertà e compagni di viaggio straordinari. Potevo registrare seguendo molteplici impostazioni stilistiche, scegliendo strumentisti che ammiravo. In album come «One Of Another Kind» emerge la mia capacità di arrangiatore, di coordinare fiati e ritmi con precisione.
(Verrina): Con «Together» del 1978 sei stato abile nel mettere insieme un super collettivo di musicisti. Quale fu la formula per mantenere l’equilibrio in un contesto così ricco di personalità?
Risposta (Tyner): In genere questi set rischiavano di degenerare in egoismi. Ma con Freddie Hubbard, Hubert Laws, Bennie Maupin, Bobby Hutcherson, Stanley Clarke e Jack DeJohnette abbiamo trovato un senso di collegialità perfetto. Ognuno ebbe spazio per esprimersi, ma sempre in funzione di un progetto comune. I miei assoli divampavano con energia, ma erano parte di un dialogo equilibrato.
(Verrina): Negli anni ’80 il panorama musicale era attraversato da trasformazioni radicali: la fusion si dilatava, il pop-latino e la disco-funk conquistavano il pubblico afro-americano. Così, con «Looking Out» del 1982, ti sei voluto confrontarsi con queste nuove istanze. Quale fu la motivazione?
(Tyner): Sentivo il bisogno di dialogare con lo spirito del tempo. «Looking Out» non voleva essere una jam session tradizionale, ma un prodotto raffinato, capace di portare elementi jazz dentro la musica di consumo giovanile. Con Carlos Santana, Stanley Clarke, Gary Bartz e la voce di Phyllis Hyman ho cercato di costruire un ponte tra il mio linguaggio e le nuove forme di espressione.
(Verrina): All’epoca l’album fu definito «commerciale» da parte della critica. Oggi, invece, viene rivalutato come un lavoro di gran classe. Come interpreti questa differenza di percezione?
(Tyner): Credo che molti critici non colsero lo zeitgeist. «Looking Out» era l’epitome di un’America ottimista, opulenta, apparentemente risolta nei suoi conflitti. Non voleva essere un esercizio di avanguardia, ma un prodotto di qualità, capace di dialogare con il loisir e con la cultura popolare. Oggi si riconosce che, pur deragliando dai binari del jazz, riuscii a portare innovazione dentro un genere ibrido.
(Verrina): La collaborazione con Phyllis Hyman ha dato all’album una dimensione soul-jazz di forte intensità. Quale valore assegni alla sua voce nel contesto del disco?
(Tyner): Phyllis Hyman era una voce portentosa, capace di fondere soul e jazz con naturalezza. In canzoni come «Love Surrounds Us Everywhere» o «In Search of My Heart» la sua presenza ha aggiunto profondità emotiva e sensualità. Il mio pianoforte dialogava con lei, creando un contrappunto che elevava la struttura armonica.
(Verrina): In «Looking Out» si percepisce anche l’influenza di Carlos Santana e di un certo pop-latino. Come s’inserisce questa componente nel tuo percorso?
(Tyner): Santana ha saputo sfruttare le intuizioni di questo genere ibrido, portandole al successo negli anni successivi. Con lui ho voluto esplorare un modulo pop-dance-latino che conservasse una valenza jazzistica. Il mio fraseggio e lo sviluppo tematico restavano fedeli alla mia identità, ma si aprivano a contaminazioni che arricchivano il tessuto sonoro.
(Verrina): Guardando a distanza di tempo, quale significato attribuisci alla tua breve esperienza con la Columbia Records?
(Tyner): Fu un approdo risolutivo anche dal punto di vista economico. Dopo anni di sperimentazione e fatica, la Columbia mi offrì gratificazioni concrete. In due soli lavori ho potuto dimostrare che il jazz poteva dialogare con il mainstream senza perdere dignità. «Looking Out» rimane la testimonianza di quella fase, un album che oggi considero di gran classe.
(Verrina): Siamo qui ad Umbria Jazz, uno dei festival più prestigiosi al mondo. Come ti trovi in questa cornice e quali ricordi conservi delle sue prime apparizioni a Perugia?
(Tyner): Umbria Jazz è per me un luogo di incontro e di celebrazione. Ogni volta che torno a Perugia sento di entrare in una comunità che vive il jazz con passione autentica. Ricordo la mia prima volta qui come un’esperienza intensa: il pubblico appariva colorato, entusiasta, rumoroso, ti veniva quasi addosso, ma era partecipe e desideroso di cogliere le sfumature del mio linguaggio. È raro trovare un contesto in cui la musica venga ascoltata con tale coinvolgimento e rispetto.
(Verrina): Quale valore attribuisci a un festival come questo, che da decenni porta il jazz in dialogo con culture e generazioni diverse?
(Tyner): Festival come Umbria Jazz hanno un ruolo fondamentale: creano ponti tra tradizione e contemporaneità, tra musicisti e ascoltatori di ogni provenienza. Qui non si celebra soltanto la musica jazz, ma si costruisce un tessuto culturale che rafforza il senso di comunità. È un privilegio poter contribuire a questa storia.
(Verrina): Prima di congedarci, desideri rivolgere un saluto al pubblico italiano che ti segue con tanta dedizione?
(Tyner): Sono sempre grato a tutti coloro che hanno accompagnato il mio percorso, dagli anni giovanili fino ad oggi. La musica non esiste senza ascoltatori: ogni nota trova senso solo se incontra un orecchio e un cuore pronti ad accoglierla. In Italia ho sempre ho trovato un pubblico che sa ascoltare, e questo rappresenta il dono più grande. Vorrei ringraziare anche te e gli amici della radio, con la speranza che il jazz continui a essere per tutti noi un linguaggio di libertà e di bellezza.