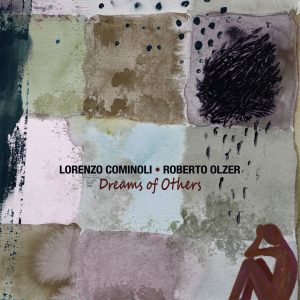Emmet Cohen: eredità e metamorfosi del pianismo jazz contemporaneo

Emmet Cohen
Nell’universo pianistico di Emmet Cohen si avverte con nettezza una trama di rimandi che lo collega alle figure cardine del pianismo afro-americano del Novecento, da cui egli ha saputo trarre ispirazione senza mai cadere in una sterile imitazione. La sua tastiera, infatti, porta in sé le tracce di una genealogia plurale.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Emmet Cohen è uno dei jazzisti più attivi sulla scena mondiale, basta dare un’occhiata ai cartelloni dei vari festival di rilievo sparsi in tutto il mondo. Pianista di raro eclettismo, Cohen risulta capace di coniugare una solida formazione accademica con un innato talento comunicativo che lo ha reso una delle personalità più significative della sua generazione. Il percorso artistico, avviato precocemente all’età di tre anni, si è nutrito dapprima della disciplina del pianoforte classico presso la Divisione Pre-College della Manhattan School Of Music, per poi approdare a un consolidamento accademico che lo ha visto laurearsi alla Frost School Of Music dell’Università di Miami e perfezionarsi con un master ancora alla Manhattan School Of Music. Questa duplice tensione tra rigore tecnico e libertà espressiva ha costituito la matrice di un linguaggio pianistico che unisce virtuosismo, lirismo e profonda attenzione all’interazione con gli altri musicisti.
Il debutto discografico, avvenuto nel 2011 con «In the Element» in trio con Joe Sanders e Rodney Green, manifesta già l’attenzione di Cohen alla dimensione collettiva del fare jazz: il pianoforte non come strumento di mera esposizione individuale, ma quale catalizzatore di energie dialogiche. Tale attitudine trova ulteriore conferma in «Infinity» (2013), lavoro che lo vede al fianco di Giuseppe Venezia ed Elio Coppola, esponenti di rilievo della scena jazzistica italiana, a testimonianza di una vocazione internazionale che non si limita ai circuiti statunitensi. L’anno successivo, con «Questioned Answer», Cohen intreccia il proprio percorso con due figure di grande autorevolezza come Brian Lynch e Billy Hart, delineando un itinerario musicale che si fonda su un costante dialogo con i maestri e su una spiccata sensibilità per la tradizione. Il progetto forse più emblematico della sua visione artistica è rappresentato dalla «Master Legacy Series», iniziata nel 2017, un ciclo discografico concepito come atto di filiazione e di trasmissione culturale. In esso Cohen invita leggendari interpreti quali Jimmy Cobb, Ron Carter, Albert “Tootie” Heath, Benny Golson e George Coleman a condividere il palco e lo studio di registrazione, creando un corpus di testimonianze sonore le quali, più che celebrare, intendono tramandare un lascito musicale. In queste collaborazioni, la sua pianistica si modella come terreno fertile in cui si intrecciano memoria storica ed invenzione, rigore stilistico e freschezza improvvisativa. La poetica di Cohen non si riduce a un esercizio di stile o a un brillante virtuosismo tecnico, bensì tende a una concezione del jazz come esperienza di comunione: «suonare significa esprimere l’essenza più intima della propria individualità e, insieme, intessere vincoli duraturi con l’ascoltatore». Tale dichiarazione di intenti trova riscontro non solo nella produzione discografica, ma anche nella sua intensa attività concertistica ed in iniziative di divulgazione digitale come la serie «Live From Emmet’s Place», che durante la pandemia ha trasformato il suo appartamento newyorkese in un laboratorio di resistenza culturale, capace di attrarre un pubblico planetario e di ribadire la vitalità del jazz come arte viva e condivisa. Il percorso di Cohen si colloca così in una prospettiva che non indulge in nostalgie museali, ma rinnova la tradizione attraverso un gesto creativo fondato sull’ascolto reciproco e sull’urgenza di mantenere il jazz come linguaggio contemporaneo. In lui si riconosce la tensione di una generazione che, pur consapevole dell’eredità dei maestri, non rinuncia a elaborare nuove forme di comunicazione musicale, dando voce a un’idea di arte intesa come continuità, dialogo e responsabilità verso il futuro.
Nell’universo pianistico di Emmet Cohen si avverte con nettezza una trama di rimandi che lo collega alle figure cardine del pianismo afro-americano del Novecento, da cui egli ha saputo trarre ispirazione senza mai cadere in una sterile imitazione. La sua tastiera, infatti, porta in sé le tracce di una genealogia plurale, che intreccia il lirismo sofisticato di Bill Evans con la robusta architettura armonica di McCoy Tyner, la sobrietà cantabile di Ahmad Jamal e la vitalità inesauribile di Oscar Peterson. Dal primo eredita la cura minuziosa del colore timbrico e la capacità di trasformare l’accordo in una nube cangiante, in cui ogni nota vibra come parte di un continuum poetico; da Tyner assimila il senso della monumentalità, con accordi quartali che conferiscono ampiezza orchestrale allo strumento; da Jamal raccoglie l’arte della rarefazione e del silenzio, la gestione teatrale dello spazio sonoro, la propensione a trasformare il non detto in tensione musicale; da Peterson, infine, accoglie l’irrefrenabile agilità tecnica e il gusto per la brillantezza, senza mai rinunciare al senso dello swing più autentico. Ma la sua tavolozza non si esaurisce qui. Vi si ritrovano anche le ombre profonde e bluesy di Wynton Kelly, il fraseggio narrativo di Hank Jones, la ricercata linearità di Tommy Flanagan, fino a risuonare con l’energia contagiosa di Phineas Newborn Jr. La sua cifra pianistica, in tal senso, può essere interpretata come una sintesi dinamica di modelli eterogenei, in cui la tradizione afro-americana non viene mai citata come reliquia, bensì riattivata come linfa vitale. L’affinità con questi grandi maestri non consiste in un calco superficiale, bensì nella condivisione di un principio estetico: il pianoforte come voce capace di coniugare disciplina e libertà, radicamento ed invenzione. Come Evans, Cohen ricerca la dimensione contemplativa; come Peterson e Tyner, non rinuncia alla potenza del gesto; come Jamal, riconosce al silenzio un ruolo costitutivo. Il suo stile, dunque, si colloca in un orizzonte di continuità, in cui il passato diviene matrice di un presente vivo, rielaborato con una sensibilità contemporanea. In definitiva, i modelli di riferimento di Emmet Cohen non sono semplici fari da seguire, bensì interlocutori immaginari con cui intrattiene un dialogo costante. Attraverso essi egli ribadisce l’idea di jazz come tradizione in divenire, una lingua collettiva che si rinnova nel momento stesso in cui viene pronunciata.
La traiettoria estetica di Emmet Cohen, pur radicata nella tradizione afro-americana, rivela consonanze significative con alcune figure europee contemporanee che, in modi differenti, hanno interpretato il pianoforte jazz come strumento di dialogo intergenerazionale e come veicolo di una poetica al contempo colta e accessibile. Non si tratta di somiglianze epidermiche, bensì di affinità sotterranee, di un comune habitus musicale che tende a coniugare perizia tecnica, profondità culturale e vocazione comunicativa. Si pensi, ad esempio, a Stefano Bollani, la cui cifra ironica e teatrale cela una serissima capacità di muoversi tra generi e linguaggi con spirito ludico ed insieme rigoroso. Cohen, come Bollani, sembra concepire il concerto non solo come esecuzione ma come rito comunitario, luogo di scambio e di vitalità condivisa. Diversa, ma altrettanto pertinente, è la parentela con Enrico Pieranunzi, custode di una linea poetica in cui la raffinatezza armonica e la cantabilità melodica si fondono con una disciplina formale ereditata dal pianismo classico europeo. Cohen manifesta una sensibilità affine quando scolpisce linee trasparenti e liriche, senza indulgere nell’eccesso ornamentale. Un’altra analogia può rintracciarsi nel percorso di pianisti nordici come Bobo Stenson o Tord Gustavsen, interpreti che hanno saputo innestare nella grammatica jazzistica un senso di sospensione e di rarefazione, quasi una dilatazione contemplativa del tempo sonoro. In Cohen, pur con una matrice più swingante e ritmicamente radicata, si ritrova la medesima attenzione all’introspezione, al respiro del fraseggio, alla capacità di creare atmosfere fitte con un uso calibrato del pedale e del silenzio. In senso più ampio, si potrebbe dire che Cohen condivide con molti pianisti europei l’idea di un jazz che non vive di pure citazioni, ma di relazioni culturali: da una parte il rigore accademico e la conoscenza del repertorio classico; dall’altra la volontà di mantenere viva la pulsazione afro-americana che costituisce l’essenza del genere. Se Bollani rappresenta la dimensione estroversa e Pieranunzi quella intimista, se Stenson e Gustavsen incarnano la spiritualità rarefatta del Nord, Cohen sembra collocarsi in un crocevia ideale, capace di sintetizzare le qualità di ciascuno pur rimanendo fedele al cuore pulsante della tradizione statunitense. In questa prospettiva, i modelli europei non appaiono come semplici punti di riferimento stilistici, ma come paralleli artisti che, pur da contesti differenti, condividono con Cohen la consapevolezza che il jazz del XXI secolo debba essere al tempo stesso memoria, invenzione e testimonianza viva di un’arte in continua trasformazione.
Il confronto fra Emmet Cohen e Manuel Magrini, giovane pianista umbro di notevole sensibilità, permette di cogliere come due percorsi diversi, uno radicato nel cuore del vernacolo afro-americana e l’altro sviluppatosi nel contesto europeo, possano convergere su alcuni punti e divergere su altri, generando un terreno di osservazione fecondo. Sul piano ambientale, Cohen porta con sé l’eredità della scena newyorkese fatta di club, jam session ed un tessuto musicale intriso di storia, in cui il lineage con i maestri non costituisce un dato accademico ma un’esperienza diretta. L’idea di jazz che lo anima risulta dunque inseparabile da un contesto urbano pulsante, in cui la memoria dei leggendari trii e quartetti continua a vivere come pratica quotidiana. Magrini, al contrario, si è formato in un ambiente più decentrato e meno immerso nel mito afro-americano, ma proprio per questo ha sviluppato un’attenzione peculiare al rapporto con la musica europea, il dialogo con la tradizione colta, l’apertura verso linguaggi popolari mediterranei ed un rapporto con il silenzio che riflette, quasi simbolicamente, una geografia più rarefatta. Dal punto di vista armonico, Cohen predilige una scrittura che integra il lessico bebop e post-coltraniano con la fluidità evansiana, ossia accordi quartali che conferiscono respiro orchestrale, sostituzioni raffinate che allargano il campo tonale ed una propensione costante al cromatismo come strumento di modulazione. Magrini si muove invece verso una concezione più lirica e contemplativa, in cui la progressione accordale non sempre cerca la tensione risolutiva, ma si apre a variazioni modali ed a spazi vuoti che evocano, più che la dialettica del II-V-I, l’atmosfera della musica europea del Novecento, da Debussy a Messiaen. Se Cohen lavora per intensificazione, Magrini preferisce attenuazione e trasparenza. Sul piano stilistico, la differenza diventa ancora più netta. Cohen conserva un’energia swingante e comunicativa che gli deriva dalla frequentazione costante con la tradizione afro-americana, in la sua improvvisazione appare spesso simile ad un discorso teatrale, un dialogo vivace che invita l’ascoltatore a condividere il ritmo e la vitalità del momento. Magrini, invece, si avvicina ad un’estetica più introspettiva, talora cameristica, in cui il suo tocco leggero e il senso della dinamica lo conducono a una narrazione musicale che evoca immagini più pittoriche che teatrali, con ampi paesaggi sonori che si aprono come orizzonti vaporizzati. In definitiva, Cohen rappresenta il prosieguo e l’evoluzione di una tradizione identitaria, in cui il jazz sembra essere anzitutto memoria condivisa e rito collettivo; Magrini, pur non rinnegando il legame con l’idioma afro-americano, rivela invece una vocazione europea, più individuale e contemplativa, che si misura con il silenzio e con la luce del suono. La loro affinità sta nella ricerca di un pianoforte inteso come universo totalizzante ed olistico, capace di contenere contrappunto, colore e ritmo; la loro distanza emerge nella prospettiva culturale che li alimenta: urbana, dialogica e swingante per Cohen, lirica, diradata e mediterranea per Magrini.
L’idioma pianistico di Emmet Cohen si fonda su un lessico armonico che coniuga radici bebop, sofisticazioni post-coltraniane ed una cura per la sonorità che rivela l’eco della tradizione classica. Le sue progressioni non si limitano a reiterare i clichés delle sostituzioni tonali, ma cercano piuttosto di generare un continuum fluido in cui la funzione accordale si piega a esigenze narrative: l’accordo non appare soltanto un vincolo, ma un nodo da cui dipanare un discorso che procede per tensioni e rilassamenti calibrati con estrema lucidità. La pratica dell’accordo quartale, retaggio di McCoy Tyner, affiora spesso nelle sue fughe in solitaria, conferendo al tessuto sonoro un’opulenza verticale che trascende la tradizionale gerarchia tonica-dominante. Tuttavia, Cohen non indulge nella monumentalità statica, ma integra queste strutture con una mobilità melodica di matrice evansiana, in cui le sovrapposizioni armoniche si dissolvono in veli trasparenti e scintillanti. Ne risulta un equilibrio sottile fra verticalità e linearità, fra architettura e canto. Il trattamento delle cadenze rivela inoltre un gusto spiccato per la modulazione inattesa. Le cadenze II-V-I, colonna portante del linguaggio jazzistico, vengono spesso deviate attraverso sostituzioni tritoniche, cromatismi discendenti o slittamenti modali che creano un effetto di interruzione momentanea, quasi un rinvio del compimento atteso. In tal senso Cohen si mostra debitore della lezione di pianisti come Hank Jones o Tommy Flanagan, i quali avevano già trasformato la tradizione bop in un laboratorio di eleganza armonica e di sottile sofisticazione. La sua sensibilità ritmica, infusa di swing inossidabile, non si accontenta tuttavia di ribadire la pulsazione, tanto che frequentemente si coglie una predilezione per la poliritmia, per l’uso di figure asimmetriche che scivolano sopra la scansione regolare del tempo, creando un senso di accelerazione o di attesa. Tale concezione ritmica si annoda con l’armonia, poiché Cohen impiega dislocazioni metriche come strumenti di modulazione percettiva, ossia un voicing spostato leggermente fuori battuta che assume così la funzione di vera e propria cadenza sospesa. Il trattamento del registro rivela infine una dimensione orchestrale, in cui le note basse sono spesso scolpite con forza per stabilire radici solide, mentre la mano destra si libra in figurazioni contrappuntistiche, quasi evocando un dialogo a più voci. Non di rado il pianoforte si trasforma in un ensemble autosufficiente, dove walking bass, linee melodiche ed accordi sincopati convivono simultaneamente, proiettando una concezione del pianismo come assolutismo sonoro. Ciò che colpisce, in ultima analisi, è la capacità di Cohen di mantenere sempre vivo il rapporto tra invenzione e memoria, mentre le sue scelte armoniche, pur intrise di modernità, restano radicate nella grammatica afro-americana del blues, del gospel e del songbook, che agiscono come linfa segreta sotto la superficie. Così, il suo jazz si sviluppa come un organismo in perenne trasformazione, capace di trasmettere un senso di continuità storica pur restando permeabile alle inquietudini e alle possibilità del presente.
Tra le molte pubblicazioni che costellano il suo percorso artistico alcuni lavori assumono il valore di vere e proprie pietre miliari, non tanto per la loro funzione di tappe cronologiche quanto per la loro capacità di rivelare, di volta in volta, una diversa angolazione del suo universo espressivo. Ogni album si offre come un laboratorio sintattico, in cui la forma e gli accordi vengono riplasmati, ma anche come un’esperienza emozionale che travalica il puro ascolto, inscrivendosi in una più ampia costellazione di riferimenti artistici. Il primo, «In the Element» (2011), reca l’impronta di un esordio non acerbo ma già sorprendentemente consapevole. La sintassi musicale vi appare serrata, quasi come un flusso narrativo privo di esitazioni, in cui il pianoforte si muove con una linearità che richiama l’eleganza della prosa di uno scrittore novecentesco, capace di rendere naturale anche la complessità. A livello emozionale si coglie una tensione verso l’affermazione di sé, simile alla pennellata energica di un giovane pittore che, pur guardando ai maestri, intende imprimere sulla tela il segno inconfondibile della propria mano. Con «Infinity» (2013) la scrittura armonica si distende in ampie frasi che sembrano respirare oltre la misura, evocando quasi la spazialità di un’architettura che gioca con la luce e con le ombre. Le modulazioni inattese appaiono come archi di volta che si aprono su inedite prospettive, mentre l’ascoltatore viene condotto dentro un paesaggio sonoro che richiama l’arte filmica caratterizzata non più da una linearità narrativa, ma da una sequenza di quadri emotivi, con improvvisi cambi di inquadratura. L’elemento lirico si si lega con una sorta di cinematografia sonora, in cui la musica sembra suggerire montaggi e dissolvenze. Il successivo «Questioned Answer» (2014) segna un ulteriore passo in avanti sul piano espressivo. La costruzione sintattica assume i contorni di un dialogo serrato, come in un dramma teatrale in cui le voci dei musicisti si rincorrono e si contraddicono. Gli spazi lasciati al silenzio non sono meri intervalli, ma pause cariche di significato, equivalenti agli sguardi e ai gesti di un attore sul palcoscenico. L’emozione che ne deriva non è più quella dell’esuberanza giovanile, ma la complessità di una scrittura che accetta l’ambiguità, come un testo poetico che si nutre di chiaroscuri e di sospensioni semantiche. La «Master Legacy Series», inaugurata nel 2017, rappresenta invece un progetto corale, assimilabile a una grande opera figurativa in cui un giovane artista dipinge accanto ai maestri più venerati. Ogni volume della serie funziona come un pannello di polittico, dove la sintassi musicale si fa più ariosa, perché Cohen lascia spazio a voci autorevoli come quelle di Jimmy Cobb, Ron Carter o Benny Golson, ed in cui egli costruisce trame armoniche che fungono da cornici, valorizzando la figura al centro del quadro. Emozionalmente si percepisce una sorta di riverenza creativa, non servile ma animata da quella tensione che lega l’allievo al maestro. Tanto che il risultato somiglia ad un affresco rinascimentale in cui si sovrappongono mani diverse, ma unificate da una stessa idea di bellezza. Infine, le registrazioni nate dalla serie digitale «Live From Emmet’s Place» – che hanno successivamente trovato anche forma discografica – si impongono come messa in scena del presente. La scrittura abbandona qualsiasi pretesa di monumentalità per assumere il carattere dell’istantaneo, del gesto catturato nel suo realizzarsi. La sintassi risulta più aperta, più assorbente, simile a un quaderno di appunti che si trasforma, in tempo reale, in opera compiuta. Dal punto di vista emotivo, l’ascolto restituisce la vitalità di un happening creativo, dove jazz, immagine ed interazione con il pubblico si fondono in una dimensione performativa che richiama le arti visive contemporanee, in particolare quelle installazioni che esistono solo nella condivisione del momento. Questi cinque nuclei creativi, così diversi ed al tempo stesso legati, delineano il ritratto di un musicista che non si limita a ripercorrere i modelli della tradizione, ma li trasfigura in esperienze estetiche che si connettono con la letteratura, il teatro, la pittura ed il cinema, inscrivendo il proprio gesto pianistico in una più vasta concezione dell’arte come atto di memoria ed, al contempo, di rinnovamento.