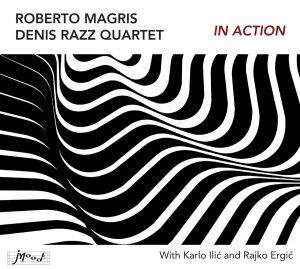È morto Chuck Mangione, colui che fece del flicorno uno strumento di seduzione di massa

Mangione non è stato semplicemente un trombettista-flicornista di successo, ma un architetto della melodia, capace di articolare un lessico musicale tanto accattivante quanto stratificato. La sua scomparsa rappresenta non già un epilogo, quanto una sospensione. L’eco delle sue architetture sonore, tra post-bop, fusion e smooth-jazz, permane e continuerà ad abitare il paesaggio sonoro globale.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Chuck Mangione ha lasciato il mondo degli uomini martedì 22 luglio: aveva 84 anni. Il suo legale ha dichiarato che l’artista si è spento nella dimora di Rochester, New York. In uno scenario musicale che sovente ha visto il jazz dividersi tra ortodossia accademica e slanci contaminanti, l’itinerario artistico del flicornista delinea una singolarità irriducibile, capace di conciliare il lirismo istintivo con la perizia formale. Mangione non ha semplicemente suonato il flicorno, ma lo ha convertito in voce interiore, in articolazione emotiva, costruendo attorno ad esso una semantica musicale propria, riconoscibile e mai manierista. La sua scrittura, lungi dall’essere epidermica, si fonda su uno studio armonico sofisticato che non cede mai all’ornamento fine a sé stesso. In ogni suo gesto compositivo si avverte una tensione dialogica tra melodia ed arrangiamento, tra intenzione e ricezione, tra il frammento e la forma. La sua parabola, incardinata inizialmente nel bebop e nutrita dal confronto con Dizzy Gillespie, si è progressivamente liberata da qualunque vincolo stilistico per abbracciare un personalissimo ethos musicale.
Lo stile di Chuck Mangione si delinea come una sintesi peculiare tra cantabilità melodica e architettura armonica di tipo jazzistico, distinguendosi per una tensione lirica che lo rende difficilmente assimilabile ai canoni del jazz più ortodosso. Tuttavia, nel panorama dei musicisti che hanno operato in territori contigui, si possono individuare alcune figure con cui stabilire un confronto dialettico. Maynard Ferguson, ad esempio, condivide con Mangione l’uso del registro acuto e una certa teatralità timbrica, ma la sua scrittura tende a una spettacolarizzazione virtuosistica che Mangione rifugge, prediligendo invece una narrazione musicale più intimista e circolare. George Benson, chitarrista e vocalist, si avvicina a Mangione per la capacità di rendere il jazz accessibile senza impoverirne la struttura, ma la sua inclinazione verso il soul e il pop lo colloca in una traiettoria più vocale e meno orchestrale. Spyro Gyra e Bob James, esponenti della fusion e dello smooth jazz, condividono con Mangione la volontà di integrare elementi melodici e ritmici provenienti da altri generi, ma la loro scrittura si orienta verso una produzione più elettronica e stratificata, mentre Mangione conserva una dimensione acustica e una predilezione per l’organicità orchestrale. Dave Grusin, infine, si avvicina forse più di tutti per la sua vocazione cinematica e la capacità di costruire paesaggi sonori evocativi, ma la sua formazione classica lo portava ad una scrittura più strutturata e meno spontanea rispetto alla fluidità narrativa di Mangione. Chuck Mangione non si colloca in una genealogia lineare, ma piuttosto in una costellazione stilistica in cui il jazz si fa veicolo di emozione, non di dimostrazione.
L’evoluzione stilistica del flicornista non si attesta come una semplice transizione tra generi, bensì come un processo di sedimentazione linguistica, in cui ogni fase della sua carriera contribuisce a definire un’identità musicale stratificata e coerente. Nato nel 1940 a Rochester, New York, Mangione si forma in un contesto permeato dal jazz più autentico: il bebop. Le sue prime esperienze con il fratello Gap nel gruppo The Jazz Brothers, e successivamente con Art Blakey nei Jazz Messengers, lo collocano nel cuore pulsante della tradizione afroamericana, dove l’urgenza espressiva e la complessità ritmica costituiscono i cardini del discorso musicale. Tuttavia, già in questa fase embrionale si avverte in Mangione una tensione verso la cantabilità, una propensione a distillare il gesto jazzistico in forme più narrative. Il flicorno, strumento che predilige al posto della tromba, diventa il veicolo di questa ricerca timbrica: più caldo, più rotondo, più adatto a una scrittura che non vuole impressionare, ma coinvolgere. Negli anni ’70, questa tensione si cristallizza in una nuova configurazione stilistica: la fusione tra jazz, pop, orchestrazione sinfonica e suggestioni latine. Nel corso degli anni, Mangione mantiene la postura: non si piega alle mode, ma le attraversa, lasciando che il proprio linguaggio si evolva per osmosi. La sua scrittura si fa sempre più orchestrale, cinematica, ma non perde mai il contatto con la radice jazzistica. In tal senso, la sua traiettoria non è lineare, ma spiraliforme, parte dal bebop, lo interiorizza, lo trasfigura, e approda a una forma musicale che è al tempo stesso personale e universale.
La parabola discografica di Chuck Mangione si articola come un continuum espressivo, in cui ogni album non rappresenta un episodio isolato, bensì la tessera di un mosaico sonoro coerente e in evoluzione. Il primo snodo significativo è «Friends And Love» (1970), registrato con la Rochester Philharmonic Orchestra, dove il flicornista distilla una sintassi musicale che già trascende il jazz convenzionale, integrando elementi sinfonici ed una narrazione orchestrale che ne anticipa la futura estetica. Tale impianto trova ulteriore sviluppo in «Land Of Make Believe» (1973), dove la dimensione favolistica non è semplice ornamento, ma struttura portante di un discorso musicale che si fa evocazione collettiva. Nel 1975, «Bellavia» segna un momento di intimità compositiva. Dedicato alla madre, l’album si distingue per una scrittura che coniuga lirismo e rigore, ottenendo il primo Grammy e consolidando la reputazione di Mangione come architetto melodico. Nello stesso anno, «Chase The Clouds Away» viene scelto per le Olimpiadi di Montreal, confermando la capacità dell’autore di tratteggiare paesaggi sonori atti al dialogo con l’immaginario pubblico. Il 1977 è l’anno della consacrazione con «Feels So Good», dove la melodia si fa protagonista assoluta, sorretta da una tessitura armonica sofisticata e da un fraseggio che conserva la minuzia jazzistica pur rinunciando alla complessità formale. L’album non rappresenta solo un successo commerciale, ma costituisce la cristallizzazione di un linguaggio che Mangione ha pazientemente elaborato, un jazz che si fa racconto e che s’insinua senza imporsi. Nel 1978, «Children Of Sanchez» diviene l’apice della sua vocazione cinematica: colonna sonora del film omonimo, l’opera si distingue per una scrittura orchestrale ambiziosa, dove jazz, bolero e sinfonismo convivono in un equilibrio dinamico. Il secondo Grammy suggella questa fase di maturità artistica, in cui flicornista italo-americano non si limita a comporre, ma costruisce ambienti sonori. A chiudere il decennio, «Fun And Games» (1979) e «An Evening Of Magic» (registrato dal vivo all’Hollywood Bowl) testimoniano la piena padronanza di un ensemble che non è semplice gruppo di accompagnamento, ma estensione del pensiero musicale dell’autore. La scrittura si fa più fluida, il timbro più rotondo e la narrazione più espansa. Questa sequenza di lavori non va letta come successione cronologica, ma come sviluppo tematico. Ogni album rappresenta una variazione su un’idea centrale, quella di un jazz che non si chiude in sé, ma si apre al mondo, alla memoria ed alla condivisione.
L’itinerario stilistico del musicista italo-americano si staglia come una traiettoria fluida, mai rigidamente incasellabile, ma costantemente nutrita da una pluralità di riferimenti che affondano le radici nel jazz postbellico. La sua formazione bebop, maturata sotto l’egida di Art Blakey nei Jazz Messengers, lo pone in dialogo diretto con una genealogia trombettistica che include figure come Clifford Brown, Freddie Hubbard, Lee Morgan e Kenny Dorham, tutti predecessori nella stessa compagine orchestrale. Tuttavia, Mangione non si limita a replicare i codici espressivi di questi maestri, ma li interiorizza, li trasfigura e li riconfigura in una sintassi personale. Il flicorno, strumento che Mangione elegge come voce primaria, lo colloca in una linea evolutiva che passa per Clark Terry, Art Farmer e, in certa misura, Chet Baker. Da Terry eredita la duttilità timbrica e la capacità di piegare il fraseggio a esigenze narrative; da Farmer la compostezza lirica e la predilezione per la forma breve; da Baker, infine, una certa malinconia melodica, mai ostentata ma sempre sottesa. Eppure, Chuck si distingue da tutti loro per una scrittura che non cerca l’introspezione solipsistica, bensì la comunicazione emotiva, la condivisione affettiva. Nel confronto con Miles Davis, Miles figura cardine del dopoguerra, Chuck si pone in posizione tangenziale; se Davis ha fatto del silenzio e della rarefazione il proprio linguaggio, Mangione opta per una burrosità melodica che non rinuncia alla chiarezza. La sua musica non è mai criptica, ma nemmeno banale; si muove in una zona intermedia, in cui il jazz si fa racconto, dove il flicorno non è solo strumento, ma medium poetico. Egli non si relaziona ai grandi flicornisti del secondo dopoguerra come epigono, ma come interlocutore; la sua voce non è derivativa, ma dialogica. In questa dialettica, il suo costrutto sonoro si attesta come una risposta: non imitazione, ma interpretazione.
Il ritiro dalle scene nel 2015 non ha reciso la sua presenza nel panorama musicale globale; al contrario, ha cementato una eredità stilistica. Quel che permane non è un insieme di brani, ma una postura musicale. Il flicornista non ha cercato l’ibridazione per moda, ma ha lasciato che le influenze agissero per osmosi, senza mai tradire la sua identità. Mangione non ha tradito il jazz, ma lo ha interrogato, lo ha dilatato e lo ha reso permeabile.